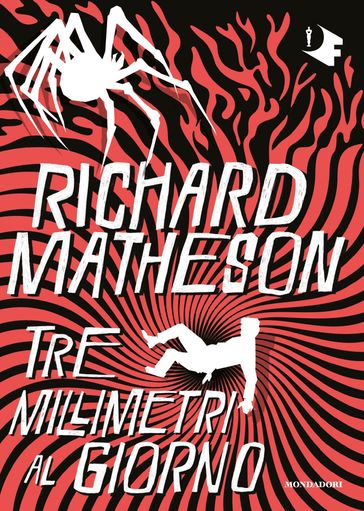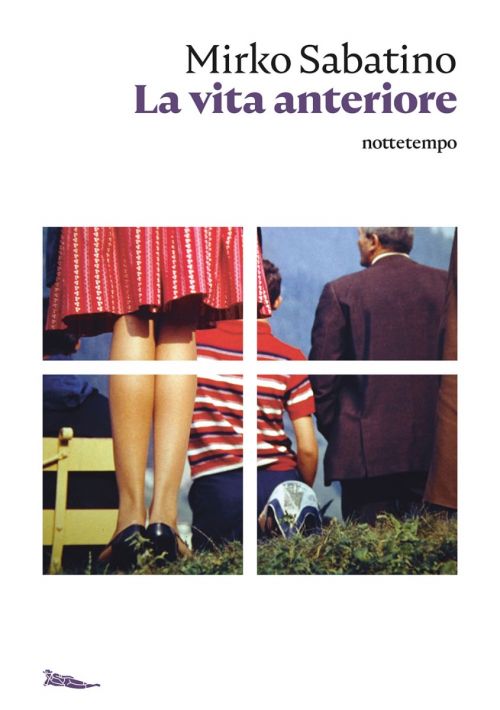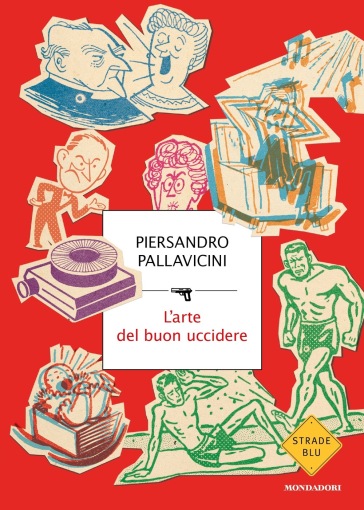Ho cominciato questo nuovo anno di letture con “Raccontare la fine del mondo”, di Marco Malvestio. Attraverso l’analisi di opere iconiche appartenenti al genere della letteratura distopica e della narrazione post-apocalittica – da pagine che hanno fatto la storia come “La spiaggia terminale” di J.G.Ballard a pellicole blockbuster quali Resident Evil – l’autore (ricercatore presso l’Università di Padova) si impegna a raccontare le modalità e le ragioni in base alle quali queste tipologie di “scritture dell’immaginario” sono state scelte, sin dal 1800, come forma prediletta per – appunto – “raccontare la fine del mondo”.
Il tema cardine intorno a cui ruota questo saggio, scorrevole e adatto anche ai neofiti della materia, è la definizione di Antropocene (“L’intera era geologica caratterizzata dall’impatto delle attività umane sull’ambiente”) e la maniera in cui questa nuova, nostra epoca – che alcuni fanno cominciare dal primo test nucleare della storia (il Trinity test, 15 luglio 1945), altri dalla Rivoluzione Industriale – è declinata, spiegata e (o) interpretata all’interno del contesto letterario e (o) cinematografico della fantascienza.
L’opera si sviluppa in cinque capitoli a tema, ciascuno dei quali affronta la fiction distopico/apocalittica in base all’argomento che essa, di volta in volta, si ritrova a trattare: il nucleare, la pandemia, il cambiamento climatico, il regno vegetale, il regno animale. Il punto di Malvestio non è tanto quello della lettura critica di un catalogo (anche perché – per stessa ammissione dell’autore – le opere e le pellicole citate sono moltissime e varie ma riferiscono quasi tutte alla sfera di influenza nord-americana, o in generale anglosassone, e mancano i rimandi alle nuove forme di fantascienza di matrice asiatica, al sistema multiforme dell’Afrofuturismo, a tutta la galassia Solarpunk) quanto quello del domandarsi per quali ragioni la nostra contemporaneità, pur nella sostanziale durevolezza (perché questo nostro tempo, malgrado la pandemia, è di fatto uno dei periodi più floridi per il genere umano), sia così interessata alle (no, diciamo meglio: ossessionata dalle) fantasie sulla catastrofe.
In questo senso è evidente il merito di “Raccontare la fine del mondo”, che è quello dell’insegnare un linguaggio. Analizzando le motivazioni che stanno alla base di opere quali “La spiaggia terminale” di J.G.Ballard o “L’esercito delle dodici scimmie” di Terry Gilliam, “Contagion” di S. Soderbergh e, ancora, la trilogia dell’ “Area X” di Jeff VanDerMeer o “Il pianeta delle scimmie” di Pierre Baulle, Malvestio introduce al lettore i concetti di “paesaggio sintetico” e di “spazi dell’assenza” e crea familiarità, per esempio, con il pensiero della “medicina positivista” e del “sogno del contenimento igienico” che, nella fantascienza, sono gli strumenti attraverso cui vene fatto emergere il sommerso tutto occidentale delle ansie sinofobiche (post)coloniali, nell’ottica di una “trasformazione” vista come contaminazione verso cui si prova un timore che è “cultural(e) e politic(o) prima che sanitari(o)”. Per non parlare dello nzumbe di origine congolese, che se nella tradizione kikongo significa “il feticco”, nella trasposizione d’oltreoceano rivela, ancora una volta, l’ansia di contaminazione da parte del “suddito coloniale schiavizzato”. Impariamo poi la categoria concettuale degli iperoggetti, all’interno della quale occorre inserire la discussione sul cambiamento climatico inteso come “entità diffusamente distribuita nello spazio e nel tempo” e infine, nei capitoli dedicati al mondo vegetale e a quello animale (inteso come “tutti eccetto l’Uomo”), ci avviciniamo alle nozioni di “agentività vegetale“, plant blindness, “anti-antropomorfismo” ed ecofobia (oltre che alle categorie letterarie del terroir, del weird e dell’eerie).
Ancora una volta, insomma, la tanto vituperata fantascienza si rivela uno tra i pochi strumenti di creazione artistica a nostra disposizione – nella parola scritta, nel fumetto, nella produzione cinematografica – utile a “immaginare un futuro possibile e attraverso questo futuro di ripensare il presente“.
Note: 1) I virgolettati sono citazioni che provengono direttamente da “Raccontare la fine del mondo”. 2) In calce al volume è presente una corposa bibliografia, che per la maggior parte delle voci è costituita da testi (saggi, pubblicazioni universitarie, articoli, long-form) stranieri mai tradotti in italiano: questo fatto la dice lunga sullo stato di queste analisi in Italia. 3) Su ADC ci siamo più volte occupati degli argomenti toccati nel saggio di Malvestio. Qui ai link sotto lascio alcune letture, ordinate per argomento. 4) Sul Twitter, a questo link, citazioni e altri approfondimenti su punti specifici di “Raccontare la fine del mondo”.
La “Trilogia dell’Area X” e “Borne” di Jeff VanderMeer, “Loop” di Simon Stalenhag per capire il new weird e lo “sci-fi vintage” – “Una passeggiata nella Zona” di Markijan Kamyš, “L’altro mondo” di Fabio Deotto, “Qualcosa là fuori” di Bruno Arpaia, “La sesta estinzione” di Elizabeth Kolbert, “La grande cecità” di Amitav Ghosh per parlare di Antropocene e cambiamento climatico – “Neghentopia” di Matteo Meschiari, “La guerra invernale nel Tibet” di Friedrich Dürrenmatt per un tuffo profondissimo nelle distopie post-apocalittiche più buie.