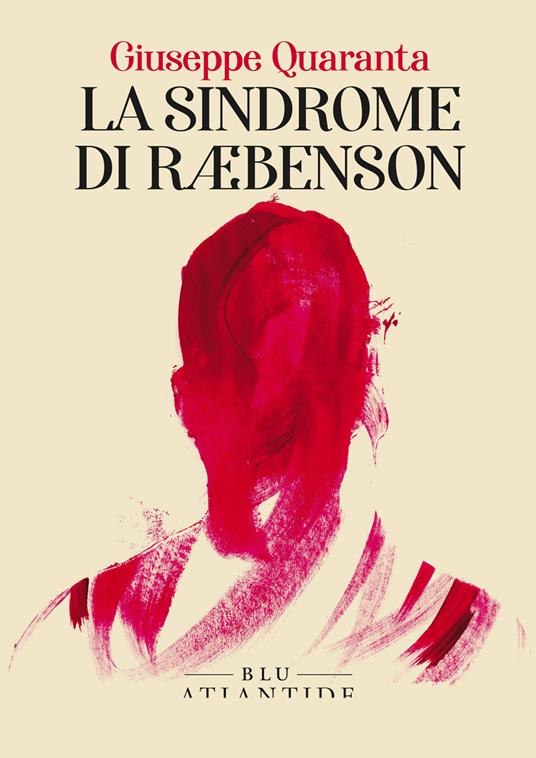
Durante una cena a casa di amici, nel chiarore lunare che rischiara le cupole della città eterna mentre l’odore dell’antizanzare si sparge in terrazza, il quarantenne psichiatra Antonio Deltito è preso da un grande spavento: all’improvviso si rende conto di non rammentare la presenza stessa del collega Berra, congedatosi in anticipo dalla tavolata perché vittima di uno sfogo di pianto dovuto al divorzio appena ratificato. La figura stazzonata del Berra, sul quale gli amici stanno spettegolando, gli si è come cancellata dal ricordo. A questa repentina amnesia seguono confusione mentale e tremori; nella notte si aggiunge l’emicrania, che necessita del pronto soccorso. Attacco di panico, sentenziano i medici. Eppure, all’atterrito Deltito sorge il sospetto – dopotutto è medico – che la questione non sia derubricabile a certe forme cliniche. La serie di analisi a cui ossessivamente comincia a sottoporsi non rivela tuttavia alcuna patologia fisica, eccetto una lieve disfunzione alla vista e uno stato generale di stress acuito dalle pratiche compulsive che Deltito mette in atto al fine di prevenire nuovi attacchi.
“Ebbe la sensazione che qualcosa di molto importante fosse successo nella sua vita senza che lui ne avesse più memoria, e che le pareti la stessero per sussurrare. (…) Ricordare qualcosa che forse non aveva mai vissuto: era mai stato formulato un paradosso più assurdo di quello?”
“Come stabilire, con quali strumenti misurare la circonferenza della propria sanità mentale?” chiede Deltito al migliore amico, compagno di studi universitari, anch’egli psichiatra di reparto – ovvero il narratore senza nome che per quasi trent’anni continuerà a indagare l’insieme di sintomi che a cadenza via via più stretta e invalidante affliggeranno il collega per tutto il resto della vita e sino alla morte, che per Deltito arriverà nella forma del suicidio. Sintomi riconducibili alla misteriosa Sindrome di Ræbenson di cui Deltito stesso, in conclamata autodiagnosi, a un certo punto dichiara di essere sicura vittima.
“Io ho sempre avuto l’impressione, in quei momenti di sconvolgimento dei sensi, che qualcosa di fortemente malvagio lo stesse attraversando, come una spada.”
La caratteristica principale di questa fantomatica affezione è la perdita del ricordo, la cui consapevolezza arriva naturalmente a cose fatte. Immaginiamo cosa significhi renderci conto di aver dimenticato intere fette della nostra vita, dall’amico d’infanzia a un importante traguardo professionale, fino alla cancellazione totale degli anni trascorsi insieme a un’amatissima fidanzata. Queste prese di coscienza portano Deltito a un progressivo sgretolamento mentale e fisico ([come se] “lo scompiglio creato da un disordine mentale fosse solo il capriccio di un bambino che mette a soqquadro una stanza, e non un terremoto che lascia crepe nei muri, pavimenti vacillanti e detriti”) sia per la violenza dirompente degli attacchi sia perché nessun piano terapeutico, dalle medicine all’elettroshock, pare in grado di risolvere la questione. Amnesia dissociativa, “brain fog, stato di assenza”, demenza precoce, epilessia, disturbo dell’attenzione con iperattività: per il Deltito vengono tirate in causa le ipotesi più pertinenti, anche sulla base di alcuni episodi giovanili riconducibili a disturbi di questo genere e per una certa allure svagata di cui Deltito non ha mai fatto mistero. L’eziologia della sindrome di fatto però resiste: pare che la malattia ne escogiti sempre una nuova per scappar via dalla propria definizione. Deltito perde il lavoro, i contatti con il mondo professionale, gli amici; anche la relazione con la compagna Delia comincia a scricchiolare: la fragilità mentale – a cui Quaranta non si permette di concedere il guilty pleasure d’una stranezza affascinante – distrugge non solo chi ne soffre ma anche chi le gravita intorno. (1)
“Tutti concepiscono a un certo punto dei loro giorni che se c’è qualcosa che rende vivi è sentire di avere dei ricordi che sono propri e di nessun altro. Pensiamo che il tempo passerà e lo farà all’infinito, ma nulla toccherà quei ricordi, niente li violerà. Noi resteremo una traccia, per quanto flebile, irripetibile.”
Durante gli attacchi, Deltito sperimenta gravissime manifestazioni dissociative, il cui carattere depersonalizzante (l’uscire da sé) diventa, nell’economia del romanzo, il filo rosso a legare i temi sui quali Quaranta intende ragionare. “La sindrome di Raebenson” infatti gioca su due livelli paralleli, lavorati separatamente sia sulla trama sia nella forma. Da una parte, si tratta di un romanzo di ricerca all’interno del quale il protagonista, il narratore senza nome, racconta della propria vita professionale spesa – fra visite, convegni, papers, conferenze tra colleghi – a documentare lo stato clinico dell’amico e nell’analisi della sindrome; dall’altra, ci troviamo di fronte a una narrazione a scatole cinesi in cui il protagonista stesso si trova a indagare una serie di flashback temporali relativi alla vita e alle memorie non solo dell’amico ma anche di tutti coloro – familiari, colleghi, amici, compagne – che della vita di Deltito hanno fatto parte.
“E io stia sicuro che, se avessi il minimo dubbio di scrivere a un fantasma, userei tutte le accortezze del caso. Le ombre che ci hanno preceduto meritano che si usi con loro il massimo rispetto.”
“La realtà aveva un frastuono che la notte e i sogni mal sopportavano.”
Al primo livello si accompagna uno stile narrativo pulito, che accarezzando con un’ironia misurata, mai fuori luogo, la forma del saggio accademico lascia trasparire competenza professionale e conoscenza del contesto, pur senza scivolare nei tecnicismi. Qui si innesta la riflessione che mi pare più significativa per Quaranta: mettere a tema l’incapacità di accedere alla piena conoscenza di un fenomeno, nel caso in cui il sistema di indagine dipenda esclusivamente da un metodo a classificazione.
L’analisi sulla sindrome di Deltito ne è esempio paradigmatico – e provocatorio: in psichiatria il tema della diagnosi, difatti, è di grande rilevanza e complessità, poiché dipende per tanta percentuale da ciò che il paziente è in grado di comunicare di sé e del suo disturbo; è concreta la possibilità che la diagnosi, pur corretta e utile a dare un nome al proprio disagio, sia di fatto insufficiente (perché limitata ai sintomi classificati) a rendere totale evidenza della dolorosa fragilità esperita da molti pazienti, come concreto il rischio che per varie motivazioni lo specialista operi pericolose inversioni di metodo.
Ad ampliare il senso di straniamento c’è il divertissement di Quaranta, che a suffragio delle tesi esposte dal narratore senza nome produce una serie di documenti bio-iconografici in una voluta e caleidoscopica mescolanza fra testi, scatti fotografici realmente esistenti ma re-interpretati (quanto è facile talvolta far dire a uno scritto unicamente quello che si vuole che dica!), scampoli di conversazioni estrapolate e manipolate.
“La realtà aveva un frastuono che la notte e i sogni mal sopportavano.”
Al secondo livello corre parallelo il viaggio di tenebra conradiana che il narratore senza nome compie all’interno della memoria dell’amico. Nutrendosi di ricchi riferimenti letterari l’autore costruisce una propria cornice di conforto formale, a metà strada fra romanzo gotico, thriller psicologico e realismo magico (suggestive le pagine sul viaggio a Taranto, per esempio) all’interno della quale il narratore senza nome si muove fisicamente alla ricerca delle origini della sindrome, per le parti che appaiono legate a questioni genetiche. In una serie sempre più articolata di matrioske, i capitoli scivolano l’uno dentro l’altro nel recupero delle testimonianze familiari, fra racconti di prima mano e aneddoti di bisnonni centenari, anomalie scheletriche, gravidanze gemellari, sparizioni improvvise, gesti anticonservativi e terrori di complotto.
“Ho avuto come la sensazione di essere un aereo che decolla e rimane a pochi metri dal suolo. Ho iniziato a immaginare i rettangoli degli appezzamenti di terreno che si vedono dagli oblò, solo che tutto rimaneva così poco distante. Non c’era decollo, non c’era volo. A un certo punto, anziché vedere attorno a me i colori brillare nel pulviscolo, o le immagini impreziosirsi di riflessi argentei, ho cominciato a percepire in maniera più densa, non so come esprimerla, l’oscurità della notte dietro le cortine. Mi è sembrato di vedere, se non suona troppo paradossale come espressione, l’oscurità, quel buio visibile (a darkness visible) di cui ha parlato Milton. E’ stato come concepire il vuoto.”
“Cos’è, dunque, mi sono chiesto, la sindrome di Ræbenson, è davvero un’epifania demoniaca? Una torre oscura e una prigione del dolore senza fine? O è, piuttosto, la maschera per celare una menzogna, un sistema per occultare una verità ai limiti del terrore?”
La sindrome di Raebenson possiede infatti altre due caratteristiche: sembra donare a chi ne soffre una longevità inconsueta – tanto da sfiorare l’immortalità (2), nonostante le terribili sofferenze fisiche che questo progressivo decadimento produce, e pare oggetto di studio di una setta di scienziati maledetti, i Ræbensonologi, che impiegano ogni sforzo nel tentativo di rintracciare e studiare chi è affetto dal male e che, per qualche oscuro motivo che qui non si può anticipare, non hanno intenzione di rendere pubblici i risultati delle ricerche. E’ Deltito stesso a rivelare all’amico – confessione che al principio viene derubricata a delirio maniacale, come ovvio – di sentirsi braccato da alcuni di questi studiosi.
Nel momento in cui il narratore senza nome riuscirà nel compito di assegnare alla sindrome di Raebenson una propria definizione, e quindi a renderla reale, inserendola all’interno del DSM-7 – aggiornata e distopica versione del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – ecco allora l’umanità si troverà nella condizione di avere a che fare con un sé inedito – forse davvero altro.
“La maschera che indossiamo è la scelta della nostra rappresentazione agli occhi del mondo. Forse la vecchiaia, con il suo corteo di corruzione, non è altro che questo lento calare del velo, dell’immagine fittizia che siamo soliti portare.”
Note a margine: (1) all’inizio del libro pensavo che la sindrome fosse un tentativo a giustificazione di certe fragilità mentali ancora insolute o dal quadro complesso – come un pensiero consolatorio; solo poi ho capito che di mezzo c’era l’idea dell’accettare l’inspiegabile, dello sforzo per arrivare a toccare certi punti che però restano comunque sospesi, per quanta fatica e struggimento si impieghino; una lotta titanica d’equilibrio fra l’assumersi l’obiettivo di tirar fuori senso, soluzioni e cure ed educarsi all’osservare, come un tirarsi indietro, prender distanza – senza abbandonare. (2) Credo che la riflessione dell’autore non sia tanto sul modo in cui parlare di salute mentale (al limite, sulla sua definizione) quanto su temi filosofici dell’identità, a cui si aggiungono i pensieri sull’invecchiamento. E’ questo in realtà secondo me il tema che forse ha più affascinato l’autore, su cui rivela tratti di una particolare tenerezza e compassione: cosa accade quando l’essere umano smette di crescere e comincia a modificarsi, una trasformazione che agli occhi appare come un ripiegamento (tornare bambino, retrocedere in sé, chiudersi al mondo tramite la sospensione dei sensi e l’immobilità fisica) ma che, in un’ipotesi suggestiva quanto misteriosa, potrebbe definirsi come la preparazione a un salto ulteriore, che esiste già ma che ancora non siamo in grado né di vedere né di spiegarci. Ps. “La sindrome di Raebenson” va letto con impegno, di notte, tutto in fila.
“L’immortalità, ma chi potrebbe mai volerla? Il solo pensiero di non morire in tutto e per tutto, corpo e anima, mi farebbe impazzire. Che io continui a essere qui mentre tutto il resto passa. È una cosa che proprio mi annienta.”