
“Ha vissuto così a lungo nascosta che ora tutto le sembra tempesta. Questo vento che scaraventa, percuote, scuote le spalle, disturba” (“Non oso dire la gioia”, Kindle, pos. 4413)
“Quando ero sola sbarravo porte e finestre, mentre i sospetti mi si incistavano in testa. Avevo nausea per le oscillazioni degli alberi nelle scariche di vento” (“La vita lontana”, pag.44)
“Esperta dei loro umori, m’illudevo di conoscerli alla perfezione” (“La vita lontana”, pag.81)
“A nessuno si augurano errori madornali come a chi non sembra farne” (“Non oso dire la gioia”, Kindle, pos.2897)
Credo poco nelle coincidenze, specie quelle che hanno a che fare con i libri – con quei libri che trasudano lo sforzo che fanno per essere trovati, essere letti. Mi domando se non ci sia un nesso, o meglio una convergenza, che si fa mia, intendo: un percorso di acque carsiche che in qualche modo io stia seguendo, inconsapevole.
Tutto è cominciato con “L’estate muore giovane“, una storia cruda di bambini venuti su troppo in fretta sotto il sole caldissimo di un passato italiano così difficile da vivere, figuriamoci da dimenticare. Ho continuato poi con “La vita lontana“, una specie di confessione intima e urticante scritta da una madre ormai matura, col cuore straziato dai rimorsi e dai rimpianti. E tanto il passaggio da Sabatino a Pecere era stato consapevole e strutturato, dettato dal desiderio di restare ancora per un po’ a camminare nel solco della narrativa contemporanea italiana (ndr: indipendente) e dalla necessità di approfondire ancora gli stessi temi (quali, di preciso, va detto che non sapevo), tanto è stato inconscio e viscerale lo scivolamento verso “Neghentopia“. Che non è altro se non la favola truce di un ragazzino che, per garantirsi la sopravvivenza – fisica e mentale – uccide i propri genitori, in tutti i modi in cui possono essere uccisi e poi dimenticati. Lì, tra le pagine finali di “Neghentopia”, ho intuito per la prima volta che quello che mi interessava davvero non era tanto il soggetto familiare quanto, nel dettaglio, il tema dell’allontanamento dei figli dal nucleo familiare e dall’influenza genitoriale.
“La maternità, lo sente, la sconfigge in ogni forma” (cit. , Kindle, pos.1142)
E poi è arrivato “Non oso dire la gioia“, a confermarmi che ciò di cui ero alla ricerca aveva a che fare con la genitorialità: il modo in cui i figli li si cresce attraverso quello sforzo di continua, incessante e quotidiana correzione di rotta che viene chiamata, pomposamente, “educazione” ma che assomiglia di più a una scalcagnata barchetta lignea in balia dell’oceano, che cerca disperatamente di tenere la rotta verso la terraferma alla mercé di maree, vortici, tempeste e finanche qualche coccodrillo uscito da chissà dove.
**
“Perché la violenza è un contagio. E la famiglia ha maglie larghissime, così che l’odio, e l’amore, e la viltà, e ogni emozione che germoglia nella madre, e poi nel padre, passa ai figli, e vi si insedia senza antidoto né soluzione” (cit. , Kindle, pos.1024)
Si dice spesso che per un romanziere la seconda prova sia la più difficile. Non so se Laura Imai Messina l’abbia percepito così, questo suo secondo romanzo, o se abbia prevalso il senso della creazione in sé dell’opera, un parto intellettuale che ha accompagnato la fisicità della gravidanza e della maternità. Ho la presunzione di pensare che sia stato un po’ così – ma solo per via del fatto che, nel caso, mi troverei a condividerne l’esperienza. Il voler fissare per iscritto non una storia qualsiasi ma come fosse un pezzo della propria, come un diario, quasi che la scrittura, cesellata e limata negli spigoli e per questo fattasi così tagliente, sia il modo attraverso cui rendere espliciti i timori e le inquietudini che riempiono le future madri durante il periodo dell’attesa (Sarà sano? Sarò ancora bella dopo il parto? Sarò in grado di occuparmene? Perché ho desiderato tanto questo figlio, eppure sento quasi il bisogno di tornare indietro e riavvolgere il nastro? Crescerà bene? E se qualcosa non andrà come deve, durante il parto? Stanotte ho sognato di essere al mare, sulla spiaggia. Era bel tempo, ma poi all’improvviso si è sollevata una grande onda di acqua, una massa gigantesca di materia densa e trasparente, che voleva ingoiarmi).
“Nutriva il costante timore che Marcel si ferisse, che qualcuno lo rapisse, che un incidente banale lo uccidesse. Era dalla vita che lo voleva tenere lontano, quella cosa da cui lei stessa non conosceva protezione. Quanto poco doveva esserselo goduta da bambino, quanto affanno doveva aver provato fino a che non s’era fatto adulto e indipendente” (cit. , Kindle, pos.3413)
Attraverso le storie di quattro personaggi a cavallo dei trent’anni – storie che si intersecano l’una con l’altra in un modo di cui qui non si può dire – l’autrice affronta il tema dell’essere genitore, che in sé ne contiene molti altri, dalla scelta di diventarlo sino a cosa capita quando invece questa libertà di preferenza è preclusa, in un modo o nell’altro. Passando per tutti i “rimpiantivi” che inevitabilmente ogni sistema educativo porta con sé.
“Piange per quanto è perduto, per la nostalgia di quando la responsabilità era sempre di altri, per la poca fiducia che sta concedendo all’uomo di cui è innamorata, per il pericolo che ogni inganno porta con sé” (cit. , Kindle, pos.2865)
Credo che il nucleo fondamentale di “Non oso dire la gioia” sia proprio il desiderio dell’autrice di “rimettere tutto a posto“; di figurarsi un mondo in cui, nonostante tutto, si possa ricominciare e all’interno del quale ogni errore sia se non rimediabile, almeno accettabile. D’altra parte, il “bambino immaginato” non è cosa nuova (Silvia Vegetti Finzi lo chiama “il bambino della notte“, in un testo diventato ormai celebre) e parte del tempo della gravidanza – quell’ultima parte di “attesa” spesso tanto vituperata (Perché non resti al lavoro anche l’ottavo mese? Tanto l’alternativa è stare in casa a non far niente) – ho sempre avuto la convinzione che fosse in qualche modo biologicamente destinata a far germogliare non solo il feto ma anche l’intelletto.
**
“Se uno può decidere cosa far ereditare al proprio figlio, la scelta è scontata. Le cose negative è sempre meglio tenersele per sé, anche a costo di mentire” (cit. , Kindle, pos.2186)
“Non oso dire la gioia” forse fa anche di più. Perché se l’autrice riesce da una parte nell’intento di rendere esplicita la dimensione genitoriale in tutte le sue forme e le sue paure, dal pre-nascita sino alla vecchiezza del genitore, dall’altra è in grado di creare una struttura narrativa e soprattutto stilistica che garantisce l’assoluta imparzialità di giudizio, attraverso la guida di un punto di vista esterno, collocato sempre “altrove“. E’ questo, più che il proporre personaggi e situazioni culturalmente ibride date dalla dislocazione (e dicotomia) geografica occidente / oriente, a rendere l’autrice una scrittrice che appartiene a due mondi. E non è un caso che il senso del nonostante tutto di Pecere (la vita lontana in qualche modo, nella sua propria forma, diviene salvifica, nonostante il passato) si trovi a un certo punto a convergere e fondersi con quello di Laura Imai Messina (la vita futura in qualche modo, nella sua propria forma, andrà avanti, nonostante le cicatrici che si porterà inevitabilmente dietro): entrambi, guarda la coincidenza, hanno l’occhio rivolto lontano, là in fondo, in mezzo all’oceano. E ci vedono bene: forse davvero hanno tracciato la rotta per evitare le onde più grosse, i mostri marini e i coccodrilli.
“Senza saperlo si trovano a pensare la stessa cosa, ovvero che famiglia è forse allora la mancanza di confini, il non essere più in grado di stabilire con chiarezza l’inizio e la fine delle cose in una casa. Tutto piomba nel caos, nell’eliminazione sistematica della reciproca distanza, di quella sola cosa che sa separare e nella stessa misura avvicinare le persone. A star troppo vicini ci si fa male, a star lontani si soffre” (cit. , Kindle, pos.3765)
Buona lettura 🙂
ps. la questione “genitorialità”, ahimè per voi non è finita qui. Arriverà presto un nuovo (e forse conclusivo – almeno per il momento) capitolo.
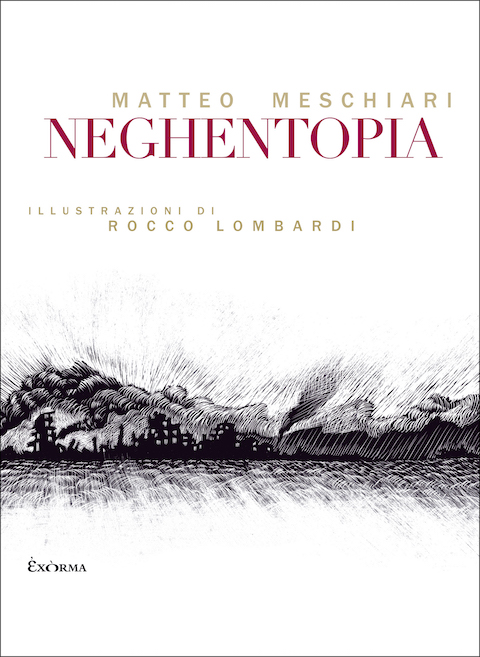
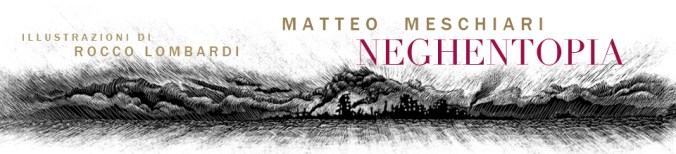










 Prolifico giornalista, famoso scrittore, brillante aforista, attento critico letterario e saggista, anglicano convertito al Cattolicesimo, G.K. Chesterton (Londra 1874, Beaconsfield 1936) – sì, proprio il creatore di Padre Brown – negli anni giovanili era considerato, pensate, di intelligenza scarsa; non finì mai le scuole, non riuscì a prendere la laurea: eppure ne ricevette diverse honoris causae fino a essere candidato al Nobel per la letteratura, nel 1934. Potete leggere la sua biografia completa
Prolifico giornalista, famoso scrittore, brillante aforista, attento critico letterario e saggista, anglicano convertito al Cattolicesimo, G.K. Chesterton (Londra 1874, Beaconsfield 1936) – sì, proprio il creatore di Padre Brown – negli anni giovanili era considerato, pensate, di intelligenza scarsa; non finì mai le scuole, non riuscì a prendere la laurea: eppure ne ricevette diverse honoris causae fino a essere candidato al Nobel per la letteratura, nel 1934. Potete leggere la sua biografia completa  E così, Charlotte Bronte, “se la si interpreta a partire dai suoi istinti, fu altrettanto grande (ndr: di George Eliot); Jane Austen fu più grande. (…) Lei seppe non perdere la testa, mentre tutte le altre donne venute dopo hanno cercato di ritrovare il cervello. Jane Austen era capace di descrivere un uomo con freddezza; cosa di cui né George Eliot né Charlotte Bronte furono capaci” (p88-89)
E così, Charlotte Bronte, “se la si interpreta a partire dai suoi istinti, fu altrettanto grande (ndr: di George Eliot); Jane Austen fu più grande. (…) Lei seppe non perdere la testa, mentre tutte le altre donne venute dopo hanno cercato di ritrovare il cervello. Jane Austen era capace di descrivere un uomo con freddezza; cosa di cui né George Eliot né Charlotte Bronte furono capaci” (p88-89)

 Anthony Trollope, ” un realista lucido e assai abile, rappresenta invece un altro aspetto dello spirito di benessere vittoriano: la mancanza di fretta, il gusto per il dettaglio, soprattutto quello domestico; il gusto di seguire i personaggi e i loro familiari di libro in libro e di generazione in generazione” (p110).
Anthony Trollope, ” un realista lucido e assai abile, rappresenta invece un altro aspetto dello spirito di benessere vittoriano: la mancanza di fretta, il gusto per il dettaglio, soprattutto quello domestico; il gusto di seguire i personaggi e i loro familiari di libro in libro e di generazione in generazione” (p110). “E’ caratteristico della sua opera (e della rivolta contro la rispettabilità vittoriana in generale) che la sua storia più sensazionale e a tinte più forti sia anche quella che contiene la sua verità più amara e profonda: Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr Hyde è un duplice trionfo: combina le emozioni esteriori tipiche di Conan Doyle con quelle interiori tipiche di Henry James. Purtroppo, è altrettanto caratteristico del periodo vittoriano che quasi tutti gli inglesi abbiano apprezzato l’aneddoto, ma che quasi nessuno abbia colto la burla” (p199).
“E’ caratteristico della sua opera (e della rivolta contro la rispettabilità vittoriana in generale) che la sua storia più sensazionale e a tinte più forti sia anche quella che contiene la sua verità più amara e profonda: Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr Hyde è un duplice trionfo: combina le emozioni esteriori tipiche di Conan Doyle con quelle interiori tipiche di Henry James. Purtroppo, è altrettanto caratteristico del periodo vittoriano che quasi tutti gli inglesi abbiano apprezzato l’aneddoto, ma che quasi nessuno abbia colto la burla” (p199).



