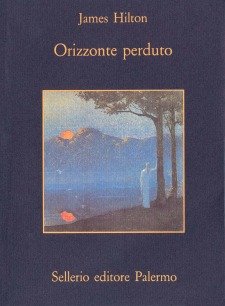Leggere “Pimpernel” significa recuperar contezza di quanto significhi l’avere passione per un romanziere. Succede a Paolo Maurensig con Henry James – il più importante prosatore nordamericano di fine Ottocento, ça va sans dire – riguardo al quale l’autore si prende perfino la libertà della fanfiction, dopo averlo a quanto pare completamente eviscerato attraverso uno studio pluriennale matto e disperatissimo.
Ebbene sì, questo racconto lungo alla maniera maurensighiana è un fittissimo gioco di rimandi, riferimenti, citazioni che prende avvio proprio da un what if; un gioco di scatole cinesi di racconto-nel-racconto che immerge le radici, per struttura, non solo nel profondo della nostra letteratura ma anche nella tradizione orale, antichissima, delle storie-nelle-storie. Si comincia con l’impasse di uno scrittore non altrimenti identificato che, imprigionato nel vicolo cieco di una creatività bloccata e capricciosa, viene a scoprire attraverso il passaparola di fumose conoscenze le pagine slabbrate di un taccuino appartenuto, come sembra, niente meno che a Henry James (di cui lo scrittore, “piccato di fare il regista”, s’era impegnato a trascrivere “Il carteggio Aspern” in forma di sceneggiatura, senza però riuscire né a venderla né a trasformarla in pellicola).
Il fuoco della curiosità brucia lo scrittore che, spinto dalla passione nei confronti del romanziere e non del tutto insensibile alla fama che il ritrovamento di un inedito potrebbe riservare, si dedica anima e corpo alla ricostruzione del testo (recuperato in una misteriosa libreria antiquaria veneziana), operazione per la quale impiegherà anni. Ciò che lo scrittore presenta in “Pimpernel” è proprio “Pimpernel” stesso: il racconto inedito che Henry James inviò in lettura a Constance Woolson, la scrittrice amica del romanziere, morta suicida a Venezia nel gennaio del 1894. Cosa conteneva la scatola di biscuits au chocolat Delacre, all’interno della quale giacevano quelle carte sbiadite dall’acqua? Furono quelle parole a determinare il suicidio della donna che, come tutti sapevano, serbava per il romanziere americano sentimenti fortissimi, al limite dell’ossessivo?
“Non aveva più di vent’anni, di carnagione chiara, già arrossata dal sole, gli occhi di un azzurro limpido e una mascherina di efelidi sulle guance, teneva stretto sotto il braccio un ombrellino di seta, proteggendosi dal vento con una sciarpa di tutte bianco, allacciata alla cupola di un ampio cappello di paglia che non voleva saperne di stare al suo posto” (pag31-32)
Miss Annelien Bruins – la protagonista femminile di “Pimpernel” è una delle iconografie fin de siècle più belle che ho mai incontrato. Chiarissima, morbida nelle sue crinoline mosse dalla brezza primaverile, negli occhi un fondo di mistero insondabile che rimanda al più terribile incubo gotico. La storia d’amore tra questa giovane donna dal viso spruzzato di lentiggini, che lotta contro le convenzioni in nome di un femminismo e di una auto-determinazione appena emergente, e il trentenne americano Paul Temple, scrittore di successo, è breve, intensissima e votata alla disgrazia – come si capisce fin dalle prime pagine.
Il sole della primavera veneziana con i suoi toni accesi, luminosi e implacabili mette a nudo per contrasto le parti più buie delle calli – e dell’animo umano, tra il brulicare dei mendicanti e la decadenza di un grand tour ormai al crepuscolo, spingendo lettore e personaggi alla riflessione su questioni di profondità universale come il significato dell’arte (fruizione d’élite oppure oggetto mainstream?), il soggettivo intrinseco nella Bellezza, l’idea del divino e – al rovescio – quella del maligno, un incessante rimbalzo di opposti complementari tipici dell’arte di Henry James nelle cui opere spesso si avvicendano temi riguardanti la contrapposizione tra epoche, geografie e società.
L’omaggio di Maurensig a Henry James si riversa non solo nel contenuto ma anche nella forma: una maniera descrittiva che si avvale di frasi lunghe e di una ricca – ma mai ridondante – aggettivazione; un’abilità di Maurensig, quest’ultima, che a me piace particolarmente: la capacità che possiede di scegliere, per qualsiasi aggettivo, la forma sinonimica meno banale o più ricercata, sapendone tuttavia trattenere la desiderata sfumatura.
Nota, già condivisa sul Twitter: le amiche che con precisione chirurgica, millimetrica, regalandomi libri riescono a farmi felice fino alla commozione, ecco, quelle amiche sono per me un dono. Grazie. ❤