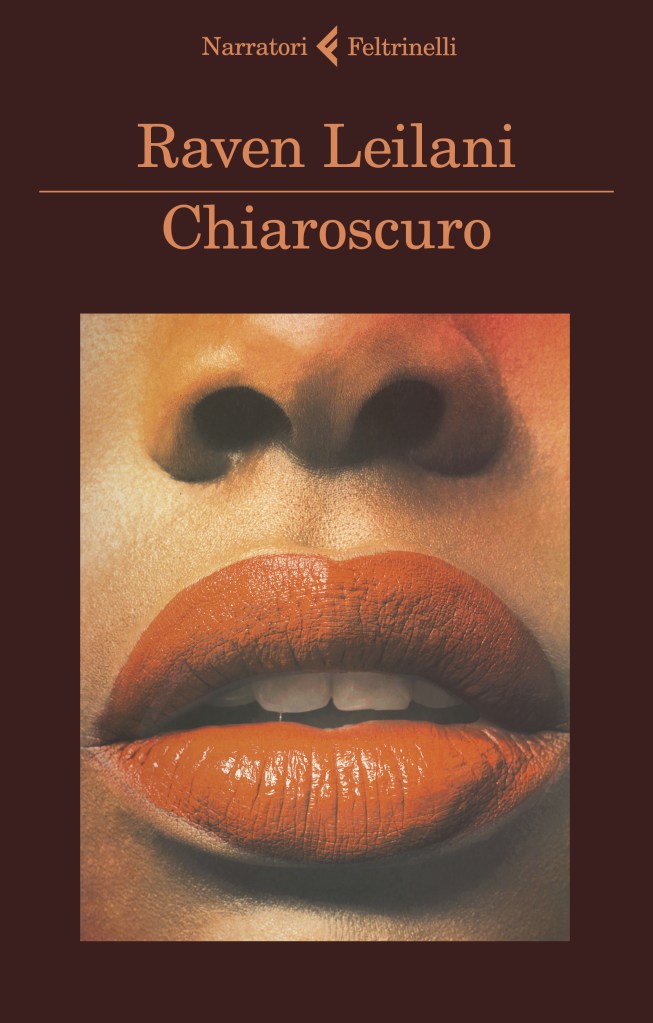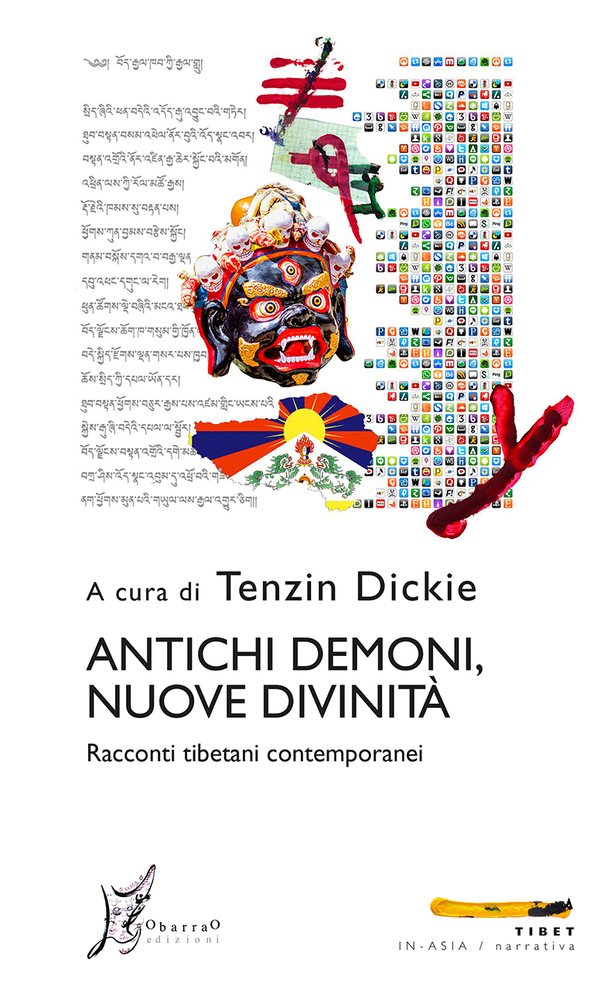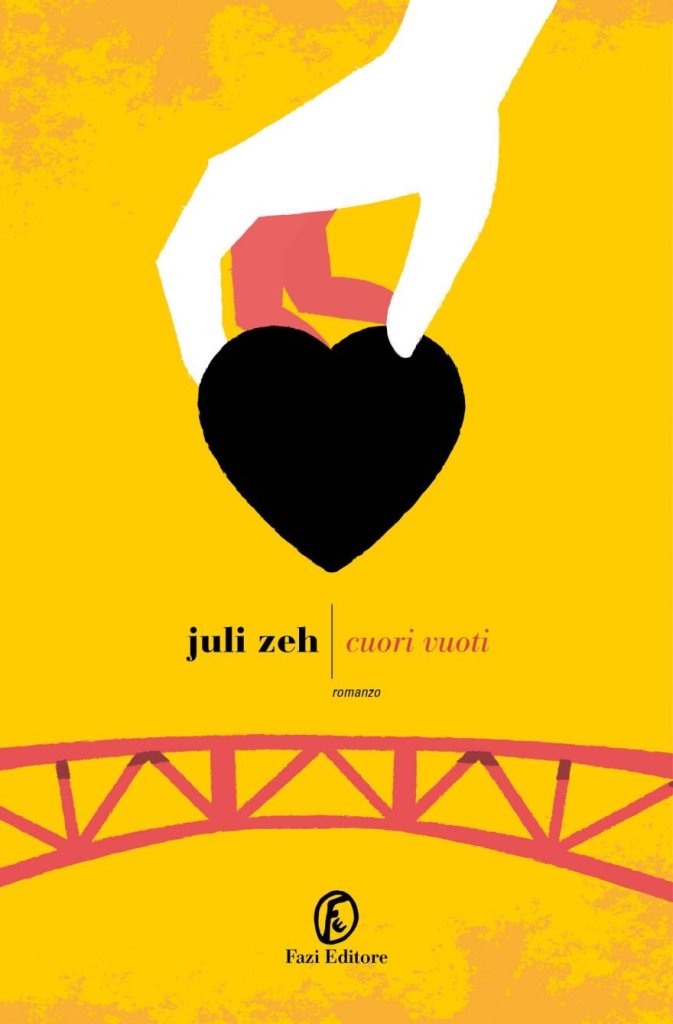
“Chiunque abbia bisogno di un attentatore non è più costretto a rivolgersi a dei fanatici jihadisti con disturbo narcisistico, o a dei bambinoni con il feticismo per le armi né a degli psicopatici che odiano gli stranieri e le donne. Loro invece gli consegnano un martire formato professionalmente, rigorosamente selezionato, che desidera morire per un fine alto. Il Ponte ha messo fine all’anarchismo terrorista. Ci sono accordi fissi e un numero controllato di vittime. Con il tempo il settore ha aderito a questo modello di business.”
Quanto mi piace Juli Zeh. L’ho scoperta l’anno scorso in biblioteca, con “Turbine“, e poi ho camminato a ritroso per recuperare tutto il resto. Zeh è laureata in giurisprudenza e specializzata in diritto internazionale; viene da una famiglia in cui di politica si parlava a colazione (suo padre è Wolfgang Zeh, giurista ed ex direttore del Bunderstag) e da più di vent’anni scrive romanzi pluripremiati. E’ mia coetanea (Bonn, 1974) e forse è stato proprio il punto dell’età a incuriosirmi perché questa scrittrice possiede uno sguardo in cui mi riconosco: un piede di qui, nel lontano secolo scorso, e uno di là, in un futuro che di fatto mi appartiene poco e che osservo – come lei – mescolando la famelica curiosità allo scetticismo proprio dei diffidenti.
A me pare che “Cuori vuoti” possa essere ben identificato come una summa degli argomenti che a Juli Zeh interessano da sempre; se qualcuno mi chiedesse da quale titolo cominciare a leggerla penso che consiglierei di partire proprio da qui. Da questo futuro di pochi anni avanti a noi – il 2025 – in una Germania distopica in cui il BBB (“Besorgte Bürger Bewegung” ovvero “Movimento dei Cittadini Preoccupati”), spodestata la cancelliera Merkel, ha preso il potere e lavora alacremente per ripristinare un certo tipo di ordine novecentesco di non nuova fattura che ha come effetto collaterale – guarda caso – il progressivo allontanamento dei cittadini dalla vita politica, il pugno di ferro nei riguardi delle migrazioni, la creazione di un’eccellenza d’élite la cui costruzione parte sin dalla scuola. Nel resto del mondo, intanto, Trump ha vinto le elezioni, Putin è all’apice del potere e l’Europa si sta disgregando sotto il peso dell’inefficienza.
“(…) la folla che gridava «La Merkel se ne deve andare!» riunita davanti alla Cancelleria, il momento in cui Angela, dopo l’annuncio ufficiale dei risultati, era apparsa davanti alle telecamere e si era assunta la responsabilità dello straordinario risultato della BBB. Aveva unito le mani a forma di rombo e aveva dichiarato, con il suo tono pacato e leggermente bleso, che quei risultati elettorali non erano solo una catastrofe per la Germania, ma anche il fallimento della sua carriera personale. Tra i vari «Buuuh» di alcuni giornalisti presenti, alla fine la ex cancelliera era crollata. Una lacrima le era scivolata lungo il viso, mentre, cercando di evitare interruzioni, urlava al microfono: «Auguro al nostro paese, auguro a noi tutti, buona fortuna!». Poi aveva abbandonato il podio, con la testa china, e improvvisamente era apparsa terribilmente invecchiata.”
Il punto di forza di Juli Zeh non sta solo nella profonda conoscenza del sistema politico tedesco – la qual cosa le permette di modellare intrecci di genere legal thriller molto dettagliati – ma anche nella capacità di penetrare la scena privata: quel contesto intimo di rapporti familiari, in specie genitoriali, che aggiungono alla trama i tratti caratteristici del giallo psicologico. In questo modo, mettendo in scena, qui in “Cuori vuoti”, l’agiata realtà familiare di Britta – una manager sofisticata, sposata con un imprenditore e madre di una bambina di sette anni – Zeh riesce a coprire tutti gli argomenti che le sono cari: dalla spy story fino alle questioni filosofiche sollevate proprio dal thriller psicologico, ad esempio l’interrogarsi su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, o sul sistema valoriale delle nuove generazioni, oppure ancora sull’etica del lavoro; senza dimenticare la riflessione, importantissima, sui pericoli delle derive democratiche.
“In verità la teoria tratta soprattutto del fatto che il capitalismo del corpo sia, in fin dei conti, un comunismo dell’anima.”
In questo tempo pandemico si parla spesso di distopia e il termine, ormai, rischia di essere abusato: in verità, non tutto ciò che è rappresentazione di un futuro alternativo merita automaticamente la definizione di distopico e non è nemmeno detto che una ricostruzione post-apocalittica, per dire, sia sufficiente a determinare di per sé la distopicità di un racconto. L’invenzione distopica esiste soltanto nel momento in cui, paradossalmente, lo sfondo si ritira perché a tener banco non siano tanto le descrizioni cataclismiche di manufatti umani sprofondati nelle sabbie quanto i punti di critica al sistema socio-economico che al mondo distopico ha portato e che in esso è reso fattuale: la crisi dell’attivismo politico individuale e della responsabilità civile collettiva, per esempio, o l’espansione delle correnti di pensiero esistenzialista, o ancora le conseguenze politico-sociali dei regimi fondati sul capitalismo. Juli Zeh di tutto questo ha gran contezza tanto che, con arguzia sottilissima, sceglie per “Cuori vuoti” un’ambientazione green che accosta – attraverso un sistema descrittivo molto vicino al Nature writing – le linee di pensiero del vivere suburbano e della prossimità territoriale all’idea di una città sostenibile e smart – ad uso e consumo di chi ha possibilità e diritto a goderne.
“Un paio di anni fa hanno fatto un’inchiesta», racconta Britta, «hanno chiesto alle persone cosa farebbero se dovessero scegliere tra il diritto di voto e la lavatrice».
«Cosa ne è venuto fuori?».
«Il sessantasette per cento ha scelto la lavatrice. Quindici per cento gli indecisi».”
La Germania di Juli Zeh è un mondo allo specchio all’interno del quale nessuno è chi crede di essere e nulla è come sembra; in un continuo gioco di rimandi, echi e memorie, pagina dopo pagina capita anche di dimenticarsi il fatto ovvio della distopia e proprio questo punto, l’esistere di quell’attimo – del passaggio tra la dimenticanza e il rinnovamento della presa di coscienza – rende il distopico di Juli Zeh così preciso, perfetto e terrificante.
Ringrazio Fazi Editore per l’invio dell’ebook.