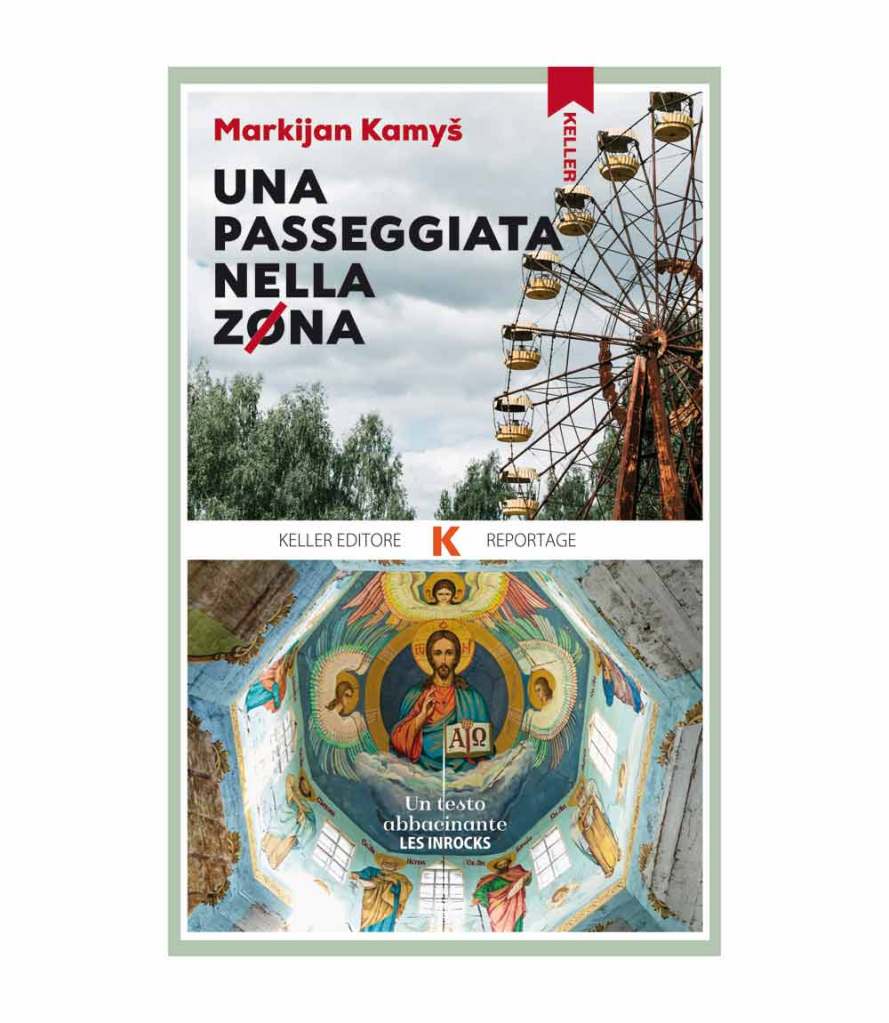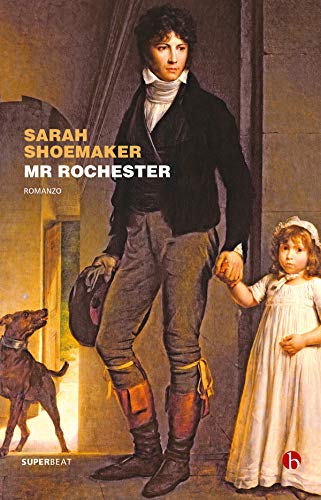“Il tempo da soli con una neonata può essere orrendo. Non passa, è pesante, è pericoloso. Ti fa guardare in faccia chi sei, e alla fine sei qualcuno di solo e inesperto”
Non sono mai stata in grado di apprezzare per intero i racconti auto-ironici sulle disavventure della maternità. Un mio limite, suppongo.
Comunque c’era questo trend alcuni anni fa e va detto, l’operazione ha funzionato: per la prima volta infatti, grazie ad alcune ardite outsider (blogger, giornaliste, madri comuni con un certo talento per la scrittura e l’utilizzo dell’internet) sono venuti alla luce in maniera colorata, divertente e spiritosa tutti quei piccoli e grandi dolori della giovane puerpera che sino a quel momento erano stati come lasciati da parte – dimenticati, ignorati – intenzionalmente o meno. Dimenticati o ignorati senza secondi fini, perché tanto è stato sempre stato così quindi è inutile lamentarsi, dimenticati o ignorati con deliberata pianificazione, perché se non canti inni di gioia ogni volta che una ragade ti spacca un capezzolo, non sei una madre degna.
Quindi ben venga che qualcuno abbia trovato il modo di far sapere al mondo che sì, far figli è proprio una bella storia ma ci sono quei due o tre punti che varrebbe la pena mettere in chiaro. Perché il bodyshaming in gravidanza esiste; esiste pure la competizione tra puerpere, o l’assenza dei padri – sì, anche quella esiste; e da ultimo, udite udite, esiste anche la depressione post-parto e di depressione post-parto soffrono milioni di donne nel mondo, e di depressione post-parto a volte ci si rimane anche secche, o si fa ancora peggio. Ma spesso parlare di questi temi significa(va) fare come nella famosa storiella dei vestiti nuovi dell’imperatore: tutti sapevano che il sovrano era nudo ma nessuno voleva prendersi né la briga né il fardello di farglielo notare.
Detto ciò, per quanto mi riguarda (SPOILER: questo è un post un po’ più intimo del solito, abbiate pietà) sdrammatizzare va bene perché se no sai che pesantezza, ma la verità è che io sono sempre stata più incline al dramma che alla commedia. Sicché mi trovo a fare le tre di notte per finire “Cattiva“: perché Rossella Milone racconta, senza tanto girarci in giro, l’abisso profondo, e ne parla come piace a me: ci si affaccia, lo guarda bene e poi, dando voce a tutte quelle come me, noi che non siamo brave con le parole, lo descrive nella sua crudezza.
“Quando mia figlia piange io so di essere un animale e corro. Non è amore, è corsa; un’impellenza da cui mi devo salvare. Quando mia figlia piange io la devo salvare. A me a salvare qualcuno non me lo ha insegnato nessuno”
In una manciata di pagine, con un linguaggio secco e brutale intessuto di dialetto e materia, la Milone ci parla di Emilia, giovane donna napoletana, e delle settimane successive alla nascita della prima figlia. Sono giornate intensissime, lunghe eppure brevi, in cui l’orologio pare aver cambiato il suo giro consueto, rifiutandosi di obbedire alle leggi dell’alternanza giorno e notte che per tanti anni avevano scandito le nostre attività dentro e fuori casa. Giornate sospese, fatte di riflessioni e spaventi, paure e pensieri, fatica fisica e sfinimenti mentali – perché si sa, l’estrema gioia e l’estremo dolore prostrano allo stesso modo; fatte di suprema, fisica aderenza, e nello stesso tempo di enorme solitudine.
“Se soffri tu soffro anch’io, mamma, e questa fu la prima libertà che persi: la libertà di stare male, ché se il mio cuore perdeva un battito lei ne perdeva due”
“Non ha bisogno di me, ha bisogno di ciò che le so dare. E io non so cosa le so dare, se non il latte”
Sono giornate che trascorrono alla ricerca continua di punti di riferimento vecchi e nuovi: dai nonni che non è detto siano di aiuto anche se presenti – come ben sottolinea l’autrice, al marito che comunque ritorna subito alla propria routine (la quale, va detto, mica è mai cambiata più di tanto), alla vicina di casa che pare sapere sempre tutto, alle amiche che però si dileguano, al lavoro che chissà se si potrà riprendere, alla pediatra che parlare con un divano darebbe più soddisfazione.
“Mentre lei succhia io posso ritornare a essere viva, non per la vita che passo a lei, no: per la vita che devo passare a me. Perché magari un paio di pagine di un libro pescato dalla libreria riesco a leggermele, venti minuti di un film preso a caso in Tv riesco a vedermeli, starmene coi piedi abbandonati sul divano, mentre con una mano faccio le parole crociate, riesco a stare”
“Cattiva” è intessuto di parole vere. E se da una parte mi viene da concordare con il famoso assunto, che chi non ci è passato non può capire, dall’altra permetto a me stessa di pensare che questo libro andrebbe fatto leggere in tutte le medie superiori della nostra penisola – ma d’obbligo però, di programma. In primo luogo, perché è un testo non giudicante e molto oggettivo nei fatti – fatti che, certo, non accadono sempre ma che per il solo fatto che potrebbero accadere e talvolta accadono dovrebbero metterci tutti sul chi va là. In secondo luogo, perché secondo me aiuta nel contestualizzare le esperienze.
Mi spiego (SPOILER II, vedi sopra). Mi sono imbattuta in questi giorni in una polemica molto social che riguardava una delle più famose influencer italiane la quale, divenuta mamma da pochi mesi, è diventata oggetto di feroci critiche per la sua vita poco dedita alla prole – a quanto pare. Quel che mi ha stupito non è tanto l’esperienza della singola persona che comunque, date le contingenze, non credo debba venire presa a misura, quanto la violenza verbale dei commenti pubblicati on line e il messaggio complessivo che viene fuori da questa storia. In primis, un relativismo etico con cui, forse per l’età, faccio fatica a interagire (il corpo è mio e decido io, se ti dà fastidio vai da un’altra parte), seguito a stretto giro dall’aggressività di talune risposte (stai zitta e torna in cucina a fare il sugo in ciabatte e mollettone) a cui si affianca, di contro, la strenua difesa di un ben preciso concetto di maternità autoreferenziata che è quella che poi porta alla competizione tra mamme, intessuta di bugie nella mitizzazione di aspettative francamente inaccessibili.
“Ci sono certe cose che nessuno vuole sforzarsi di comprendere, e in quel momento in cui non vuoi comprendere l’odio si trasforma, non più incandescente e vivo e fertile come l’odio è, ma una cosa morta e inutile, e questa cosa è il disprezzo”
La questione che mi stupisce è, di fatto, la difficoltà nell’affrontare una delle emozioni più potenti e distruttive che esistano: la paura. Da una parte c’è infatti il terrore (esemplificato dall’immagine della donna sciatta, chiusa in cucina a preparare la pietanza per marito e figli) di trovarsi ingabbiate nel piccolo mondo asfittico che in qualche modo fa parte dell’esperienza di chi a oggi è in età riproduttiva. La maggior parte di noi ha per madri donne che dopo il parto hanno rinunciato al lavoro e ai divertimenti, perché figlie a loro volta di un’Italia del passato; madri che a quanto pare sono state capaci di trasmettere alle proprie figlie, ovvero a noi, soltanto la pars destruens della storia, cioè le indubbie fatiche dell’accudimento genitoriale, tralasciando il significato profondo e non scontato della parola “sacrificio” (con tutte le gioie, il senso di liberazione e i cambi di prospettiva che esso porta con sé). Ne viene fuori una donna aggressiva, che in nome di una presunta “libertà” da conquistare e mantenere, accetta acriticamente qualsiasi modello sociale altro – basta che sia diverso da quello di cui ha esperienza, che rifiuta in toto (ma attenzione, rifiutare un costrutto sociale non vuol dire liberarsi automaticamente dal senso di colpa, anzi). Dall’altra parte c’è l’angoscia – che si trasforma spesso in terrorismo psicologico (il tuo CUCCIOLO ne soffrirà, chiamerà ‘mamma’ la tata) – di chi, facendo proprio quel valore rifiutato dalla maggioranza (il senso dell’accudimento esclusivo, il tempo della mutazione, la rinuncia a ciò che era prima) si scaglia contro tutti coloro che, in un modo o nell’altro, cercano di mostrare i limiti intrinseci a questa interpretazione e di dare legittimità a un altro punto di vista. In tutto questo, il buon senso va a farsi benedire e, last but not least, le figure maschili scompaiono: impaurite si fanno da parte, ridotte al silenzio.
Emilia sta nel mezzo. Questa bambina, così desiderata e voluta, è altra cosa dalla figlia immaginata: non dorme, piange sempre, è una bambina ad alto contatto, non dà tregua. Il marito Vincenzo pur attento e premuroso è di fatto distante dalla quotidianità del puerperio. I genitori di Emilia non sono d’aiuto, incastrati tra supposizioni e pregiudizi (e la convinzione che Emilia farebbe bene a togliersi dalla testa l’idea di tornare al lavoro – questa è una delle pagine più belle, più struggenti).
Non funziona nemmeno il servizio pubblico: la culla in camera è una favola che ci si racconta in tante, ma a cui non crede quasi nessuna (“E poi dovevo tenermi le forze per quelle notti con la neonata, lì in ospedale, che in quell’ospedale c’era il rooming-in, come se in inglese suonasse meno faticoso: i bambini li devi accudire da subito, diventi madre da un’ora all’altra, e quando ti accorgi che semplicemente non ne sei in grado, non sai cambiare manco un pannolino, altro che evoluzione, vorresti tanto stringere la mano a Darwin e dirgli Ma vaffanculo”). I pediatri, sbrigativi e poco empatici.
La soluzione a cui arriva Emilia, perché ci arriva, non ve la racconterò: non è una pillola miracolosa, è qualcosa che si trova alla fine di un cammino, e in questo caso il cammino è il processo di fruizione del testo. Una lettura che spesso non scorre né facile né piacevole, perché o non c’è mai stata immedesimazione (figurarsi, che esagerazione), o il testo risulta fin troppo destabilizzante (dallo speriamo che a me non capiti al o Dio mio, ecco cosa mi è successo, non ne voglio sentir parlare mai più), ma che è necessaria, e va fatta.
Io confido molto nell’istruzione. Nella lettura, nell’approfondimento, nella creazione di figure professionali adeguate che riescano ad aiutare le donne a trovare la propria dimensione nella maternità al di là di ogni pregiudizio, convenzione, imposizione. Ecco perché secondo me i libri come questo di Rossella Milone dovrebbero essere letti a scuola.
“Quando sono rientrata Vincenzo era seduto sulla sedia a dondolo di vimini, è lì che li ho trovati: incastrata nell’incavo del suo gomito c’era la testolina di Lucia, il corpo abbandonato nel calore del padre; una coperta di cotone, la tettarella del biberon tra le labbra che lei schifa, che spesso rifiuta. (…) Eppure la bambina lì nel suo grembo, mi pareva, finalmente aveva recuperato un po’ di serenità”
Buona lettura 🙂