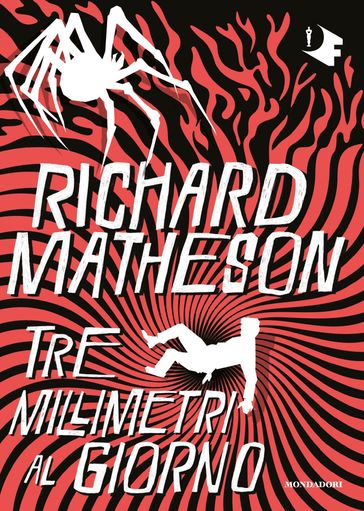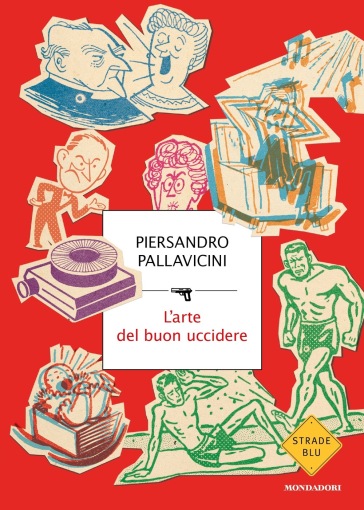“Tutti volevano una pagina, un logo, una veste grafica. Tutti volevano un po’ di bellezza, intesa come una posizione unica in un sistema di differenze.”
“Il gioco di prestigio della gentrificazione è proprio questo: il racconto globale, generico e scintillante, è reso possibile dall’occultamento di una storia locale specifica e priva di valore aggiunto. Una storia viene sostituita da una narrazione il cui contenuto informativo è nullo. Il sapere si perde, un sapere che di per sé è ovviamente inutile ma la cui testimonianza serve, se non altro, a mostrare la vacuità di ciò che l’ha rimpiazzato.”* (*V. Latronico, “La rivoluzione è in pausa”, – I Quanti Einaudi, serie Città, 2022)
Giorni nostri – anno più, anno meno. Anna e Tom, trentenni in coppia di vita intima e attività professionale (si definiscono “creativi“), sono riusciti a trasformare la loro passione per il codice in un mestiere ben retribuito – e decidono di trasferirsi a Berlino. Da diverso tempo, questo è un fatto, la capitale tedesca è frizzante espressione di comunità cosmopolite: incubatore di tendenze all’avanguardia che, come specifica la voce narrante, rappresentano la via di fuga da una “città grande ma periferica nel sud dell’Europa”, libere dal gusto “provinciale e stantio” che invece pervade la provincia dell’impero, scardinate dai legami di “conformismo” e “aspettative” tra “persone tutte identiche”.
Cosa mai potrà andare storto nella vita di Anna e Tom? In realtà nulla; come nulla, d’altra parte, finirà per andare proprio dritto.
“Si sentivano decadenti e invidiabili, vivi.”
“Le perfezioni”, romanzo breve che segna il ritorno di Vincenzo Latronico alla narrativa, è un carosello dell’Instagram: in palette di sfumature petrolio e miele fotografa quel modo di esserci, quello stare all’interno di un “movimento tendenziale” che – racconta l’autore – “assume[va] le fattezze antropomorfe di una mitologia”. La voce fuori campo recupera scintille di vita (Anna e Tom a un rave, Anna e Tom in un club per scambisti, Anna e Tom chiusi in casa per mesi, fra tisane al gelsomino equosolidale, caffè monorigine e plaid di lana pregiata, per terminare una commessa di rebranding) e appartiene a un narratore esterno privo di onniscienza che pare sovrapporsi al ritratto di un noi stessi fruitori del social quando, con una serie più o meno distratta di rapidi scroll, ci introduciamo nella vita di qualcun altro, nella realtà che qualcuno vuole mostrarci.
“La meticolosa composizione di quella mitologia aveva occupato Anna e Tom per tutto il loro primo anno a Berlino, perlomeno nel tempo in cui non stavano organizzando uno dei loro traslochi. Non era una mitologia personale; anzi il suo valore risiedeva precisamente nella sua universalità. Era condivisa da tutti gli spagnoli e francesi e italiani e americani che incontravano; era glossata in un’infinità di articoli di costume e documentari, e replicata nelle immagini che scorrevano sulle timeline di Facebook e sui feed di Instagram di una generazione intera. Era il sigillo del loro ingresso in una comunità cementata da una realtà condivisa, che è quasi come dire una realtà”.
Anna e Tom non sono due soggettività specifiche da romanzo di formazione, non sono una coppia sull’orlo della crisi di nervi di cui “Le perferzioni” si impegna a scandagliare il rapporto; pare buffo ma di Anna e Tom non conosciamo né l’età esatta, né la fisicità – e nemmeno le voci: Tom ha la barba, è secco o in sovrappeso? Anna ha i capelli lunghi? E come parla, Anna? È lieve, impacciata, timida, sbruffona, consapevole? Non lo sapremo mai. Di Anna e Tom nelle pagine di “Le perfezioni” non troveremo un dialogo, un be’, un respiro. Niente. D’altra parte, Instagram ci insegna quanto il linguaggio verbale sia sopravvalutato: la fotografia parla per sé, poi al limite ci sta una caption, ma breve e arguta. A pensarci però, se ci prendiamo la briga di allargare lo sguardo a tutto il feed partendo dai primi, goffi scatti di cui spesso ormai ci si vergogna (ma guai a cancellarli, guai ad alterare la griglia) ecco che la fotografia comincia a svelarsi: una piccola incrinatura della porcellana, il reticolo delle crepe nell’olio del dipinto. La voce narrante allora si fa occhio sottile, armato di pollice e indice aperti nello zoom a osservare le fessure minuscole: una timeline inalterata, vecchia di alcuni giorni, un’imprecisione nello scatto (fuoco al disimpegno della cucina: buste della spesa e fazzoletti di carta sparsi sul ripiano; un tramonto che si vorrebbe glorioso e invece – nemmeno il filtro è riuscito a smussarne i bordi – la vacanza traspira un impietoso grigio plumbeo di fine stagione; un viso smunto, le occhiaie), una disintossicazione da social al sapore di giornate indegne di memoria.
Perché questo atto, il punto di svolta in cui l’esistenza diventa esperienza e la realtà si sovrappone all’immagine – il momento nascosto tra l’adagiarsi su una seduta di design svedese e il cappuccino consumato proprio in quel bar – per Latronico possiede un titolo preciso: è il “sigillo” che definisce l’appartenenza a una “struttura di relazioni”. E questa impronta è uno dei tratti distintivi di quel “crimine di cui solo i colpevoli conoscono il nome“*: la gentrificazione.
“Le perfezioni” è questo: la declinazione poetica di una struttura teorica ben fondata, di cui Latronico si occupa da anni e che consiste nell’analisi dei fenomeni di gentrificazione ossia di quel processo di “riqualificazione e rinnovamento di zone o quartieri cittadini, con conseguente aumento del prezzo degli affitti e degli immobili e migrazione degli abitanti originari verso altre zone urbane”*. Così si esprime Treccani nel definirla (la si recupera da Latronico stesso, che cita Treccani nel saggio “La rivoluzione è in pausa” appena uscito per i Quanti di Einaudi) a cui tuttavia l’autore oppone un altro punto di vista: quello dell’attivista Camilla Pin che all’epoca della riqualificazione dell’Isola, storico quartiere operaio di Milano Nord, la definì come “il processo di investimento e acquisizione a scopo speculativo, da parte di soggetti pubblici e privati, di aree immediatamente circostanti a zone altamente redditizie, con lo scopo di smantellare l’esistente per ricostruire, seguendo standard edilizi che alterano inevitabilmente il contesto urbano.”*
La vita berlinese di Anna e Tom, difatti, è un racconto globale per il semplice fatto che qualsiasi loro esperienza, anche la più elitaria e rarefatta (e vale la pena ricordare la varietà del significato: esperienza è una nottata nel club per scambisti o un tour ai resti del muro ma è anche il possesso – un pezzo di arredamento recuperato dal rigattiere, le cuffie antirumore ultimo modello) risulta già replicata, da altri prima di Anna e Tom, da altri come Anna e Tom e – orrore – anche replicabile, in altra declinazione, da chi arriverà a prendere il loro posto. Che poi Anna e Tom di questo paradosso ne percepiscano l’esistenza è tutto da dimostrare, dato che una delle storture proprie della gentrificazione è appunto la consapevolezza del progetto, che è posseduta solo da chi produce gentrificazione e non da chi ne usufruisce – o almeno non fino in fondo.
“La gentrificazione di cui erano consapevoli era qualcosa che facevano gli altri”.
Ovviamente poi qualcosa accade, tra le pagine di “Le perfezioni”. Si tratta di scarti minimi, eventi che presi singolarmente vengono derubricati a piccoli fastidi, inciampi sgradevoli ma tutto sommato prevedibili: una coppia di amici torna in patria dopo la nascita del figlio – la gestione del quale in Germania è troppo onerosa e complicata per chi non è ben attrezzato con lingua e burocrazia (lingua e burocrazia con cui Anna, Tom e molti altri si erano imposti di non interagire, questione di gran vanto), un cliente disdice il contratto perché l’affitto dell’immobile ha sforato il limite di tollerabilità, la galleria d’arte autogestita nel centro commerciale diroccato è stata sgomberata per far spazio ad appartamenti di lusso; al posto di quella elegante e alternativa torrefazione artigianale (che sorgeva sulle rovine di un antico bar al confine tra l’Est e l’Ovest – ma chi lo sapeva? Non certo Anna e neppure Tom, che di quel che era nel prima non si è mai più di tanto occupato) ora c’è un negozio di articoli tecnici, che del bar ha maliziosamente conservato l’insegna. Di fronte a queste minuterie, però, il feed si incrina in un loop di già visti: le commesse calano, ad Anna e Tom vengono preferiti inglesi madrelingua o, più spesso, tedeschi iper-specializzati dal cachet stellare; la cerchia di conoscenze – tutte piuttosto superficiali, va detto – si restringe: c’è chi si sposta in provincia o parte per la Spagna o semplicemente sparisce dalla timeline; i costi dell’appartamento crescono mentre le occasioni sociali diminuiscono, perché le entrate mensili sono appena sufficienti per pagare le spese.
In realtà, alla definizione di Camilla Pin di cui sopra ho omesso un ultimo pezzo, che recupero qui ora: “[La gentrificazione è] la trasformazione di un quartiere non solo a livello sociale ma identitario e culturale.”* Ad Anna e Tom non sta succedendo nulla di diverso da ciò che era capitato agli abitanti della loro zona nel momento in cui cominciò quel processo di “omogeneizzazione” che, fa notare Latronico, è anche un “processo di ottimizzazione, cioè di appiattimento verso l’alto”. Se da una parte infatti la gentrificazione porta con sé un discorso complesso sull’abitabilità di quartieri all’interno dei quali i residenti storici, spesso di bassa estrazione, non possono più permettersi di vivere né riescono più a trovare ciò di cui hanno bisogno, dall’altra essa ha come risultato una “perdita dell’unicità” a favore di un “processo di disincanto”. E cosa accadrà ad Anna e Tom, quando si renderanno conto di non essere più così speciali? Ma poi, speciali, lo erano mai stati?
Il libro è scomodo, infastidisce, spinge allo sguardo interiore: perché sfruculiando le vite di Anna e Tom ci sentiamo irritati e invidiosi; siamo vecchi boomer di passaggio, siamo fratelli di poco maggiori, un tantino più saggi a brontolare quel “te lo avevo detto” che trasuda rammarico o acidume a seconda dei casi; siamo il cugino piccolo, gli occhi sgranati a dire “dai, racconta ancora quel che facevi là”. La parte finale è spiazzante perché coinvolge il deus ex machina più aborrito di tutti: la famiglia di origine. Conviene leggerlo, quindi.