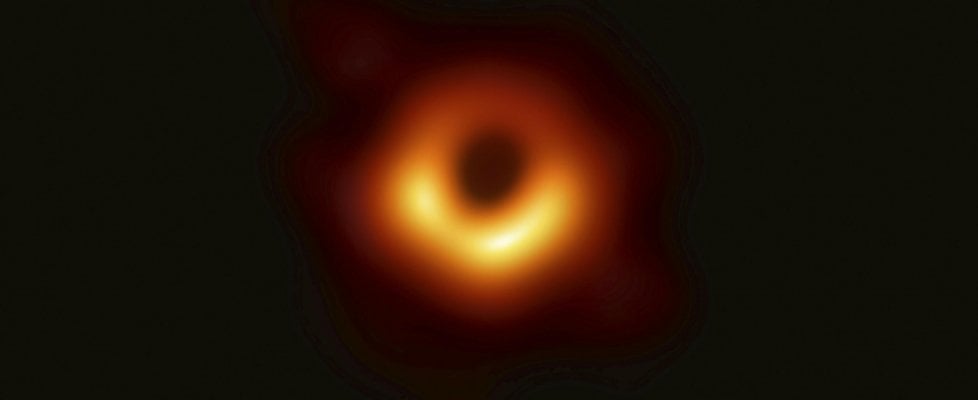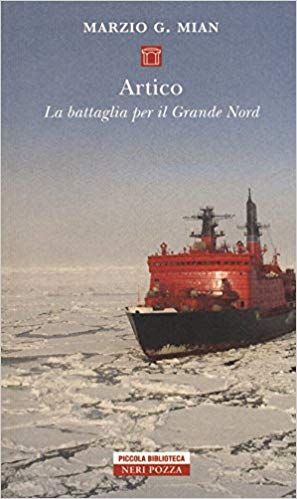Tempo di lettura: 7mins
Ho fermato il blog per qualche mese perché avevo bisogno di chiarirmi le idee: su che cosa stessi leggendo, cosa volessi leggere, cosa significasse quel necessario di cui tutti parlano. Ci stavo ragionando sopra da un po’* finché a primavera, poco prima di #Bookpride, mi accade di imbattermi nel post di una persona – non alle prime armi in fatto di letture – che ogni tanto seguo sui social: una foto di “Serotonina” accompagnata dal commento “Non ho capito se mi è piaciuto o no”. Un’immagine potente che mi ha colpito per sé stessa, non tanto perché riferita a Houellebecq: il simulacro di un lettore, in cui sempre più spesso mi identifico anch’io, che chiude un libro e si trova a dirsi che in fin dei conti non ha proprio proprio capito fino in fondo la natura del prodotto che gli è passato per le mani. Per quanto riguarda le scritture e in particolare il rapporto tra autore/casa editrice/lettore, ho la convinzione che non esista niente di più mal riuscito.
Insomma, la questione vera è la difficoltà che ho da un po’ nel comprendere la verità dei libri. Ora come ora mi viene in mente “La ragazza con la Leica”, per dire. Oppure “La Scuola Cattolica”, che ho preso e abbandonato per tre volte di seguito (ADC, come hai potuto, è premio Strega pure quello, mica selfpublishing, che diamine). Oppure Carrère che mi sono sforzata di leggere per intero (mi manca solo “Romanzo russo”); dall’altra parte il magico Franzosini, il mio percorso di lettura #ADCNorthPole, con l’antropofiction di Matteo Meschiari e i reportage di Marzio G. Mian, i romanzi iper-contestualizzati come “L’invenzione del vento”, solo per citarne uno – di cui poi vorrei parlare su ADC. Potrei andare avanti all’infinito ma poi un momento, fermi tutti: in ballo non ci sono soltanto i libri – e il fatto che ADC si metta a tracciare rotte crossmediali vi deve dare l’idea della gravità con cui percepisce la questione.
Penso a “Bohemian Raphsody” di Bryan Singer o anche a “Rocketman“, il biopic su Elton John diretto da Dexter Fletcher. Ci aggiungo pure “Stranger Things (1-2-3)” coi suoi favolosi Eighties e la miniserie “Černobyl’ ” (che comunque un merito ce l’ha di sicuro: aver insegnato a migliaia di persone la pronuncia corretta della disgraziata cittadina ucraina).
Insomma, la verità sulla verità. La verità vera come la verità vera, anzi, più vera della verità vera – perché a volte la verità vera è così sfaccettata, imprecisa, discutibile, finanche abbastanza noiosa o sconosciuta, celata, aliena che se ne sente il bisogno di una verità, a tratti più vera del vero (non per nulla s’è scritto da più parti che il Freddie Mercury di Rami Malek è in certi punti più autentico dello stesso Farrokh Bulsara in carne e ossa).
Sicché una volta a Bookpride, spinta da chissà quale grazia divina o tentazione demoniaca me ne sono andata ad ascoltare il dialogo tra Lorenzo Marchese e Alessandro Gazoia che se la raccontavano bellamente (pure davanti a numerosi spettatori, il che dimostra come la faccenda non interessi soltanto un pubblico d’élite come ad alcuni piacerebbe pensare) riguardo la difficoltà “accresciuta nei lettori a distinguere verità e menzogna, e comportando una consapevole alterazione dell’identità del genere” (“Storiografie parallele”, p13). E lì, ecco l’illuminazione, Dio benedica le presentazioni dei libri – quelle fatte bene: cara ADC tu hai un problema, e quel problema si chiama non-fiction.
Io devo essere grata a Lorenzo Marchese (ricercatore presso l’Università di Pisa e dell’Aquila, una tesi di specialistica sull’autofiction, diploma di Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Linguistica – proprio con il testo che diventerà il nucleo di “Storiografie parallele”): non solo mi ha inviato “Storiografie parallele” per posta – un’Odissea de’ no artri, made in Poste Italiane, che noi a raccontarla impiegheremmo giornate intere e voi sbianchereste di spavento, quindi anche no – ma mi ha proprio preso per mano perché prima di tutto mi ha regalato il lessico: le parole che mi mancavano per imparare a parlarmi (da me a me) di non-fiction. Non le ho assimilate tutte e non ho la pretesa di riutilizzarle in completa autonomia ma per lo meno posso affermare con sicurezza di averle lette e sottolineate, domandandomi il loro significato; non dico solo quello sulla carta, la definizione, ma anche il senso e la conseguenza del loro esistere.
Se non lo avete mai fatto, fermatevi un momento e chiedetevi cosa succede nella vostra testa quando leggete, che so, “La Scuola Cattolica” di Albinati appunto, o “Gomorra“, o “Elisabeth” di Paolo Sortino, o “I cani del nulla” di Emanuele Trevi. O “In cold blood” di Truman Capote, o “Il Regno” di Carrère. Se volete, quel cosa succede ve lo spiega proprio Marchese, spalancandovi la porta dell’ingarbugliato universo parallelo delle “narrazioni storiche che si servono però di strumenti comunemente riconducibili alla letteratura d’invenzione” (p22). Scoprirete così che la questione della non-fiction non è poi così nuova: viene addirittura dall’antichità classica, si spinge fino alle agiografie, si contorce su se stessa con “Robinson Crusoe”, prende il volo sulle ali del new journalism firmato Joan Didion. Perché il desiderio di “restituire la realtà avvenuta senza filtri apparenti” è cosa antica – e non è mai stata priva di effetti collaterali.
Leggendo “Storiografie parallele” scoprirete pure che questa pratica di scrittura copre una vastità di tipi a dir poco innumerabili: scritti di viaggio (dall’Oriente di Pasolini alla paesologia di Arminio, solo per fare due esempi), saggi narrativi fra saggio critico e romanzo-saggio (tra i vari analizzati: “Troppi paradisi” di Siti, “Le benevole” di Littell, Houellebecq e Albinati appunto), reportage (da Capote a Leogrande, passando per “Gomorra”), biografia (autobiografia, romanzo autobiografico, autofiction, biofiction… dalle “Vite Parallele” di Plutarco all'”Hitler” di Giuseppe Genna). Tipologie che se da una parte sono appunto così varie da essere praticamente incatalogabili – e forse è bene che rimangano così per mio punto, perché se da brava filologa classica ho un debole per la tassonomia, è pure vero che a far troppe schedature talvolta ci si rimette nella visione d’insieme – dall’altra non si può dire che non siano accomunate da alcuni minimi, comuni denominatori: primo fra tutti il carattere di rottura col passato.
“(…) a premessa e conclusione di questo libro c’è una tesi forte e restrittiva su cosa è la non-fiction contemporanea e su come la si dovrebbe leggere per orientarsi fra le pagine: la cosiddetta non-fiction contemporanea è un tipo di discorso narrativo che s’incarica di raccontare storie realmente avvenute e documentabili (in particolare dalla cronaca recente) usando gli strumenti formali e le strategie retoriche della letteratura d’invenzione (comunemente ricondotta alla grande galassia della fiction). Nel farlo, questa categoria di scrittura si pone esplicitamente contro la storiografia contemporanea e fuori, al tempo stesso, dal romanzo” (p42)
Perciò mi sono presa il mio tempo. “Storiografie parallele” va trattato con cautela perché è un testo densissimo: Lorenzo Marchese mi ha raccomandato di sottolinearlo, piegarlo e orecchiarlo e così ho fatto, e nel farlo ho capito che il bisogno che mi aveva spinto al principio era la necessità di uno strumento attraverso cui orientarmi nel buio sempre più buio dell’ipertrofica produzione editoriale contemporanea.
Il romanzo non ci basta più (veramente a me basterebbe anche, solo che quasi nessuno ne scrive più di quelli che vorrei leggere), perché sempre più spesso la fiction è percepita “come un grande discorso insufficiente, inerte, lontano da un confronto serrato con la realtà esterna” (pag273) ma d’altra parte la nostra conoscenza della realtà per come essa è davvero, ossia tramite il giornalismo, è mediata da processi irreversibili quali il fact-checking e la post-truth (pag276). L’ascesa della non-fiction si incista proprio qui, in questo scarto del pensiero che esige una storia vera, nel desiderio di comprendere qualcosa di cui il lettore non ha avuto esperienza (diversamente dall’autore, dato che uno dei criteri base della non-fiction specie con riguardo all’ “odeporica fattuale” e al reportage è la presenza in loco dell’autore, a testimonianza del vero narrato) – ah, l’importanza tutta contemporanea del fatto esperienziale – , ma nello stesso momento non può fare a meno (grazie tv, grazie cinema, grazie reality shows, grazie spettacolarizzazione mediatica del lutto e della tragedia, I’d like to thank you all), del “criterio drammatico“:
“Gli avvenimenti storici sono intramati in un intreccio coinvolgente, secondo una ricostruzione spesso non obbiettiva secondo i nostri canoni di modernità, né mancano aneddoti, scene *teatrali*, confronti ricostruiti ex post. La maniera non finzionale della rappresentazione della realtà, in questo frangente, predilige la costruzione scene-by-scene, le sequenze memorabili e icastiche, la predilezione per l’impatto emotivo e il risvolto forte della violenza: elementi che non di rado tradiscono una memoria cinematografica, televisiva o comunque di secondo grado” (pag277-278)
Si parlava di effetti collaterali – e quelli che si porta dietro la non-fiction non sono da sottovalutare. Lorenzo Marchese li illustra nei dettagli e sarebbe troppo lungo soffermarci a elencarli tutti. Certi autori di non-fiction ne sono consapevoli e cercano con vari espedienti (per esempio Saviano in “Gomorra” o Albinati in alcuni passi de “La Scuola Cattolica”) di avvertire il lettore – pur guardandosi bene dal mettere in atto alcuna azione correttiva sul testo, come a dire lettore io ti ho avvertito: per il resto, arrangiati da solo.
Per quanto riguarda le forme di non-fiction che trattano gravi casi di cronaca oppure episodi storici narrati “dalla parte del cattivo” (e la mia domanda di fondo è: ce n’è proprio bisogno?) la questione diventa ancora più complicata, perché entrano in gioco ad esempio il rischio di “feticizzazione” (pag279) o quello di usare il fatto di cronaca “come laboratorio per parlare d’altro” (pag279), per non tacere la questione spinosa della possibile mancanza di obiettività da parte dell’autore e di una certa spinta alla massmediazione; un inevitabile effetto guilty-pleasure che si accompagna a un altro minimo comune denominatore di tutte o quasi le forme di non-fiction contemporanea: la scarsa attenzione alle fonti scritte cui viene preferita la testimonianza orale, che paradossalmente viene indicata come risolutiva e necessaria al fine di comprendere l’accaduto, quando invece “ridurre l’elemento di ricerca e verifica a favore del criterio testimoniale (…) comporta anche delle conseguenze” (pag275).
Quindi alla fine il tutto si riduce al patto di sangue che sempre, dalla notte dei tempi, accompagna autore e lettore (con le linee editoriali di ciascuna casa editrice in mezzo). Patto che se è ben chiaro nel macrocosmo della fiction (nulla di ciò che è raccontato è vero – ma al limite verosimile) e in quello parimenti vasto della storiografia (tutto ciò che è raccontato è accaduto e verificabile), non così chiaro è oggi al fruitore di non-fiction, che in certi contesti mi pare ultimamente un po’ passivo. Un altro dei miei crucci personali, la passività: nell’accettare un invio gratuito, nel comperare un libro per via del battage pubblicitario, nello spingermi a certe letture sull’onda della spendibilità on-line.
Solo alla fine di “Storiografie parallele” ho capito cosa forse volesse davvero dirmi Lorenzo Marchese quando mi ha scritto che su questo testo occorre “ridiscuterne”. Significa non tanto – credo, che il Cielo mi aiuti – valutarne di nuovo i contenuti, magari alla luce di qualche altro approfondimento (cosa sempre possibile, certo: è vero che certe materie invecchiano in fretta… ma non così in fretta), quanto considerare “Storiografie parallele” un testo aperto, su cui tornare nel momento in cui si senta il bisogno di ri-fare il punto su ciò che si sta leggendo e che il panorama editoriale offre.
“Certamente [le storiografie parallele] fanno parte [della letteratura]. (…) Piuttosto, si deve spostare più a monte la domanda sull’appartenenza, non senza qualche perplessità: posto che le storiografie parallele sono letteratura, cosa sta allora diventando la letteratura? Cos’è che la rappresentazione per molti versi tipica e sincera (ma spesso non esatta) della Storia aggiunge a una conoscenza profonda e stratificata del mondo – conoscenza che della letteratura è teoricamente stato, finora, il fine? Se le storiografie parallele sono letteratura, quanto esse contribuiscono all’accrescimento di conoscenza, e quanto invece tolgono alla nostra capacità di visione, imperniate su un’autenticità che troppo spesso somiglia a una scorciatoia per (illudersi di) vedere *come sono andate le cose fin dei dettagli*, su tecniche di realismo più dirette ma anche più povere, su una verità empirica che non di rado resta luogo comune, espediente spettacolare, appello ricattatorio e blandamente progressista (col lettore portato a calarsi, per il tempo della lettura, nei panni comodi di chi assiste alle ingiustizie della realtà e ai delitti della cronaca stando seduto sempre dalla parte della ragione)?
Non posso impegnarmi a non leggere più testi di non-fiction: finirei per escludere, così a spanne, almeno un terzo dei prodotti presenti a scaffale oggi, cosa che equivarrebbe a scartare anche scritture potenzialmente valide. Ma una cosa l’ho capita, proprio grazie a “Storiografie parallele”: che per me debbono restar fermi alcuni punti – che sono i miei, si intende, senza pretesa di renderli universali: l’attenzione che l’autore deve porre nei riguardi delle fonti, una certa aderenza a un principio che mi viene da definire di sobrietà stilistica, il rispetto nei confronti di ciò che oggettivamente non si può conoscere, nemmeno utilizzando l’escamotage della supposizione. Tutto il resto, a cominciare dalla spettacolarizzazione della sofferenza altrui o da un certo modo di usare “somebody as a mouthpiece”, andrà escluso.
Buona lettura, se volete cimentarvi (E’ necessario? Sì, se come me vi trovate troppo spesso lì, seduti in poltrona con in mano quel libro appena terminato, a domandarvi “ma che cosa ho letto?” e a seguire vi prende quella lieve, scocciante sensazione di aver perso del tempo prezioso)
*A posteriori, come al solito le mie letture si rivelano fondi di caffè postumi che non imparerò mai a interpretare con la dovuta lungimiranza: era chiaro che qualcosa non andava, sin dalla dedizione che quest’inverno spesi per “Il Tao della fisica” – questo mio istinto a recuperare il passato, ritrovarlo, restarci – ed è per questo che spesso mi chiedo come sia possibile avere piani di lettura, elenchi di libri da leggere e pure rispettarli, giorno dopo giorno, settimane di seguito, mesi perfino. Forse è proprio per questo che il bookblogging, quello vero, quello si direbbe focalizzato, non ha mai fatto per me.