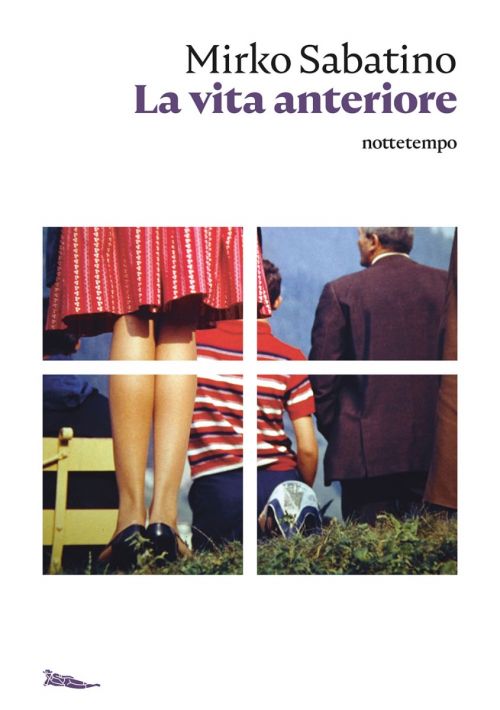“Šaken discuteva spesso con nonno Daulet della Terza guerra mondiale, a cui si preparava con grande zelo nel suo posto di sorveglianza. Forse fu a causa di quell’ultima visione della città morta, che Eržan, da allora, cominciò a sognare la Terza guerra mondiale. Di solito il sogno cominciava da una cielo azzurro e sereno in cui si materializzavano all’improvviso dei piccoli aeroplani che attaccavano un cacciabombardiere americano, mentre le stelle si disperdevano rapidamente nel cielo notturno. Questi sogni si concludevano spesso con l’immagine di una cielo plumbeo, il boato di un’esplosione, seguito dai lamenti del bestiame che si levavano dal suolo, e un improvviso bagliore che si accendeva nell’aria mentre un gigantesco fungo velenoso si stagliava sopra la terra come un jinn.”
Il treno attraversa l’immensità della steppa kazaka. A ogni fermata, le carrozze vengono circondate dai venditori: di lana di cammello, bevande, pesce secco. Sono passati quattro giorni dalla partenza quando, appena lasciata l’ennesima, minuscola stazione, lo scompartimento viene invaso da una musica divina: un ragazzino poco più che dodicenne impugna il violino e con gran talento attacca non le solite melodie della tradizione locale ma le Danze ungheresi di Brahms. Rapiti sono i passeggeri, che aprono le porte delle cuccette e si riversano in corridoio, rapito è il narratore di questa storia, che si avvicina al ragazzino e lo incalza sull’origine di quella vocazione maestosa. Inizia così il racconto della storia di Eržan il Wunderkinder, “Вундеркинд Ержан” – il bambino delle meraviglie. Il bambino che non cresce. Sì perché Eržan, passaporto alla mano e aria da scugnizzo spazientito, fa ben notare che lui di anni ne ha ventisette, non dodici, malgrado le fattezze infantili.
Durante la Guerra Fredda l’Unione Sovietica prese a incrementare la costruzione degli ZATO, complessi abitativo-industriali chiusi, sovente nemmeno segnalati sulle mappe, che venivano utilizzati in specie per scopi militari. Si parla di una quarantina di località, per un totale di più di un milione di abitanti, di cui diverse ancora attive. Semipalatinks-21, nell’attuale Kazakistan, era uno di questi insediamenti; si trattava di un poligono di circa 20mila chilometri quadrati costruito dai prigionieri dei gulag, all’interno del quale dal 1949 al 1989 furono effettuati qualcosa come 459 test nucleari tramite esplosioni in atmosfera e al suolo. Benché la steppa circostante fosse territorio non urbanizzato, si stima che almeno duecentomila persone, per lo più gli ignari abitanti degli agglomerati rurali sparsi lungo le direttrici principali e la ferrovia, furono vittime del fallout nucleare. Il piccolo Eržan è parte di questa ruralità semicontadina: abita ai bordi della ferrovia, all’interno di un casello che conta due casupole: la sua – quella in cui vive col nonno Daulet, addetto al movimento degli scambi, la nonna Ulbarsyn, la mamma Kanysat e lo zio Kepek – e quella dell’anziana Šolpan con il figlio Šaken, impiegato presso il poligono e forte sostenitore del dovere categorico “di metter[si] al passo con gli americani, e perfino sorpassarli”, la nuora cittadina Bajčiček e la figlioletta Ajsulu, cui Eržan in tenera età ha mordicchiato un orecchio, decidendo così di farla sua sposa.
“La fiaba nucleare dell’uomo bambino” è il racconto dell’infanzia di Eržan, tra la nuova urbanizzazione stanziale e un nomadismo ancora radicato nelle abitudini familiari (quell’istinto al viaggio e alla scoperta che tanta parte avrà nelle vicende del ragazzo), tra le melodie della donga, suonata dal nonno nelle lunghe notti invernali, e lo swing dell’Elvis Rosso che esce dalla televisione portata a casa dall’indottrinato Šaken, tra la medicina moderna che Ajsulu vuole studiare da grande e le credenze sciamaniche della vecchia del villaggio, che scudiscia le gambe gonfie della nonna brandendo cosci di montone appena sgozzato. È Il racconto, privo di rimpianto, di un mondo rustico in cui la libertà degli spazi aperti si paga con povertà di risorse e malattie, con l’isolamento sociale e politico, con l’analfabetismo, le botte in famiglia, l’alcolismo, lo stupro. Ed è anche un romanzo di profonda rivoluzione strutturale.
“Nella sua storia non c’era spazio per l’amara nostalgia dei ricordi di cui solitamente si è preda sui vecchi treni, dove il fumo acre, che soffia dalla locomotiva, invade anche gli ultimi vagoni.”
Hamid Ismailov (1954), traduttore e mediatore culturale, è cresciuto in Uzbekistan, terra che appena adulto dovette abbandonare per via delle persecuzioni del regime. Giornalista alla BBC per più di vent’anni, è autore prolifico sia in russo sia in uzbeko; si occupa anche della traduzione in inglese dei testi della letteratura uzbeka e studia da anni il rapporto che intercorre tra musica e poesia popolare. Le sue opere sono bandite in patria.
“Tengri mandò sulla terra Gesar in regno della steppa senza alcun sovrano. (…) Per non correre il rischio di essere riconosciuto, Gesar giunse sulla terra sotto le sembianze di un orribile piccolo moccioso come te! (…). Solo Kara-Coton, che era suo zio, come Kepek lo è per te, aveva intuito che Gesar non era un bambino come tutti gli altri, che aveva un’origine divina, e allora cominciò a perseguitare il nipote con l’intenzione di ucciderlo prima che diventasse grande.”
Il verso formulare costituisce “la cellula elementare della dizione omerica”, scriveva Dario Del Corno. Già nel 1928 Milman Parry in una campagna di rilevamenti in Iugoslavia “accertò che i cantori popolari serbo-croati sono tuttora in grado di improvvisare canti eroici (…) ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente“. In sostanza l’aedo omerico, “attingendo a un materiale precostituito da una lunga tradizione, improvvisa la propria poesia nell’atto stesso in cui la recita” rendendo così di fatto indistinti i momenti rappresentati dall’atto della creazione, della trasmissione e dell’esecuzione, così come diviene irrilevante l’esistenza del “poeta sovrano”. “La fiaba nucleare dell’uomo bambino” (il cui titolo originale è proprio il Wunderkind Yerzhan a cui fanno riferimento le nonne) è strutturata proprio come un poema tradizionale, all’interno del quale l’aedo, rappresentato in questo caso dal viaggiatore anonimo, si fa narratore al ritmo non della bacchetta che il recitante professionista picchiava a terra per contare l’esametro ma delle ruote del treno sui binari. La storia di Eržan quindi si sovrappone all’epos e alle fiabe della tradizione popolare kazaka – di cui acquisisce anche la forma, che nella parte finale passa dalla prosa a un flusso di coscienza vicino alla dimensione poetica. Perfino la nascita del piccolo bambino prodigio – “buldur kimdir“, uno che la sa lunga – , rimane nell’ombra (la madre, chiusa da anni in un rigido mutismo selettivo, pare fosse stata violentata mentre giaceva inerme in un campo, traumatizzata dall’ennesima esplosione nucleare che aveva squassato la campagna), assumendo già dal principio i contorni di una leggenda che per importanza e gravità viene sovrapposta dalle anziane nonne a quella del favoloso regno di Ling, ancora oggi cantato dai bardi della “cintura di Gesar” in Cina (ndr: sì, parliamo proprio del nostro Caesar/Καῖσαρ, di origine turca); un corpus fittissimo di racconti epici a tradizione orale, vivi anche in forma di performance artistica dall’Asia centrale e meridionale sino al Tibet da dove pare derivi.
“La fiaba nucleare dell’uomo bambino” è il racconto di un’esistenza individuale che di fatto incarna quella di una tragedia collettiva, letta attraverso l’unico sguardo che Ismailov ritiene utile e necessario per raccontare simili avvenimenti: la narrazione epico/mitica, ossia quella che sin dalla notte dei tempi trasforma, tramite lo strumento dell’oralità e dell’occasione condivisa, le vicende umane da piccole e particolari a eventi universali. Come ogni epica che si rispetti, essa segue il medesimo percorso di iniziazione: la storia particolare viene disancorata e collocata in una dimensione a-temporale e per certi versi decontestualizzata; al protagonista, tramutato in eroe, è assegnata una missione (l’uccisione rituale dell’antagonista, che per Eržan è identificato con la Zona, la porzione di steppa altamente radioattiva al centro del quale, tra carcasse di automobili e acciaio fuso, ombre nere di alberi proiettati su muri scarniti e crateri profondi come quelli lunari, giace un occhio di blu purissimo, pesante, che conserva il segreto delle ossa irrigidite di Eržan), gli vengono forniti armi e attrezzi magici (un violino e un fucile) e gli viene promessa la sposa tanto desiderata.
“Mi sentivo anch’io smarrito come quella volpe nella steppa aperta, incapace di capire dove finisse la verità e dove cominciasse la finzione. Dov’era il confine tra il fluire ineludibile dell’esistenza e l’eternità indecifrabile?”
La narrazione mitica ed epica, di fatto, è il modo in cui l’essere umano usava spiegare a se stesso e ai propri figli gli eventi naturali e le tragedie causate da altri uomini, come le guerre. Che i narratori conoscessero o meno la realtà dei fatti, poco importa. Lo scarto del pensiero sta tutto qui. La storia di Eržan comincia su un treno, nel momento in cui un ragazzino in tutto e per tutto sano, reale, concreto mostra a uno scrittore un documento di identità – non sapremo mai se vero o falso. Non a caso la terza parte del racconto si intitola “Il sale del mito“: perché col passare del tempo l’acqua di quel blu straordinario – la storia vera – evapora e svanisce, facendone sedimentare le scorie – il sale – di una narrazione che diventa sempre meno aderente al vero (alla fine importa se le nonne di Eržan conoscessero o meno la causa dei loro malanni, delle improvvise tempeste, del latrato dei cani durante la notte?), per acquisire un significato universale. La storia di Eržan farà la fine di tutte le altre storie perse nel tempo, quei racconti che ognuno tira insieme un po’ come vuole, durante le notti d’inverno, e alla fine, dopo tanti anni, nessuno saprà più se siano vere o finte, sciocchezze raccontante dai vecchi o accadimenti reali e documentati. Chi ha dimestichezza col mito, però, è consapevole del fatto che nel cuore nero di ogni leggenda, specialmente in quelle più antiche, resiste sempre un nodo di verità profonda. La storia di Eržan non fa eccezione, fatto salvo un punto: che quel qualcosa di vero noi lo conosciamo bene.
“Nulla è più puro della luna, che nella notte alberga, ma il giorno dispare. / Nulla è più puro del sole, che nel giorno alberga, ma la notte dispare. / Il vero islam in nessuno dimora, solo sulla lingua vive, e non nei cuori. / Destino nomade e ricchezze solo ad alcuni sono concessi. / Invano ti affaticherai a cercarli. / E pochi sono i posti che vengono destinati. / (…) Quando il nemico insorge, / se pure di cingerai della sciabola e ti armerai di cinque fucili, / non diverrai un vero guerriero.”