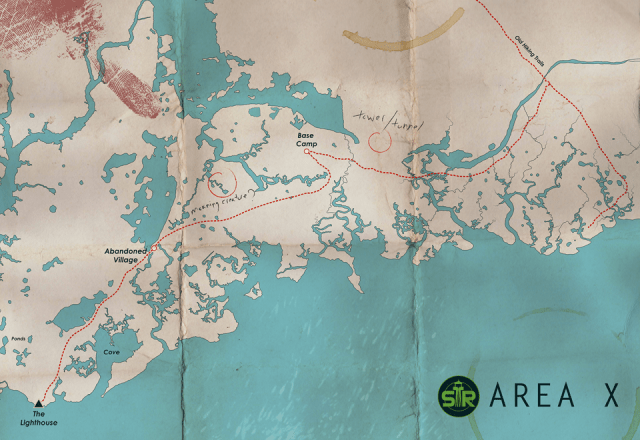Ancora una volta Andrea De Carlo punta sulle dinamiche di coppia. Qui però in maniera esclusiva, diversamente da quanto aveva fatto due anni fa con “Villa Metaphora” opera in cui lo scrittore si era messo alla prova affrontando in maniera esplicita anche temi di natura politica e sociale.
Luglio 2014. Craig Nolan, antropologo inglese di fama internazionale, come ogni estate da sette anni torna per le ferie a Canciale, un paesino a mezza costa tra La Spezia e le Alpi Apuane in cui sua moglie – l’affermata scultrice di gatti in pietra Mara Abbiati – possiede da tempo una piccola casetta a cui è sentimentalmente molto legata. L’abitazione è vecchia e avrebbe bisogno di una ristrutturazione che entrambi i coniugi rimandano di anno in anno, ognuno per le proprie ragioni. A seguito di un forte temporale Craig sale sul tetto per controllare i danni ma le tegole cedono e l’antropologo, non più agile come un tempo, frana rovinosamente all’interno, riportando tra l’altro alcune contusioni. Nella spasmodica ricerca di qualcuno disponibile anche nel pieno dell’estate a riparare il cratere che rende inagibile la stanza da letto, i due coniugi si imbattono in Ivo Zanovelli, proprietario di una piccola impresa edile. Il motociclista Ivo, bicipiti e tattoo in evidenza, catenone d’oro al collo e coda di cavallo, con la sua banda di operai slavi sarà la scintilla che scardinerà gli equilibri già precari e le tensioni che minano non solo la coppia ormai al limite ultimo di vicendevole sopportazione ma anche la fragile stabilità emotiva dello stesso Zanovelli.
L’impianto narrativo a prospettiva multipla, differenziato anche a livello stilistico, per strutture sintattiche e lessico, segue quello sviluppato negli ultimi romanzi ed è lo strumento che De Carlo utilizza per raccontare a capitoli alterni la verità di ciascun protagonista. Quindi la narrazione pur procedendo lungo una linea temporale ben precisa si nutre di continui flashback e cambi di punti di vista. Ciò permette in primis una caratterizzazione dei tre personaggi a tutto tondo e in secondo luogo è in grado di offrire dinamicità a un canovaccio che altrimenti avrebbe forse risentito di una certa statica ripetitività. Non manca poi – altro segnale di differenziazione tra questa diciottesima fatica dell’autore e le sue precedenti – un certo gusto per la suspance e l’effetto sorpresa reso vivo proprio dal continuo movimento di prospettiva che dilata il tempo delle tre narrazioni individuali.
“E’ in un’altra fase della sua vita, anche se è meglio non chiedergli quale perché non lo sa. Non è più dov’era prima, va bene? (…) Non serve nemmeno cercare di mettere tutto in parole. Per raccontarlo a chi, poi?” (pag.112)
sbotta tra sé Ivo Zanovelli. Forse lo è anche De Carlo, in un altro momento della propria storia creativa. Perché alla tecnica dello spostamento della prospettiva e quella della suspance che per altro non manca di un insolito risvolto noir aggiunge pure una pungente e abile ironia. Abbandonando la consueta dicotomia di sentimento nei confronti dei propri personaggi – o la resa incondizionata o l’odio feroce – De Carlo per una volta (a dire la verità ci aveva già provato in “Villa Metaphora” ma qui affina il gusto, limandone gli eccessi precedenti) prova a divertirsi, e ci riesce pure, dando vita a tre entità caratteriali completamente differenti ma estremamente verosimili alla cui osservazione si dedica poi con piglio quasi scientifico, lasciandole libere di sperimentare la propria individualità.
Da una parte abbiamo così l’antropologo Craig Nolan, una fulgida giovinezza di studi passata “nella valle del Wahgi in Papua Nuova Guinea” (pag.31) – e in molti altri luoghi dai nomi francamente impronunziabili, dimenticati da Dio e dagli uomini – che ora, imbolsito dall’età, dalla vita sedentaria a cui l’insegnamento universitario lo ha abituato accalappiandolo scaltramente col passare degli anni, imbrigliato nel tutore che gli costringe la gamba malconcia, se ne sta lì sotto il sole cocente – la pelle arrossata da inglese pallido, il sudore che cola copioso sulla fronte – a criticare tutto e tutti.
Dalla casa di Canciale (e si badi al ruolo che via via assume, questa casupola decrepita infestata dalle erbacce):
“La verità (però quale verità, quella di adesso, o quella di allora?) è che Canciale gli era sembrato un luogo rude, sciatto, semidesolato. (…) Niente a che vedere con il solare villaggio che aveva continuato a visualizzare fino a quel momento: nessuna traccia di bianche casette risplendenti nella luce, di buganvillee dall’intenso color porpora, di terrazze affacciate sul mare blu cobalto. A vista d’occhio c’erano solo pendenze verde scuro attraversate dalle linee più chiare di oliveti ormai in gran parte inselvatichiti e punteggiate di piccoli edifici mal ridipinti e mal curati, orti primitivi, garage abusivi, erbe infestanti fuori controllo, reti metalli che, lampioni dagli steli sproporzionatamente grandi” (pag.15)
alle sane abitudini dell’italiano medio:
“E’ una cultura di furbi, truffatori, improvvisatori, arruffapopoli, seduttori da bar, prostitute e clown, che privilegia gli esercizi verbali a vuoto e i giochi di prestigio sulla serietà e l’affidabilità” (pag.72)
agli immigrati fuorilegge (i “balcanici indemoniati” come li definisce a pag.97), il tutto condito da dottissime e pedantissime digressioni antropo-psicologiche a spiegazione dei fatti accaduti e di quelli che a breve accadranno, che Nolan predice con assoluta, certosina accuratezza – va detto.
Su tutto, la pruriginosa relazione di sesso occasionale (citata a pag.256 e indagata – finalmente! – soltanto cento pagine più tardi, alla 347) con la giovane studentessa universitaria, recente conquista del noto professore: più un’affermazione del sé, vittima della classica crisi di mezza età, che un vero e proprio innamoramento.
De Carlo guarda a Craig Nolan con curioso disincanto: che fine ha fatto, sembra chiedersi, questo Indiana Jones de’ no’ artri, che dieci anni prima aveva incantato una donna straniera, meravigliosa e passionale raccontandole di viaggi e avventure, con magia di parole, destrezza di ragionamenti e fedele osservanza a misticheggianti questioni di principio (niente patente, niente auto, niente cellulare)?
Ma non c’è spazio per il livore perché “La pancetta degli ultimi due o tre anni che sporge da sopra l’orlo dei calzoni” (pag.81) non fa differenze di classe e colpisce tutti, democraticamente, e le questioni di principio trascinate all’estremizzazione dopo un po’ scocciano perché:
“Qualunque libertà (…) ha un costo: è vero, ma spesso il costo viene semplicemente trasferito a qualcun altro” (pag.104)
Si rimane davvero basiti di fronte a questa affermazione che difficilmente De Carlo avrebbe affidato a un suo personaggio fra quelli descritti in passato. Non contento, lo scrittore rincara la dose: “La realtà è che la sua carriera si è diversificata sempre più negli ultimi anni, e lui ha sempre più bisogno di un’organizzazione di vita stabile per raccoglierne i frutti” (pag.102) e affronta sempre attraverso l’alter ego Craig Nolan uno dei temi più cari, quello del viaggio, ribaltandolo addirittura nella prospettiva: la scoperta di nuovi luoghi si tramuta in pedanti elenchi di nomi astrusi e alla fine insignificanti, a favore di una riflessione a trecentossessanta gradi sul valore delle radici e delle abitudini condivise (uh sì, come no, parlatene a Guido Laremi…):
“Chiunque ha bisogno di luoghi in cui sentirsi a casa, attraverso cui definire il proprio carattere e i propri gusti, a cui affidare le proprie memorie e le proprie immaginazioni” (pag.21)
Quasi che la soluzione sia non tanto saltar da un posto all’altro come cavallette impazzite quanto imparare a comprendere quando fermarsi per poi prendere il meglio di quel che viene offerto, per migliorare non solo noi stessi ubbidendo a un semplice edonismo narcisista ma anche chi ci sta intorno.
Naturalmente a Craig Nolan fa da contrappeso Ivo Zanovelli, un personaggio bizzarro che DeCarlo studia con raffinatezza di intento evitando di cadere nel tranello della macchietta. Il costruttore motorizzato è un tamarro senza patria e senza legge; si accompagna a un gruppo di operai slavi alcolizzati di cui non fa mistero a lamentare le abitudini violente che non vengono condannate ma neppure edulcorate in nome di una presunta com-passione umanitaria; stipula accordi in nero, corrompe con qualche mazzetta, si rifornisce di materiale ecocompatibile di prima qualità prendendolo da cantieri in sequestro; ha avuto due figlie da altrettante ex-donne. Zanovelli però all’opposto di Craig è vittima consapevole di uno stile di vita che di alcune, vere questioni di principio ne ha fatto il fil rouge, lontano anni luce dall’antropologo di fama internazionale che (per chissà qual motivo – DeCarlo, è un j’accuse o un mea culpa?) si è piegato alla divulgazione televisiva da documentario in prima serata, chinando il capo di fronte a drammatiche semplificazioni contenutistiche tra ospitate di starlette nazional-popolari e doppi sensi di innegabile cattivo gusto. E vedremo a quali conseguenze porterà questa presa di posizione.
E Mara Abbiati? Sta lì, tra i due contendenti, acquattata nell’erba come una delle gatte che estrae dal tufo a colpi di scalpello. Il personaggio più sfuggente, il più abbozzato, forse quello meno riuscito dei tre, il più criticato e criticabile. Craig le rimprovera una certa fatuità credulona che forse poteva affascinare dieci anni addietro ma che adesso crea soltanto fraintendimenti e irritazioni:
“Mara è prontissima a rinunciare a qualunque tipo di garanzia: trascinata dalla sua fiducia ingiustificata nel prossimo, travolta dall’impazienza, insofferente di qualunque rallentamento” (pag.76)
“Lei sta per ribattergli qualcosa a proposito del diritto di un cittadino a disporre dei propri soldi come gli pare” (pag.158)
Lei stessa si strugge, nella vana ricerca di un punto fermo tra mente e corpo che cambia, il passare degli anni, la maturità intellettuale, l’insofferenza verso l’accademia a cui Craig la costringe:
“Craig qualche tempo fa le ha detto che la trovava “bella pienotta”, non era chiaro se in tono di apprezzamento o disapprovazione. Di fatto i jeans che l’estate scorsa le stavano già un po’ attillati quest’estate le vanno decisamente stretti” (pag.53)
E anche Ivo pur affascinato non le risparmia l’osservazione riguardo a una certa indolenza di atteggiamento – mascherata (ancora una volta De Carlo cambia prospettiva, sarà mica l’età?) sotto l’affascinante ma pericoloso mito della passione (o della repulsione, che è lo stesso) istintiva, caduca, instabile:
“Non puoi non essere curiosa (…)! Anche se odi il marmo fa comunque parte del tuo lavoro, no?” (pag.162)
Se Starnone ci ha illuminato raccontandoci nient’altro che il poi di una crisi coniugale ormai consumata, De Carlo ci aiuta a interpretare questo poi attraverso il durante, testimoniando il momento stesso in cui essa accade:
“All’iniziale cessione spontanea di sovranità, e all’accettazione di comportamenti estranei che ne discende, alla mimesi temporanea, all’adattamento volenteroso a modi e ritmi altrui, segue una fase di resistenza crescente, un rigetto progressivo, nel tentativo (spesso disperato) di recuperare la propria identità perduta” (pag.99-100)
“E’ la paura a tenerli insieme? Un sistema incrociato di minacce e rassicurazioni? Un’offerta reciproca di familiarità e consuetudine come antidoto al terrore del non conosciuto? Hanno stabilito con il loro matrimonio il diritto a paralizzarsi a vicenda la vita sentimentale, senza in cambio il dovere di coltivare sentimenti o emozioni l’uno nell’altra?” (pag.256)
“Ma l’alternativa non è molto peggiore, come hanno dimostrato i fatti di oggi? Non è la destabilizzazione totale, la moltiplicazione dei dubbi, una perdita generale di senso?” (ibid.)
Le conclusioni a cui giungono i due autori, pur analizzando lo stesso fenomeno, non sono affatto le medesime. Ancora una volta De Carlo ci sorprende perché, a differenza di Starnone e distaccandosi anche da tante sue opere precedenti, ci regala un finale sostanzialmente aperto (anche per trama) in cui per una volta viene dato spazio a una soluzione non convenzionale, nella sua apparente, semplice banalità:
“La realtà è che rifare alla perfezione il tetto di una casa in cattive condizioni strutturali non ha molto senso (…). Forse è vero che qualunque cosa può essere riparata, ma solo con un intervento radicale sull’insieme (dalle fondamenta in su, per così dire), non cercando di sistemare le singole parti” (pag.352)
Buona lettura 🙂