“L’albero di Natale sembrava solo e triste nel suo angolo, senza mobili attorno. Ecco lì tutto quello che serve per rendere sgradevole un abete: la luce solare diretta” (pag.119)
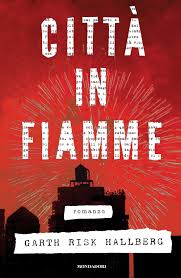 Due milioni di dollari di anticipo, la vendita dei diritti cinematografici in anteprima, un battage pubblicitario senza precedenti supportato dalle migliaia di copie spedite in anteprima a giornalisti e critici, l’endorsement di gran parte dell’establishment culturale americano. Novecentoundici pagine fitte, sostenute da un apparato iconografico che comprende riproduzioni di lettere scritte a mano, facsimili di fanzine anni ’70, pezzi giornalistici dattiloscritti, fotografie in collage – tutto materiale necessario all’economia della vicenda, di imprescindibile lettura.
Due milioni di dollari di anticipo, la vendita dei diritti cinematografici in anteprima, un battage pubblicitario senza precedenti supportato dalle migliaia di copie spedite in anteprima a giornalisti e critici, l’endorsement di gran parte dell’establishment culturale americano. Novecentoundici pagine fitte, sostenute da un apparato iconografico che comprende riproduzioni di lettere scritte a mano, facsimili di fanzine anni ’70, pezzi giornalistici dattiloscritti, fotografie in collage – tutto materiale necessario all’economia della vicenda, di imprescindibile lettura.
Questi i numeri e i fatti che hanno accompagnato, a metà 2015, l’uscita di “City on Fire”. L’autore è l’esordiente Garth Risk Hallberg, giovinotto trentaseienne cresciuto in una cittadina del North Carolina ma nato il Louisiana, e la leggenda ormai vuole che l’idea folgorante gli sia venuta nel 2003, durante uno dei suoi viaggi quotidiani in pullman verso New York, ascoltando “Miami 2017” di Billy Joel.
Questi i numeri e i fatti che hanno accompagnato, a metà 2015, l’uscita di “City on Fire”. L’autore è l’esordiente Garth Risk Hallberg, giovinotto trentaseienne cresciuto in una cittadina del North Carolina ma nato il Louisiana, e la leggenda ormai vuole che l’idea folgorante gli sia venuta nel 2003, durante uno dei suoi viaggi quotidiani in pullman verso New York, ascoltando “Miami 2017” di Billy Joel.
***
“Nella sua mente il libro continuava a crescere in lunghezza e complessità, quasi come se si fosse assunto il peso di soppiantare la vita reale, invece di evocarla. Ma com’era possibile per un libro essere grande come la vita?” (pag.946)
“Città in Fiamme” – trama e personaggi
Riassumere “Città in Fiamme” significa prima di tutto tenere a mente due date: la notte del 31 dicembre 1976 e quella del 13 luglio 1977. Hallberg utilizza la prima, un banale capodanno newyorkese come tanti, per mettere in scena l’omicidio fittizio di Samantha Cicciaro, una giovane studentessa universitaria – ultima erede di una sfortunata famiglia italoamericana specializzata nella costruzione artigianale di prestigiosi fuochi d’artificio, ora caduta in disgrazia a causa dell’avvento della produzione in serie e della tecnologia – che viene ritrovata in fin di vita in un angolo di Central Park, vittima di una sparatoria.
In un continuo scambio di punti di vista e piani temporali (dal presente della narrazione ai numerosi flashback 1950-’60 fino ai flashforward del dopo-millennio) Hallberg segue non soltanto gli ultimi mesi della vita della ragazza ma anche e soprattutto le vicende di coloro che in un modo o nell’altro erano entrati in recente contatto con lei: un paio di amici del Lower East Side, tossici e disoccupati, che l’avevano iniziata al movimento punk; alcuni insospettabili membri della facoltosissima dinastia Hamilton–Sweeney con i rispettivi figli, consorti e tirapiedi di stanza a Manhattan; Mercer Goodman, maestro e aspirante scrittore emigrato da Altana, Georgia; Richard Groskoph, un reporter alcolizzato in cerca di riscatto e infine Lawrence Pulaski, viceispettore (poteva mancare?) claudicante, a fine carriera, deciso a risolvere il rompicapo dell’omicidio. I destini di questo gruppo così eterogeneo si riuniscono nella notte – non altrettanto banale – del 13 luglio dell’anno successivo, notte in cui New York piomba in un drammatico black-out che diviene pietra miliare nella storia (vera) della metropoli.
 |
|
Alvin Langdom “Night in NY” 1905-1911
|
L’arte di Hallberg nell’organizzazione della materia è evidente e si tocca con mano.
Le parti descrittive, specie quelle relative alla città di New York, sono quasi sempre valide, contestualizzate e rivelano conoscenza diretta, ispezione, esperienza. Oggettivamente stupisce il risultato raggiunto da questo esordiente trentaseienne, per altro non originario della metropoli:
“Il centro di Flower Hill, con tutta la buona volontà del consiglio del Village, non poteva librarsi oltre i suoi limiti intrinseci. Di giorno simulava un ambiente urbano senza qualità – c’erano un fioraio, un salone per feste di nozze, un negozio di dischi niente di che – ma di sera, le luci delle facciate dei negozi sparavano in faccia le coordinate delle vere urgenze cittadine. Massaggi. Tatuaggi. Banco dei pegni. Davanti a una caffetteria vuota, un Babbo Natale animatronico con le gambe incatenate a una recinzione ruotava rigido su se stesso al tempo di Jingle Bells” (pag.19)
I protagonisti vengono presentati inizialmente uno a uno per capitolo ma l’autore è abile a scardinare presto anche questo prevedibile meccanismo perché nel momento in cui l’introduzione di un’altra figura standing-alone avrebbe potuto creare una sensazione di effetto cinematografico a fruizione passiva (ndr: fra il terzo e il quarto cap.) modifica tono e struttura. Attraverso l’inserimento di tutti gli altri personaggi per mezzo di una tecnica ad avvicinamento lento, Hallberg consegna i collegamenti nelle mani del lettore che quindi viene coinvolto in prima persona, come per ogni giallo che si rispetti.
 |
| Edward Hopper credits @HopperAtoZ |
“Città in fiamme” è sicuramente un romanzo d’atmosfere e la dinamica di dialogo poco serrato insieme all’osservazione sempre contestualizzata della realtà ne limitano l’effetto cinematografico che tuttavia permane – o meglio si rende evidente – in alcuni punti ben precisi e che tendono a ripetersi nel corso della narrazione: l’abitudine ad accostare immagini e colonne sonore, una certa teatralità di espressioni ad effetto tipiche della filmografia USA, alcune inquadrature dietro le quali si intravede la telecamera e l’età anagrafica dell’autore che comunque è persona cresciuta, come tutti noi, con la televisione in salotto.
“Lei la considerava una tipica attività californiana, guardare la tua vita da lontano, cercando di riconoscere dai profili degli alberi e delle strade e dai ristoranti costruiti con la stessa forma delle loro specialità culinarie quale casa fosse la tua. (Questo prima di trasferirsi a New York e scoprire che riscrivere la propria vita in chiave cinematografica era un fenomeno nazionale, forse anche globale)” (pag.579)
E non è certo un caso che uno dei passi più riusciti dell’opera sia l’evidente tributo al Kubrick di “Eyes Wide Shout” delle pagg.40-90.
 |
|
Night in NY Alfred Stieglitz 1896
|
***
“All’inizio avevo intenzione di scrivere un pezzo che specchiasse l’enigma che cercavo di risolvere: in che modo, dai contenitori grandi come macchine per il caffè e pieni di materiale inerte, escano sfolgoranti trame di colore che riempiono il cielo. Ho immaginato me stesso ricavare con maestria da pezzi separati un’unica esplosione. Invece adesso scopro di avere tentato di andare a ritroso, di aver provato a ricostruire un corpo unico dagli elementi che lo scoppio aveva disperso a caso” (Richard Groskoph, “Gli artificieri”, pag.31 – in “Città in Fiamme”)
“Città in Fiamme” – Il nuovo GRA
L’interesse statunitense per l’esordio di Hallberg è presto spiegato se si considera l’affanno con cui la critica a stelle e strisce è da tempo alla ricerca del nuovo GRA, il Grande Romanzo Americano. Giusto un anno fa, in occasione dell’uscita di “Purity” di cui venne proposta un’anteprima in traduzione italiana, IL pubblicò un interessante reportage in proposito (ospitando diversi interventi tra cui quelli di Christian Rocca e Marco Rossari), a uso e consumo del pubblico italiano. Philip Roth, Don De Lillo, Cormac McCarthy, John Updike e Toni Morrison – e poi, David Foster Wallace, Jonathan Franzen, Zadie Smith, Nathan Englander e Jeffrey Eugenides sono soltanto alcuni degli autori citati.
Non sorprende quindi l’ansia sempre crescente dell’audience americana, in attesa di quella nuova leva di scrittori casalinghi in grado di dare testimonianza dei mutamenti più recenti occorsi al mondo oltreoceano.
Hallberg in questo senso stupisce per furbizia, va notato. Con una captatio benevolentiae intelligente e sottile, che percorre tutto il testo, non si espone mai direttamente ma si schermisce e affida le sue (pur numerose) riflessioni a riguardo a due personaggi si potrebbe dire minori – e per altro destinati a fortune incerte: il primo è Mercer Goodman, il fidanzato di colore di William Hamilton-Sweeney, giunto a New York per “la divorante ambizione di scrivere il Grande Romanzo Americano” (pag.5-6) ma poi costretto a un impegno frustrante e a tempo pieno, quello dell’insegnante in una scuola privata d’elite (episodi di razzismo e omofobia compresi), e vittima di una relazione sentimentale complicata e di certo non alla pari, neppure dal punto di vista economico; il secondo è il giornalista sbandato Groskoph che, caduto in disgrazia dopo un esordio promettente, cerca con fatica di risalire la china – e si tace dell’esito.
Più di una volta Hallberg stempera le buone idee di cui è innegabilmente disseminato “City on Fire” attraverso l‘autoironia e l’impegno nel ridimensionare il ruolo dello scrittore, che se da una parte quasi mai risulta all’altezza alle aspettative a causa di limiti intrinseci (“Non illuderti di trovare qualcosa sotto la superficie” – pag.80), dall’altra è dichiarato vittima di un sistema che considera l’arte della narrazione soltanto come un mezzo attraverso cui autoincensarsi (“Non c’era niente che NY amasse leggere di più che di se stessa” – pag.194).
D’altro canto Hallberg non fa mistero della propria affezione (“…un tradizionalista” – pag.376) per un certo tipo di narrativa (“…la vecchia idea che il romanzo possa insegnare qualcosa” – pag.377) e del proprio debito nei confronti di tanti predecessori (“Truman [Capote] aveva i suoi demoni – chiunque avesse scolato un bicchiere insieme a lui lo sapeva- ma nessuno avrebbe potuto negargli quello di cui stavolta era stato capace: scomparire del tutto nelle vite degli altri” – pag.195) e raramente cede all’autocompiacimento (“…un giovane poeta [Balzac] arriva dalla provincia a Parigi per far fortuna, e alla fine scopre di essersi sbagliato su tutto. Tutti quelli che credeva dei geni sono degli idioti e viceversa” – pag.260).
Non manca comunque una discreta dose di positive thinking – non averla sarebbe stato del tutto contrario ai principi del GRA – sia per quanto riguarda il Romanzo in sé (“…era ancora convinto che l’arte americana dovesse essere Grande” – pag.597) sia per quello che concerne l’istruzione pubblica statunitense – ricca com’è l’opera di riflessioni riguardo la necessità di mantenere alto il livello dell’offerta culturale del Paese, tanto quanto quello delle istituzioni scolastiche e degli spazi d’arte e cultura come musei e biblioteche, veri e propri luoghi di sviluppo della società civile.
***
“…c’erano ballerini impegnati in una danza al rallentatore sotto gli alberi rivitalizzati. Famigliole sedute in ordine sui teli, in una luce vinosa. Continuo a vedere scene simili dappertutto, arte pubblica difficile da distinguere dalla vita pubblica. (…) Quasi che i sogni potessero essere piatti alternativi nel menu delle esperienze possibili (…) [la] razionalizzazione di ogni ultimo desiderio” (prologo)
“Città in Fiamme” – il mondo artefatto
 |
|
Early Spring Afternoon in Central Park
|
E’ chiaro come il fil rouge di tutta l’opera di Hallberg sia la riflessione sull’essere e sul divenire, e la responsabilità individuale che questa trasformazione da <> a <> porta con sé. E’ un tema tipico della letteratura US – imprescindibile dal sistema-GRA – che viene direttamente dall’epica del selfmade-man – artefice del proprio destino e della propria fortuna, maglio se conquistata con fatica e sofferenza – così cara all’immaginario americano. Naturalmente a ciò fanno seguito l’altrettanto tipica ossessione per il raggiungimento del successo sia personale sia professionale, il problema connesso alla gestione del senso di colpa in caso di fallimento e il senso di profonda ingiustizia percepita nel momento in cui, pur avendo fatto tutto il possibile, ciò per cui ci si è spesi non accade, o non si ottiene:
“…l’esistenza di una causa logica significa che le cose non sono così incontrollabili. Ma per sua esperienza, a cercarne una con troppo accanimento si rischiava di sentirsi colpevoli, di rendere se stessi la causa quando invece si era ben lontani dall’esserlo” (pag.348)
Nonché l’idea dell’esperienza di vita unica e perfetta, irripetibile (“Il momento clou della giornata” – pag. ), che deve essere cercata e goduta a tutti i costi che tuttavia come conseguenza porta con sé l’idiosincrasia nei riguardi del momento della scelta. Una continua serie di bivi che, come ovvio, escludono a priori altre strade che non potranno più essere battute:
“…sembrava che oggi ogni americano avesse il suo gemello oscuro, la possibilità di una vita vissuta in un modo diverso, a fissarlo dalle vetrine e dallo specchio del bagno” (pag.290)
Tant’è che la passione tutta newyorkese per il racconto delle nevrosi – vere o posticce che siano, irrompe sin da pagina 45 e investe un po’ tutti i protagonisti specie quelli dell’alta società: manie di controllo, disturbi ossessivi, ipocondria, disordini alimentari, nient’altro se non i sintomi di un disagio profondo che rivela la tensione sempre crescente tra il desiderio di un cambiamento e il terrore del giro di boa all’uscita dalla propria zona di comfort. La situazione della classe operaia è da trattare a parte, densa com’è di fenomeni sociali al limite tra cui abbandono scolastico, bullismo, dipendenza dall’alcool, utilizzo di stupefacenti (e a far da collante tra operai e upper-class, l’eroina).
 |
| Edward Hopper credits @HopperAtoZ |
La rappresentazione visiva di questo struggimento è, e sempre sarà, la metropoli newyorkese, che nell’immaginario di ogni statunitense è il “luogo in cui si concentra il cambiamento” (pag.320) per antonomasia tanto che, in un continuo disallineamento di aspettative, essa diviene l’unica entità in grado di insegnare ad ognuno “non quello che ti occorreva per vivere, ma prima ancora, quello per cui valeva la pena vivere” (pag.231). Una final destination che tuttavia, lungi dall’essere vissuta con rispetto e senso del dovere, è spesso depauperata e bistrattata in maniera parassitaria, per poi finire abbandonata nel momento in cui si ritiene abbia offerto tutto quello che era nelle sue possibilità offrire (o in assenza di un feedback giudicato adeguato):
“(…) gli americani non amano molto questa città, non la ammirano, non la stimano, non credono in lei e non ne hanno molta fiducia” (pag.161)
“(…) suo fratello William a diciassette anni era separato dal mondo che lo conteneva solo da una membrana sottilissima. In altre parole, era un ragazzo di città fatto e finito” (pag.172)
“(…)perfino i bambini, dietro il riflesso della strada che fluttuava nel vetro, avevano imparato l’arte di fingere di non vedere” (pag.671)
Il problema dell’aderenza a un canone è un altro tema tipico del romanzo di Hallberg e in generale della letteratura US, e nasce dalla necessità di inserirsi in un gruppo sociale coeso, definito da determinati parametri all’interno dei quali occorre rientrare. Chiaramente, non essendo tutto assoggettabile al raziocinio, la ricerca di un’identità propria diviene spesso una corsa al raggiungimento di una perfezione assolutamente astratta che nel migliore dei casi porta a una pantomima di inganno e finzione in cui sogni e desideri si mescolano a dar vita a una storia ideale, che non è reale, (una delle parole chiave che forse si potrebbero usare per capire qualcosa di più su “Città in Fiamme” è “coreografia” [pag.90]) e nel peggiore a un immobilismo decisionale se possibile ancora più pericoloso:
“(…) aveva preso tutte le carenze del suo matrimonio e della sua vita e le aveva suste per dare forma a una fantasia” (pag.360)
Da qui, l’impossibilità di sostenere una felicità qualunque (specie l’altrui: “la vicinanza al fascino del successo” pag.232) e la spinta a crogiolarsi nel decadente collettivo, nel momento della presa di coscienza: quell’attimo in cui si comprende la banalità della propria esistenza. Il sogno americano si spezza, i figli scappati di casa tornano dai genitori (nota a margine: il tema del ritorno in famiglia è molto forte in questo ultimo periodo, complice anche la crisi economica che mina l’indipendenza dei giovani e il drastico calo di stima nei confronti dei celeberrimi campus universitari che a parte qualche rara eccezione da IVY League si sono dimostrati, negli anni, centri di aggregazione di scarsa qualità e poco utili allo sviluppo personale e professionale dei teenagers), ogni scelta personale è foriera di gravi conseguenze, a volte drammatiche. La verità è una sola e Hallberg non fa mistero della sua tesi: nella città in cui tutti corrono per farcela, qualcuno ci riesce ma qualche altro, inevitabilmente, no.
Conclusioni: 1- mi è sembrato di vedere un gatto (cit.)
Se vi assale improvvisamente una certa sensazione di
dejavu non preoccupatevi, siete in buona compagnia – ossia quella di tutte le persone che hanno pensato a
Donna Tartt dopo aver letto le prime dieci pagine di Hallberg.
In verità c’è solo da rassegnarsi, perché è squisitamente inutile sforzarsi di combattere le assonanze che per tutta la lettura di “Città in Fiamme” il vostro cervello continuerà a produrre con “Il Cardellino”.
C’è da dire che i temi in comune sono davvero tanti, dalla location, naturalmente, all’intersecarsi di molteplici vicende su più piani temporali sfalsati, alla questione della Grande Disgrazia: dall’adolescente Charlie – adottato, asmatico, sfigato – a Samantha Cicciaro – abbandonata dalla madre e cresciuta da un padre assente, fino ai fratelli William e Regan (per la serie: anche i ricchi piangono) – insomma tutti i personaggi della saga non fanno altro che porre l’accento su un tema che alla Tartt è sempre stato a cuore, quello della genitorialità disfunzionale. Sia “City on Fire” sia “The Goldfinch” sono prima di tutto storie di padri e di madri anormali, e poi storie di figli che con fatica e dolore cercano in qualche modo di rimettersi in piedi, pur portando sul proprio corpo le cicatrici di anni di indifferenza e abbandono. Ambito riguardo al quale la letteratura d’oltreoceano s’interroga ormai da tempo.
Ma se Donna Tartt con “Il Cardellino” riesce nell’impresa di creare e mantenere viva una pluralità di voci e d’esperienze, focalizzando l’attenzione specie sull’infanzia abusata (le pagine sulla permanenza californiana del giovane Theo Decker sono tra le più belle della letteratura contemporanea, per intensità del lirismo e veridicità dell’introspezione), non si può dire lo stesso di Hallberg, che nonostante un’analisi complessivamente buona del mondo infantile molto probabilmente ne esce penalizzato dalla propria età anagrafica, riuscendo a perforare il muro del cliché letterario soltanto a tratti e restituendoci una serie di personaggi da questo punto di vista scarsamente caratterizzati.
Conclusioni: 2- guardo da qui o guardo da là?
Difatti è stato evidenziato da più parti come il punto debole di “Città in Fiamme” stia proprio nella pluralità di situazioni e personaggi che Hallberg, al pari della Tartt, decide di presentare.
In primis c’è la questione del punto di vista, che tecnicamente si avvicina più a un interno multiplo ma che poi in certi casi scivola verso un esterno quasi onnisciente, creando qualche strappo nel continuum della lettura. Pongono anche qualche difficoltà anche le connessioni tra i personaggi che non sono sempre intuitive e necessitano di una lettura attenta e soprattutto continua – il che non è semplice, data la mole dell’opera. Ciò che tuttavia ha impegnato di più (ad esempio su Minima&Moralia, per quanto riguarda la critica italiana) è stata l’analisi dello stile: sono proprio le sue peculiarità – forbito, sia per sintassi sia per lessico, erudito – moltissimi riferimenti letterari espliciti e impliciti – e complesso, a crearne il limite, quello dell’uniformità e del livellamento, fino al paradosso di avere personaggi completamente antitetici (Reagan Hamilton-Sweeney e Samantha Cicciaro, ad esempio, o il reporter Groskoph a confronto con Mercer Goodman) che pensano, riflettono, agiscono e si esprimono secondo modalità molto simili. Un risultato che in alcuni punti risulta poco credibile.
Un’altra critica mossa all’opera è la sensazione di collage che si respira leggendo alcuni capitoli che, è evidente, sono stati composti in tempi diversi (Hallberg ha impiegato quasi 10 anni per concludere la stesura). Alcune parti risultano convincenti e ispirate, altre invece funzionano meno perché ridondanti e poco coese, altre ancora convincono poco a livello di intreccio che per certi avvenimenti risulta un po’ semplificato e poco verosimile. Questo in verità è un difetto anche del Cardellino la cui autrice però, forte dell’esperienza e di una trama più accattivante, riesce ad attenuare con risultati migliori rispetto a quelli di Hallberg.
Conclusioni: 3- #punkeverywhere
“Il punk era un dio geloso che non tollerava l’esistenza di altra musica al di fuori di lui” (pag.250)
“(…) il paese è sfinito, le multinazionali controllano le nostre menti, i politici sono dei criminali. Potrei citarti capitoli e versetti, ma per quello ci sono i libri e, comunque, tu sai che è così se no non saresti davvero un punk” (pag.352)
Anche qui si potrebbe discutere per ore riguardo all’idea di Hallberg in merito, che se da un lato fa indiscutibilmente del suo meglio per inscenare un movimento punk credibile e aderente all’originale, dall’altro non fa mistero della coolness che deriva da una contestualizzazione di questo genere:
“Ultimamente tutto quello che era anni Ottanta, tutto quello che veniva da downtown, aveva acquisito lo status di icona del millennio” (pag.954)
Il risultato di tutto ciò è un’inevitabile sospensione del giudizio. Tecnicamente è impossibile mettere in atto un qualsiasi meccanismo di immedesimazione riguardo alcuno dei protagonisti della saga: i leader della vicenda sono da un lato imprenditori facoltosi, ricchissimi e cattivissimi e i loro discendenti dei casi umani debosciati e lagnosi che trovano conforto o nella droga o nel sesso promiscuo o nelle nevrosi alla Woody Allen. Dal punto di vista della classe operaia i personaggi potrebbero far pensare a una morale Dickesiana ma risultano troppo stereotipati per essere credibili: dal reporter alcolizzato al detective sottostimato e poliomielitico, dall’operaio italiano immigrato, tutto birra e televisione, al professore afroamericano, colto e gay, vittima di apartheid e omofobia. Anche volendo lasciar da parte la questione dell’immedesimazione, ci si chiede dove stia quell’idea dell'”insegnare qualcosa” attraverso la letteratura di cui Hallberg si fa ambasciatore: perché si rimane un po’ con la sensazione che sia stato tutto un gioco: giocare al giornalista, al detective, al tossico punk, all’adolescente disadattato, alla MILF vittima di disturbi alimentari. Ma un bel gioco, si sa, è bello fino a che dura poco e fino a che si è in grado di smettere.
Buona lettura (perché, comunque, è da leggere).
NB: Doverosa lode merita la traduzione di Massimo Bocchiola: musicale, dinamica, sciolta e croccante.
Nota: il tweet di cui sopra #punkeverywhere fa riferimento alla mostra fotografica “Punk in Britain” che potete visitare ancora per una settimana alla Galleria Sozzani . Un buon modo per approfondire la questione, con i dovuti accorgimenti perché si fa riferimento appunto al movimento inglese e non a quello del cugino americano.


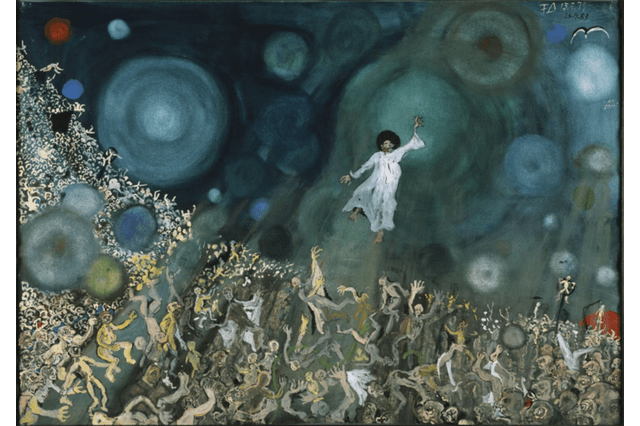

 Non c’è da fare nient’altro se non iscriversi a una delle biblioteche aderenti (al momento più di 5000), e poi tutto funziona come un normale prestito bibliotecario: si consulta gratuitamente l’offerta digitale della struttura di riferimento e si sceglie quello che occorre. Se quel che occorre non è al momento disponibile, si prenota, e poi le notifiche arrivano in email (ndr: per un testo ho aspettato… 1 giorno. Per un altro, molto richiesto e appena uscito, 4). Le opzioni sono molte, dai prodotti per la consultazione a quelli abilitati per il download, fino alle risorse open.
Non c’è da fare nient’altro se non iscriversi a una delle biblioteche aderenti (al momento più di 5000), e poi tutto funziona come un normale prestito bibliotecario: si consulta gratuitamente l’offerta digitale della struttura di riferimento e si sceglie quello che occorre. Se quel che occorre non è al momento disponibile, si prenota, e poi le notifiche arrivano in email (ndr: per un testo ho aspettato… 1 giorno. Per un altro, molto richiesto e appena uscito, 4). Le opzioni sono molte, dai prodotti per la consultazione a quelli abilitati per il download, fino alle risorse open. 







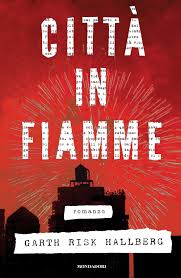 Due milioni di dollari di anticipo, la vendita dei diritti cinematografici in anteprima, un battage pubblicitario senza precedenti supportato dalle migliaia di copie spedite in anteprima a giornalisti e critici, l’endorsement di gran parte dell’establishment culturale americano. Novecentoundici pagine fitte, sostenute da un apparato iconografico che comprende riproduzioni di lettere scritte a mano, facsimili di fanzine anni ’70, pezzi giornalistici dattiloscritti, fotografie in collage – tutto materiale necessario all’economia della vicenda, di imprescindibile lettura.
Due milioni di dollari di anticipo, la vendita dei diritti cinematografici in anteprima, un battage pubblicitario senza precedenti supportato dalle migliaia di copie spedite in anteprima a giornalisti e critici, l’endorsement di gran parte dell’establishment culturale americano. Novecentoundici pagine fitte, sostenute da un apparato iconografico che comprende riproduzioni di lettere scritte a mano, facsimili di fanzine anni ’70, pezzi giornalistici dattiloscritti, fotografie in collage – tutto materiale necessario all’economia della vicenda, di imprescindibile lettura.













