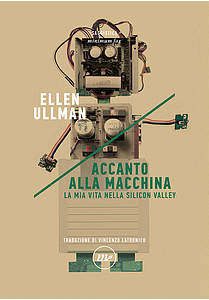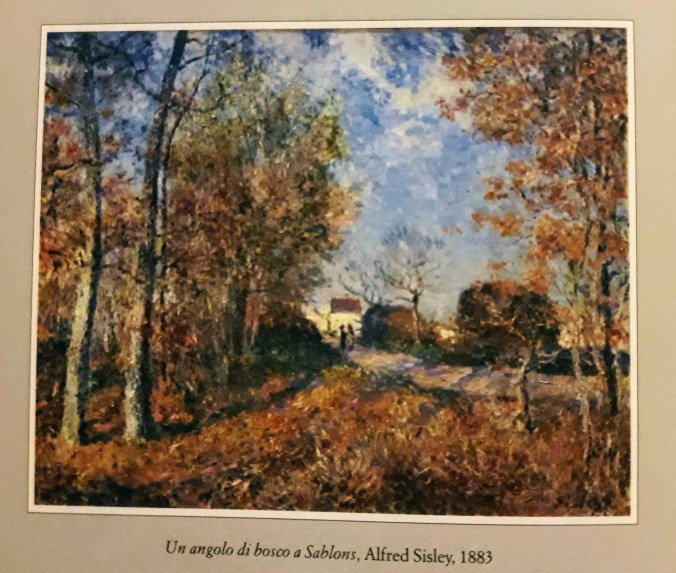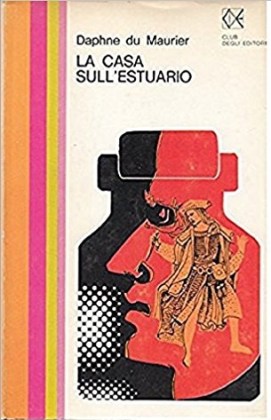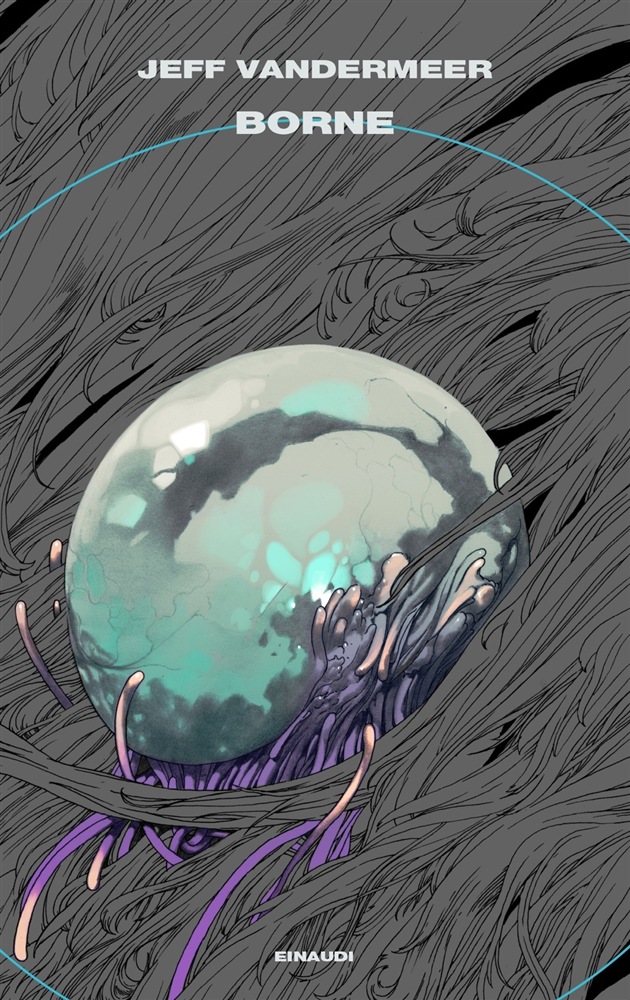“Mi dico che ormai siamo tutti collegati alla rete globale – non solo: ci siamo legati a essa, ne siamo dipendenti. E’ la nuova droga: l’istante, l’adesso, il globale” (“Accanto alla macchina – la mia vita nella Silicon Valley”, di Ellen Ullman – 1997, Minimum Fax 2018, Kindle 355)
“Le società tecnologiche stanno distruggendo qualcosa di prezioso, ossia la possibilità di meditare, poiché hanno creato un mondo nel quale siamo costantemente monitorati e continuamente distratti. (…) Il loro bene più prezioso è anche il nostro, ovvero la nostra attenzione, e loro ne hanno abusato” (“I nuovi poteri forti”, di Franklin Foer, Longanesi 2018, Kindle 159)
“In quanto umani, viviamo tra le rovine di uno splendore immaginato. Le cose non dovevano andare così: nel pacchetto originale non rientravano debolezza, vergogna, dolore, e neanche morte. Abbiamo sempre avuto un’idea ben più alta del nostro destino. Tutte le nostre disavventure – il giardino, il serpente, la mela, la cacciata – sono frutto di un errore fatale, di un crash di sistema” (“Essere una macchina”, di Mark O’Connell, Adelphi 2018, pag13)
Ho pensato molto a come affrontare questa materia oscura. Occorrerebbe la scienza di uno sguardo esterno, libero dal pregiudizio, mi dicevo. Cosa di cui io probabilmente difetto a causa di certi miei trascorsi professionali.
Basti dire che poco tempo fa mi capitò di dissertare amichevolmente proprio della discrepanza tra l’astrattezza rarefatta del codice e gli scopi pratici tutto fuorché astratti per i quali esso viene creato, con una persona di cui per ovvie ragioni non posso specificare nulla. Eravamo asserragliati dentro a un non-luogo simile a una conchiglia vetrificata, libera da qualsiasi contatto con la realtà esterna, identificata al suo interno da una quasi totale assenza di rumore, di suoni – finanche di TEMPERATURA. Dai vetri insonorizzati guardavo le gocce di pioggia strisciare sui parabrezza delle auto parcheggiate di sotto ma anche la pioggia mi pareva una realtà astratta, creata ad arte.
Un altro giorno della medesima estate, quella appena trascorsa, ho dovuto fare un lungo viaggio in macchina. Mi sono inoltrata nelle campagne di un nord Italia rovente. Ho passato quasi tre ore in autostrada, mi sono lasciata alle spalle una tangenziale suburbana e poi anche l’ultimo avamposto abitato – un grumo di casette a due piani, intonacate di arancione – per finire la mia corsa in mezzo al nulla dei campi di soia. O così pensavo, salvo poi comprendere che dentro certi capannoni che finalmente vedevo in lontananza e verso i quali dovevo dirigermi stava racchiusa una parte di quell’industria italiana e internazionale che progetta il nostro Futuro (…ma per un momento, un unico, piccolissimo istante, che il Cielo mi perdoni, ho pensato solo a “Toys” con buona pace di chi le convergenze evolutive le fa prendendo a benchmark Black Mirror).

Totalmente inadeguata quindi, per affrontare certi discorsi: forse la gente vuole qualcuno che critichi, mi dicevo, qualcuno che gliela canti, qualcuno che FACCIA OSSERVAZIONE – e quel qualcuno non sono certo io, dato che la prima reazione che ho avuto di fronte ai due casi di cui sopra, esemplificativi di un modo di fare business molto specifico, – reazione che in genere ho sempre, da 15 anni a questa parte, ogni volta che vengo a contatto con simili realtà professionali – è stata quella della stupefatta meraviglia. Siccome però c’era caso di doverne parlare, ho pensato che fosse il momento di rompere gli indugi: e forse anche lo stupore e la meraviglia possono essere un inizio.
.1 – “Accanto alla macchina – la mia vita nella Silicon Valley”, di Ellen Ullman (1997), Minimum Fax 2018
“Ho attraversato una membrana oltre la quale il mondo reale e i suoi fini perdono di consistenza” (Kindle 55)
Partite da qui, se volete capirne qualcosa di più sulla Silicon Valley e su chi – o su ciò – che l’ha creata. Partite dalla pioniera Ullman, che dopo un dottorato in materie umanistiche entra quasi per caso nel mondo della tecnologia high level, all’epoca ancora agli albori, e la sconvolge dall’interno scrivendo con “Close to the machine – Technophilia and Its Discontents“, un memoir che è anche un atto di accusa, oltre che una dichiarazione d’amore (quasi) incondizionato. Donna, over 30, ebrea, bisessuale, ex attivista politica, programmatrice – Ellen Ullman, da outsider qual era, per prima ha trovato il coraggio (e si è potuta permettere) di mettere in chiaro il rischio intrinseco a cui espone il lavoro esclusivo sulle stringhe di programmazione, ossia la depersonalizzazione.
“Gli eventi-macchina avevano più realtà, mi accompagnavano da più tempo, degli esseri umani seduti intorno a quel tavolo. Di colpo mi sono resa conto che il problema non era rimpiazzare una realtà con un’altra, ma il fatto che le realtà fossero due. Io ero lì, al confine: l’interfaccia fra il sistema, in tutta la sua esistenza, e le persone, in tutta la loro” (Kindle 172)
“Nel programmatore entrano a contatto il mondo per come lo comprendono gli umani e il mondo per come va spiegato a un computer: ma quello che si produce è uno strano stato di disgiunzione” (Kindle 270)
Di “Close to the machine” ne hanno parlato in tanti – gente molto più in gamba di me – e li trovate tutti qui. E tutti hanno sottolineato i pericoli in cui incorre chi fa dell’astrattezza del lavoro sui numeri il proprio core business, dimenticando così che alla fine quei numeri hanno una destinazione che rimane, prettamente e inesorabilmente, umana. Qualcuno poi è giustamente andato oltre, facendo notare di come il rapporto che verrebbe da definire speciale, elitario, tra la macchina e il suo programmatore (ma non solo: anche tra la Ullman stessa e i suoi collaboratori più stretti, mi vien da dire) sia qualcosa di prezioso, almeno nei suoi fondamenti, qualcosa che la Ullman trattene con sé e difende (con cognizione di causa evito di utilizzare il verbo “giustificare” sebbene mi sia venuto in mente per primo) in nome di un concetto altro, figlio di processi mentali, in specie di stampo socio-politico, nati e cresciuti ben prima dell’invenzione delle macchine stesse.
“Quando ero nel partito dicevamo spesso che il marxismo-leninismo era una *scienza*, e il partito la sua *macchina*. E quando il mondo non si adeguava alle idee che avevamo su di esso (…) reagivamo da programmatori. Ci avvicinavamo alla macchina. Dovendo avere a che fare con la confusione della vita umana, cercavamo di semplificarla” (Kindle 378)
E questo, ahinoi, non è che l’inizio della questione.
.2- “I nuovi poteri forti”, di Franklin Foer, Longanesi 2018
“L’algoritmo sarà anche l’essenza dell’informatica, ma non è esattamente un concetto scientifico. (…) Benché le sue origini siano evidentemente umane, la fallibilità umana non è tra le caratteristiche che tendiamo ad associare all’algoritmo. (…) Diamo per scontato che l’algoritmo sia privo di pregiudizi, intuizioni, emozioni o indulgenza” (Franklin Foer, “I nuovi poteri forti”, Longanesi 2018 – Kindle 1105)
 Franklin Foer, fratello dello scrittore Jonathan Safran, ha diretto per sei anni la rivista “The New Republic” ed è ora corrispondente del “The Atlantic”. Nel suo “World Without Mind: The Existential Threat of Big Tech” alcuni direbbero che “si scaglia” – io preferisco un più grezzo “se la prende” – contro/con tutto ciò che Ellen Ullman aveva potuto soltanto intuire ma non sperimentare appieno, dati i tempi: il monopolio tecnologico – in questo caso dell’informazione. Facebook, Google, Amazon, Apple: aziende che ci hanno venduto – o meglio ancora, regalato – i loro “prodotti” con il dichiarato intento di rendere migliore la nostra vita, facendoci guadagnare in efficienza e risparmiare tempo. Peccato che il dichiarato intento poi abbia portato con sé questioni che col miglioramento della nostra vita paiono aver poco a che fare.
Franklin Foer, fratello dello scrittore Jonathan Safran, ha diretto per sei anni la rivista “The New Republic” ed è ora corrispondente del “The Atlantic”. Nel suo “World Without Mind: The Existential Threat of Big Tech” alcuni direbbero che “si scaglia” – io preferisco un più grezzo “se la prende” – contro/con tutto ciò che Ellen Ullman aveva potuto soltanto intuire ma non sperimentare appieno, dati i tempi: il monopolio tecnologico – in questo caso dell’informazione. Facebook, Google, Amazon, Apple: aziende che ci hanno venduto – o meglio ancora, regalato – i loro “prodotti” con il dichiarato intento di rendere migliore la nostra vita, facendoci guadagnare in efficienza e risparmiare tempo. Peccato che il dichiarato intento poi abbia portato con sé questioni che col miglioramento della nostra vita paiono aver poco a che fare.
La parte a mio avviso più interessante di questo pamphlet è lo storytelling riguardo la nascita della Silicon Valley, che si compone per lo più – e il fatto degno di nota è che in pochi ormai ne sono a conoscenza – di temi politici e sociali.
“La brama di monopolio della Silicon Valley risale (…) alla controcultura degli anni Sessanta, all’interno della quale emerse dalla visione più poetica del concetto di peace and love. Per essere ancora più precisi, inizia con uno dei principi del movimento hippie” (Kindle 185)
Ad esempio, tra le altre Foer analizza nei dettagli la figura, controversa e carismatica, di Stewart Brand – uno dei punti di riferimento dei frequentatori del mondo psichedelico della penisola di San Francisco. Il dono di “Brand, figlio di un dirigente di un’agenzia pubblicitaria (…) fu quello di saper incanalare i desideri spirituali della sua generazione e poi spiegare come potessero essere realizzati dalla tecnologia. (…) Sviluppò un nuovo genere di pubblicazione, che conteneva qualcosa di simile a collegamenti ipertestuali ai testi di altri viaggiatori e, molto prima dei TED, creò un circuito di conferenze scientifiche. In questo modo Brand finì per ispirare una rivoluzione nel mondo informatico” (Kindle 208-209).
“Questo sogno di trasformazione, di un mondo curato dalla tecnologia e unito in un pacifico modello di collaborazione, trasmette un piacevole senso di innocenza. All’interno della Silicon Valley (…) quello che era nato come un sogno entusiasmante – l’umanità intera unita da una sola rete al di sopra di tutto – è diventato la base del monopolio. Nelle mani di Facebook e Google, la visione di Brand è divenuta un pretesto per la sopraffazione” (Kindle 213)
Per farla breve, diciamo che il punto di partenza di Brand fu il “tentativo di indurre artificialmente un senso di consapevolezza amplificata“. Cosa che più avanti lo portò ad “attribuire le stesse capacità di alterazione della coscienza ai computer” (Kindle 235). E’ un punto molto importante questo, perché è il cardine su cui dobbiamo far peso se vogliamo davvero capirne qualcosa (e sarà fondamentale più avanti, all’elenco che porta il numero 3):
“Nel suo manifesto, Brand riassumeva il pensiero del movimento delle comuni, e lo faceva avanzare sotto certi importanti punti di vista. Era stata la tecnologia, sosteneva, a creare i mali del mondo, e solo la tecnologia poteva risolverli. Gli attrezzi, tolti dalle mani di monopolisti e guerrafondai, potevano rendere gli individui più autosufficienti e liberi di esprimere se stessi. Gli strumenti di potere al popolo, insomma. Se alcuni di questi concetti sembrano familiari, è perché risuonano da anni in decine di pubblicità Apple”
Sicché, se da una parte la cultura che si respira ancora nella Silicon Valley, coi manager in t-shirt e le strutture organizzative a matrice all’interno delle quali (vivaddio!) non è così facile individuare i legami gerarchici (ma è molto facile individuare la catena delle responsabilità individuali, e non è poco), è derivazione diretta dello spirito della comune, dall’altra essa stessa, contemporaneamente, giustifica la necessità del monopolio convinta che un’eventuale concorrenza non sia di aiuto nella ricerca del bene universale.
“Le big tech ritengono che l’uomo sia fondamentalmente un essere sociale, fatto per l’esistenza collettiva, ripongono la loro fiducia nella Rete, nella saggezza della folla e della collaborazione, coltivano un desiderio profondo di porre rimedio all’atomizzazione della società. Ricucendo il mondo, lo cureranno dai mali che lo affliggono” (Kindle 75)
E questo, ahinoi (reloaded), è un altro, significativo pezzo dell’affaire Silicon Valley.
.3- “Essere una macchina”, di Mark O’Connell, Adelphi 2018
“A forza di informarmi, mi sono reso conto che del movimento non esiste una versione ortodossa, autorizzata, ma che chiunque vi aderisca condivide una visione meccanicistica della vita umana, in cui gli uomini si considerano dispositivi tenuti e destinati a inventare versioni migliori – più efficienti, potenti utili – di sé. (…) Definizione generale: il transumanesimo è un movimento di liberazione che rivendica nientemeno che una totale emancipazione dalla biologia. Esiste una concezione alternativa – uguale e contraria – secondo cui questa apparente liberazione sarebbe, in realtà, soltanto il definitivo e totale asservimento alla tecnologia” (p17-18)

Allora, facciamo un passo indietro. il giornalista irlandese Mark O’Connell, corrispondente di varie testate tra cui Slate e The Guardian, nel 2015 decide di impegnare una dozzina di mesi della sua vita, giorno più giorno meno, nello studio del movimento del transumanesimo. Quel che ne viene fuori è un reportage potentissimo, pubbicato in Italia da Adelphi, che indaga uno dei fenomeni culturali più sinistri e inquietanti della nostra epoca. Cosa questo abbia a che fare con l’affaire, è presto detto.
“Più approfondivo la questione, più mi rendevo conto di come il transumanesimo (…) esercitasse un’influenza molto forte sulla cultura della Silicon Valley, quindi più in generale sull’immaginario culturale legato alla tecnologia. Tale influenza mi pareva riscontrabile nella fanatica devozione di molti imprenditori della tecnologia all’ideale di una radicale estensione della vita: si pensi, ad esempio, ai fondi stanziati da Peter Thiel – cofondatore di PayPal e investitore in Facebook – in favore di svariati progetti per l’allungamento della vita, o a Calico, la sussidiaria biotecnologica di Google che si propone di trovare rimedi all’invecchiamento. E l’influenza del transumanesimo era percepibile anche negli ammonimenti sempre più accorati di Elon Musk, Bill Gates e Stephen Hawking sulla prospettiva di un annientamento della specie a opera di una superintelligenza artificiale, per non parlare del coinvolgimento in Google, come direttore dell’engineering, di Ray Kurzweil, il sommo sacerdote della Singolarità Tecnologica. (p19)
In “To Be a Machine – Adventures Among Cyborgs, Utopians, Hackers, and the Futurists Solving the Modest Problem of Death“, verrete edotti sulle più avanzate tecniche di estensione dell’aspettativa di vita e del suo potenziamento attraverso mezzi farmacologici e tecnologici, uploading della mente, tanatologia crionica, intelligenza artificiale, applicazione di protesi e manipolazioni genetiche. Comprenderete come mai, se è vero che le nostre aspettative “dipendono in larga parte da ciò che riusciremo a fare con le macchine”, la questione della cultura capitalistica (ecco, ci risiamo!) sia di fondamentale importanza insieme a quella della trickle-down economy tanto cara agli americani. Comprenderete anche quale siano le connessioni che collegano la “cultura del tecno-progressismo” (p59), nata e cresciuta all’interno della Silicon Valley, a tutta la Bay Area e il perché Elon Musk abbia “definito l’intelligenza artificiale *la più grande minaccia alla sopravvivenza dell’umanità*” (p92) all’interno di una riflessione più ampia, “tecno-darwinista“, secondo cui “mentre l’essere umano progetta la propria evoluzione, crea simultaneamente le condizioni per la propria obsolescenza” (p102). [Non per nulla il Future Life Institute, ente privato fondato tra gli altri anche da Jaan Tallin (Skype) ha recentemente ricevuto una donazione di 10 milioni di dollari proprio da parte di Musk, “per avviare un progetto di ricerca globale mirante a scongiurare la catastrofe che potrebbe essere causata dall’intelligenza artificiale” (p109)]. Per non parlare dello sforzo ormai ben noto di Amazon, che con l’Amazon Picking Challenge aveva messo in piedi una “gara di robot” che altro non era se non un’operazione di business volta a scoprire se qualche azienda fosse (già) in grado di sviluppare un robot capace di sostituire la manodopera umana all’interno dei magazzini. Farete la conoscenza di biohacker (detti anche “transumanisti pratici“) che scelgono di auto-impiantarsi pezzi sottocutanei di tecnologia capaci, a loro dire, di ampliare le “capacità sensoriali e cognitive del corpo umano” (p150) e capirete infine come mai, parlando di uploading della mente e di radicale allungamento della vita ci si trovi a fare i conti, alla fine, quasi più con una dimensione spirituale che con il vero e proprio progresso tecnologico.
“Il verbo *risolvere* riassume, a mio parere, l’ideologia della Silicon Valley secondo cui tutte le faccende della vita si possono suddividere in problemi e soluzioni: e le soluzioni consistono immancabilmente in una qualche applicazione della tecnologia. Che il problema sia ritirare i vestiti in lavanderia, districarsi tra le complessità delle relazioni sessuali o affrontare il fatto che prima o poi si morirà, possiamo trovare una soluzione. La morte, da questo punto di vista, non è più un problema filosofico: è un problema tecnico. E ogni problema tecnico prevede una soluzione tecnica” (pag197-198)
**
Cosa penso. • Penso che questo sia stato un viaggio incredibile – che per me non si può certo dire concluso. Né sui libri dato quel che c’è da leggere in merito (guardatevi la bibliografia citata da O’Connell e poi mi direte!) ma nemmeno fuori dai libri, dato che non credo – ma neppure lo spero, in verità – di aver chiuso qui con la SV per quanto riguarda la mia professione “fuori” dai libri. • Ringrazio Adelphi per l’invio di “Essere una macchina”. • E mi permetto anche altri tre ringraziamenti: il primo per Mr. Giuseppe Strazzeri, di Longanesi, che ha sopportato con dedizione le mie elucubrazioni notturne via Twitter su “World Without Mind”; il secondo e il terzo per la mia coppia di mentori Francesco Guglieri e Luca Albani.
ps. domenica 25 novembre 2018 torna Studio in Triennale. Tra gli altri, sarà presente anche Mark O’Connell.