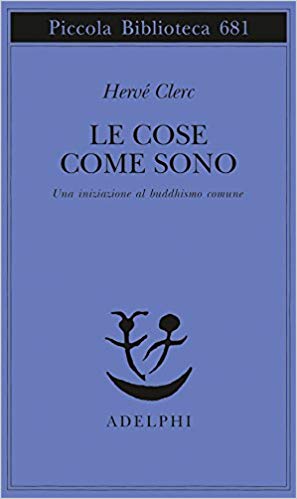Eh no, non ha funzionato. Questo è il libro delle occasioni mancate. L’evento è più unico che raro su ADC e spiace, è accaduto.
Nessuna introduzione. Si parte così.
Ho trovato l’impianto narrativo di “Maternità” scarsamente funzionale, un miscuglio di generi che, se ben fatto, avrebbe potuto costituire un punto di partenza brillante al fine della narrazione del sé: diario, memoir, cronaca familiare, saggio. Peccato che di questi, Sheila Heti ne prenda il peggio.
Del diario non c’è la sistematicità cronologica, in certi punti francamente sconclusionata (esempio: alla fine del libro la protagonista dice di essere diventata vecchia e infertile ma poi più avanti specifica di aver appena passato la quarantina: da quando si diventa sterili a quarant’anni?). Il memoir (e cronaca familiare, esempio le vicende accadute alla nonna materna, vittima dello sterminio nazista) è un terreno sul quale l’autrice prima arranca e poi si perde quasi come se non le interessasse, mi vien da dire. Del saggio c’è l’idea, una sottotrama di encomiabile e necessaria denuncia sociale (esempio: l’identificazione della donna che ancora oggi avviene troppo spesso solo attraverso il diventare madre) che però viene vanificata nella sua credibilità dall’estrema soggettività dello sguardo, di aspetto clinicamente disturbato, e dalla figura del compagno della scrittrice/protagonista che presenta alcune criticità a mio parere oggettive, di incongruenza strutturale.
***
Il libro è stato presentato come un esempio di approccio rinnovatore all’argomento tabù della maternità autonegata. Il problema è che in “Maternità” di maternità si parla poco e per altro, quando avviene, in maniera abbastanza banale. Il titolo in sé è fuorviante perché in realtà quello a cui il lettore assiste non è un riflettere sulla condizione childfree e sulle dinamiche che hanno portato a questa scelta quanto alla mera narrazione di una parte della vita della scrittrice/protagonista (dai 30 ai 40 anni, a spanne) all’interno della quale Sheila Heti fa affrontare a se stessa/alla protagonista tutti i temi propri di quell’età: la carriera, il diventare adulti, le relazioni sentimentali, la sessualità e, certo, la maternità. Fatto sta che il libro avrebbe potuto camminare da solo anche se l’editor gli avesse cambiato intestazione (“La coscienza di Sheila”, per dire, o “Sheila & Miles, cronaca di una dipendenza”, o anche, che so, “L’odio del corpo”). Anzi penso che da parte dell’editore sarebbe stato più onesto cambiarglielo davvero, il titolo. “Motherhood” avrebbe funzionato soltanto in un caso: laddove si fosse inteso come “maternità” qualsiasi frutto di qualsiasi tipologia di parto, quindi inserendo tra i “parti” anche le produzioni intellettuali e gli sviluppi del pensiero personale, di qualsiasi tipologia. Ma sinceramente non credo proprio – forse sono in malafede – che il progetto sotteso fosse questo.
Mi resta difatti la sensazione di essere stata presa in giro da un’abile operazione di marketing – che sta alla base, dentro la scrittura della Heti, non tanto al livello successivo dell’editing e della pubblicazione: diciamocelo, in un’epoca di nuovi femminismi e di mee too, scrivere un libro di autofiction, intitolarlo “Maternità” e suggerire che al suo interno verranno trattati temi childfree ha sicuramente il suo perché.
E qui arriviamo agli argomenti: già, peccato appunto che di maternità se ne parli davvero poco e per mezzo di approcci che non riescono a ottenere la necessaria credibilità. Da una parte alcune riflessioni sfiorano la banalità di un discorso tra sedicenni (della serie: non voglio essere madre perché a un figlio bisogna dedicare tutto il proprio tempo – ma dai, davvero?) e non apportano sostanziali novità al dibattito in corso sulle dinamiche importantissime dell’influenza che il giudizio sociale ancora oggi possiede. Dall’altra la scrittrice/protagonista si dimostra una donna dal vissuto certamente ricco ma intensamente fragile e nevrotico; un contesto che produce spesso riflessioni e situazioni – finanche di vero e proprio delirio paranoico – nei confronti delle quali è difficile che si attivi il processo di immedesimazione ma nemmeno quello della com-passione anche a causa di alcune criticità etiche che a mio parere non sono da sottovalutare. (Ad esempio la scelta di non volere figli e nel contempo quella di rifiutare l’utilizzo di qualsiasi anticoncezionale a parte la pillola del giorno dopo che viene assunta con la stessa frequenza di un’aspirina – quando anche solo dal punto di vista della farmacologia si tratta, lo sappiamo tutti, di un medicamento che va utilizzato con cautela poiché non privo di effetti collaterali. Oppure la fissazione che la scrittrice/protagonista ha nei confronti della chiromanzia, o l’utilizzo del metodo dell’I-Ching in maniera del tutto disgiunta dalla filosofia millenaria a esso sottesa, minimizzandone la portata: “Nelle pagine che seguono vengono usate tre monete: tecnica ispirata all’I-Ching, ma non corrispondente al vero I-Ching, che è qualcosa di diverso” -pag9 – qualcosa di molto diverso, cara Sheila).
***
“…con tutte le bugie che il corpo racconta alla mente, e tutti i brutti scherzi che gli fa. Assicurarmi che il corpo non mi faccia più scherzi (…)” (pag120)
[NB: Il fatto che la protagonista sia una personalità borderline che abbisogna di supporto psicoterapeutico non lo sto inventando io ma lo conferma lei stessa quando, a circa tre quarti del volume (attenzione, spoiler!) afferma di aver dato una svolta alla propria vita per mezzo degli psicofarmaci, grazie al cui effetto ora può vedere la negatività e l’incongruenza di alcune posizioni sostenute in precedenza (posizioni che, ricordo, il lettore si è dovuto sciroppare per almeno metà libro: ops, scusate, ero depressa, soffrivo di paranoie: ho detto delle cavolate, cancellate tutto!)]
***
“Svegliandomi ho detto a Miles: Magari sarebbe bello avere un figlio. Lui ha risposto: Sicuramente è molto bello anche farsi lobotomizzare. Tutta la fatica che ho fatto in questi anni per diventare il tipo di persona per cui riesce a provare rispetto, dice che significherebbe buttarla a mare; quando la cosa più difficile nella vita è diventare qualcuno” (pag131)
“Vedi? Non è una cosa sana, questa pressione che ti mettono le. tue amiche per farti fare un figlio. Ti vogliono sulla loro stessa barca. Vogliono che tu abbia il loro stesso handicap. Ha ripetuto che è un gioco che non vale la candela, essere genitori. L’ha definito la più grande truffa di tutti i tempi” (pag186)
Chi oppone più resistenza all’idea di diventare genitore è Miles, il compagno della scrittrice/protagonista. Ho parlato sopra di incongruenza strutturale del personaggio, spero di riuscire a spiegare il perché.
Miles, affermato avvocato 40enne, è spregiudicato nelle proprie affermazioni; rivela un profondo disprezzo per la questione maternità e una completa incapacità di empatia nei confronti della compagna che, questo va convenuto, sta affrontando un visibile e profondo disagio. Eppure, se ciò non fosse già sufficiente per dargli il benservito, il problema è un altro ancora. Il fatto è che Miles non vuole figli perché lui (attenzione, spoiler!) una figlia ce l’ha già. Avuta per sbaglio in giovane età, certo; cresciuta dalla madre, chiaro; ma ce l’ha. Con lei va in vacanza, sta al telefono, passa i week end; le paga gli alimenti, si interessa dei suoi hobbies. Ora, genitori all’ascolto: quanti di voi non hanno mai risposto “no, grazie, siamo a posto così” a chi vi chiede “fate il maschio?”, oppure “non volete altri figli?”. Perché è vero: dopo uno, o due, magari dopo il terzo o il quarto figlio – ma alla fine quel “siamo a posto così” arriva. Quindi, caro Miles, non raccontarcela. Tu, come diciamo noi madri di figli ormai grandicelli, “hai già dato” – e limitando la tua compagna nella riflessione sul perché vorrebbe dei figli, suggerendole non la tua opinione ma il tuo insindacabile volere, non fai altro che impegnarti nella conservazione del tuo status quo – in maniera del tutto disonesta perché tu, quell’esperienza, l’hai già fatta.
Di conseguenza, anche le affermazioni di Miles riguardo l’ingiustizia sociale che tocca quelle donne che decidono coscientemente di non aver figli finiscono nel calderone di quel che poteva avere un senso, se solo espresso meglio; se solo non fossero state inficiate da interessi personali che ne minano l’autenticità.
Disonesto a mio parere è anche il modo in cui il lettore viene trascinato e costretto a leggere di argomenti che con la “maternità” c’entrano ben poco; mi riferisco in specie alle frequenti scene di sesso spinto/sogni erotici (infarciti di termini volgari e descrizioni molto crude), che non sono in se stessi il male dell’universo, sia chiaro, ma di cui non si comprende il significato all’interno della narrazione. Forse l’intento dell’autrice era la dimostrazione della profonda intesa fisica e mentale della coppia: niente di più corretto. I mezzi a disposizione sarebbero stati molti e ancora una volta peccato, perché Sheila Heti ha scelto, di nuovo, quelli sbagliati: parlare di rapporti sessuali durante il ciclo mestruale con tanto di descrizione particolareggiata dei fiumi di sangue che copiosi allagano la camera da letto, o di penetrazioni anali poco consenzienti, o di sesso a tre non mi è parsa una grande idea, non tanto perché voglio gridare allo scandalo, figuriamoci, ma perché mi sembra una trovata degna che so, dei primi anni Novanta, o dei più recenti mum-porn alla cinquanta sfumature (NB: di target femminile… Una buona occasione per parlare ai maschi – di nuovo sprecata).
***
Appunto, parliamo della vecchiezza di questo testo. Sheila Heti sembra incastrata non soltanto nel personaggio Sheila Heti ma soprattutto in un tempo che ormai ha fatto la propria storia. Questo interrogarsi, chiudersi in casa a tende tirate, far muffire la roba in frigo, crogiolarsi nella recitazione della parte dell’intellettuale tormentata che non cucina e non lava i panni, spendere ore e ore a parlare con l’amica delle proprie nevrosi, avvolti dal fumo delle sigarette… ecco, questo modo di raccontarsi ha fatto il proprio tempo. Era Woody Allen il sovrano indiscusso dei monologhi “dell’analista”. Il terapeuta, la seduta, la sigaretta, le pillole (non “pastiglie”, no, proprio “pillole”) lui che piegato su se stesso, camicia bianca e maniche flosce, finge di balbettare ma io – ma io… Sembra quasi che Sheila Heti si sia dimenticata, di come tutto questo sia blasé.
Si parlava recentemente su Twitter dei romanzi millennials, in specie autofiction, e ci si domandava come mai questo tipo di narrazione da noi non riesca a prendere piede. Ho pensato che forse è il nostro Novecento, ad averci salvato. Gli americani, di struttura dimenticano. Il proprio passato, le radici, le eredità della Storia. Lo dimentica anche Sheila Heti (anche se è canadese!) come mi è stato fatto notare su Twitter, perché dei suoi illustri predecessori, quelli che avrebbero potuto darle una gran mano nella stesura di questo testo – che come idea, mi preme ricordare, non era affatto male – non gliene può fregare una beata.
Noi per fortuna non dimentichiamo e quindi non possiamo fare a meno, per quanto riguarda il romanzo psicologico novecentesco, di fare i conti con autori del calibro di Svevo, Moravia, D’Annunzio – per dirne solo alcuni. Personalità complesse con cui è molto difficile se non impossibile confrontarsi alla pari. E menomale.
Stavolta il buona lettura non c’è. Ciò non toglie che possiate cimentarvi ugualmente, a leggere “Maternità”. Non ho la presunzione di dir male di un libro e pensare che il mio dir male sia definitivo. E’ stato definitivo per me – ciò non vuol dire che lo debba essere per tutti. Mi scuso con Sellerio: mi dispiace sempre criticare un testo perché so quanto lavoro c’è dietro, quanto entusiasmo e quante scommesse. Mi capita di leggere libri che non funzionano e scelgo di non parlarne; a tutto però c’è l’eccezione e per me capita quando il libro, che ha in sé un potenziale distruttivo per via del semplice fatto che può essere venduto, letto e divulgato, passa a mio parere messaggi incongrui e distorti. “Maternità” non parla di maternità, parla di disturbo mentale. Ed è giusto che il lettore lo sappia prima di cominciare la lettura.
Non tutte le donne childfree sono donne insolute, dalla personalità borderline, che abbisognano di un supporto psicologico e farmacologico per affrontare questo e altri passi della loro vita e che hanno per compagno un uomo misogino e indifferente al dolore altrui. Vivere childfree è una scelta alla pari con quella dell’avere figli – entrambe possono e dovrebbero essere fatte in serenità e sentimento reciproco.