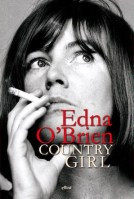lettura lenta
"La Collina", di Andrea Cedrola e Andrea Delogu
 |
"1913, l’anno prima della tempesta", di Florian Illies
"Promettimi che ci sarai", di Carol R. Brunt

Con lievità, ecco come a volte si riesce a parlare della morte.
(Un unico appunto: il titolo originale “Tell the Wolves I’m Home” – maiuscole comprese – ci piaceva assai – di più)
"Storia delle terre e dei luoghi leggendari", di Umberto Eco
#storiadelleterreedeiluoghileggendari | NPoussin Primavera o paradiso terrestre | p162 @libribompiani pic.twitter.com/fyFOHx1XXL– Appunti di carta (@appuntidicarta) 26 Dicembre 2013
//platform.twitter.com/widgets.js
#storiadelleterreedeiluoghileggendari | Thule, Olaus Magnus, Charta Marina 1539 | @libribompiani pic.twitter.com/SjWASIH31y
— Appunti di carta (@appuntidicarta) 26 Dicembre 2013
//platform.twitter.com/widgets.js
#storiadelleterreedeiluoghileggendari | Louis de Caullery Il colosso di Rodi XVIIsec | p83 @libribompiani pic.twitter.com/GkSbD2ovS7
— Appunti di carta (@appuntidicarta) 26 Dicembre 2013
Buona lettura 🙂
//platform.twitter.com/widgets.js
"La fabbrica dei cattivi", di Diego Agostini
Il protagonista è separato dalla famiglia che avrebbe dovuto raggiungere di lì a poco (la moglie Mara e i due figli, Giulia, cinque anni e Lorenzo, dieci, si trovano addirittura all’estero), immobilizzato a letto, circondato da flebo e monitor: per il momento è completamente ignaro delle sue reali condizioni di salute. Mentre attende con angoscia crescente – e oppresso da un forte senso di claustrofobia – che i medici svolgano le analisi adeguate non può fare altro, date le circostanze e le similitudini (poi si capiranno quali), che tornare con la mente alle vicende drammatiche che hanno interessato proprio la sua famiglia nell’anno appena trascorso.
Già preda della suspance di conoscere il destino di Alex, effettivamente appeso a un filo, ci immergiamo quindi in questa lunga, lunghissima rievocazione di un evento passato che sembra aver lasciato segni indelebili nella psiche (e forse anche nel fisico, ci viene da pensare) del protagonista stesso.
Alex e Mara sono una coppia di estrazione sociale medio-alta. Fanno parte dell’upperclass europea laureata, poliglotta, benestante, esterofila. Quarantenni in buona salute e forma fisica, svolgono una professione creativa e di prestigio che consente un tenore di vita oggettivamente alto. Hanno due bambini, un maschio e una femmina, vivaci, esuberanti ma beneducati e responsabili per quanto l’età lo consente.
Tuttavia, qualcosa va storto. Durante la vacanza oggetto del flashback, capita che la famiglia, un pomeriggio, venga sorpresa in spiaggia da un forte temporale. Si riparano tutti in auto e si recano in fretta in un mall poco distante per acquistare degli indumenti asciutti. Nel tragitto, Giulia si è addormentata legata al seggiolino; quindi il papà, non volendo interrompere il suo riposo, parcheggia il monovolume e rimane con lei. Dopo poco però Mara lo chiama nel negozio: ci sono problemi con la carta di credito. L’auto è all’ombra, la temperatura mite dato il brutto tempo, Giulia dorme tranquilla e sarebbe meglio lasciarla continuare, anche su consiglio del pediatra, perché se la si sveglia con troppa energia è vittima di attacchi isterici – comuni a tanti bambini – che poi si risolvono con molta difficoltà. Alex allora decide, non senza preoccupazione, di lasciare la piccola da sola in macchina qualche minuto, il tempo necessario per entrare al negozio (da cui cerca di non perdere di vista l’auto nemmeno per un secondo) e risolvere l’imprevisto. Tempo sufficiente perché qualcuno, avendo assistito alla scena, chiami immediatamente le forze dell’ordine, che arrivano sul posto in pompa magna: auto della polizia, pompieri, detective preposto all’analisi del caso, finanche una troupe televisiva. I tutori della legge si fanno strada tra la folla sempre più fitta accalcatasi intorno alla vettura. I cristalli della macchina vengono infranti, il portellone divelto, la bambina estratta dall’auto ancora legata al seggiolino e portata (naturalmente in lacrime per lo spavento) di corsa all’ospedale per delle analisi. Alex è rinchiuso a forza nella macchina-prigione dello sceriffo: i genitori di Giulia vengono accusati di abbandono di minore, arrestati e imprigionati. Secondo le imputazioni a loro carico, i bambini rischiano addirittura di essere dati in affido.
"Il bordo vertiginoso delle cose", di Gianrico Carofiglio
"Ida" – "Legami di sangue", di Irene Némirovsky
– Ida, in “Marianne”, 82, 16 maggio 1934; ripreso in Films parlés, “Renaissance de la nouvelle”, Gallimard, Paris, 1934
"Atti mancati", di Matteo Marchesini
 Il viaggio raccontato in “Atti mancati” è una cruda e lineare presa di coscienza: uno strumento di analisi personale, e professionale, che rispecchia al meglio i tempi in cui ci tocca vivere.
Il viaggio raccontato in “Atti mancati” è una cruda e lineare presa di coscienza: uno strumento di analisi personale, e professionale, che rispecchia al meglio i tempi in cui ci tocca vivere."Il weekend", di Peter Cameron
 Cameron insegna al lettore l’arte della lettura lenta e continua. A concedergli fiato, frammentandola, ci pensa lui. Placido – ma risoluto – ti ordina di seguirlo.
Cameron insegna al lettore l’arte della lettura lenta e continua. A concedergli fiato, frammentandola, ci pensa lui. Placido – ma risoluto – ti ordina di seguirlo.
“The weekend” è un’opera acerba (la prima edizione è del 1994), a tratti destrutturata, ma contiene in sé già tutti i germogli che andranno poi a comporre, maturati a frutto, le narrazioni successive.
Primo tra tutti, il gusto per il dipinto di atmosfera che tanto piace all’autore, utile e futile allo stesso tempo.
Sono i passi che più abbiamo condiviso su Twitter:
“Questa e’ l’ora del giorno che preferisco” disse Lyle. L’imbrunire in piena estate. Il mondo sembra molto perfetto, vero?” #theweekend
— Appunti di carta (@appuntidicarta) July 2, 2013
//platform.twitter.com/widgets.js
“Lyle tornò tenendo in mano la lampadina come se fosse una rarità. Era smerigliata, di un tenue rosa conchiglia. <> disse. Tolse alla lampada il paralume di carta marrone e fece il cambio. La stanza si accese di un colore rosato” (p30)
“Per un’estate va bene – rispose Laura – ma ha quella terribile aria da casa in affitto” (…) “Hanno portato via tutte le cose decenti. Ho dovuto comprare delle lenzuola di cotone e della cristalleria. C’erano i bicchieri di plastica” (p49)
Nelle descrizioni degli ambienti predominano le nuance pastello, uno shabby-chic molto retrò che spazia dal rosa confetto, alle mille gradazioni del giallo (“Il colore delle pareti […] una sfumatura delicata ma brillante, come il burro genuino” – p67) , al color acquamarina (p119) di bagni e piscine – onnipresente la dimensione liquida e fredda che Cameron associa, come caratterizzante, alla stagione estiva, malinconica e sensuale allo stesso tempo: dagli specchi d’acqua assoggettati e ricreati ad arte dall’uomo (“<>” – p125) a quelli selvatici, dal fascino potente e inconscio: “Non poteva dire che il fiume fosse più bello di mattina, anzi, c’erano certe sere quiete in cui veniva da piangere a guardarlo: prendeva un colore viola e sembrava fermo, come un livido in fondo al prato. Scorreva profondo e freddo e determinato, limpido e tonificante” (p11)
I passi narrativi, per la maggior parte impiegati in descrizione d’ambiente, creano quasi sempre uno scostamento percettivo: si tratta spesso di inserti creati ad arte all’interno di una scena o di un dialogo serrato e pregnante tra i protagonisti. Quasi come se le questioni si facessero troppo personali, l’autore entra in campo lungo ristabilendo le giuste, e civili, prospettive, come a voler in qualche modo preservare l’intimità e la privacy dei suoi protagonisti, limitando il lettore nella sua conoscenza di fatti e personaggi.
Altro tratto caratterizzante della narrazione, ancora in fieri (e per questo forse ancora troppo accentuata ed evidente), è l’attenzione per quella patina di teatralità, glassata e zuccherosa, o cupa e dirompente, con cui tutti noi, a volte, amiamo dipingerci la vita e su cui lo scrittore Cameron riflette, con disincantata autoironia (usufruendone e, allo stesso tempo, criticandone l’utilizzo):
“Voleva toccarlo di nuovo, accarezzargli la pelle tesa e levigata dell’avambraccio, ma gli parve un gesto eccessivo, troppo consapevole, scontato. Sembrava un’indicazione di scena in un’opera teatrale: (Lyle tocca il braccio di Robert)” (p19)
“<> (…) <>” (p22)
“Durante la partita, con la mazza in una mano e il cocktail o la sigaretta nell’altra, sembrava indifferente, senza una tattica, distratto, ma verso la fine metteva da parte il bicchiere o il tabacco e in pochi colpi concludeva vittorioso la partita. Letale! esclamava, sono letale!” (p60)
“<>” (p66)
“Basta che la conversazione passi dal particolare all’astratto, pensò Marian, e stai sicura che avrai l’attenzione di Lyle. (…) <> <>. <<Quindi tu parli dell’arte narrativa? (…) Ma quella è una forma morta” (p70)
“<> <> rispose lei. <> <> <> <>” (p170)
Cameron in “The Weekend” riflette. Sui rapporti umani prima di tutto, come di consueto nelle sue opere, nelle quali non si può dire di certo che l’azione prevalga sul momento riflessivo, di cui essa è spesso soltanto un pretesto. E su quelle convenzioni sociali che regolano le relazioni interpersonali e a cui, volenti o nolenti, ci troviamo a dover sottostare:
“<> disse Robert. <<Be’, non credo che oggi si possa vivere diversamente, a meno di non essere degli idioti. Ma è una seconda natura, una corazza che copre quella vera” (p130)
“Te l’ho detto che i weekend in campagna con gli eterosessuali possono essere un pericolo per la salute mentale. E’ stato orribile? Avete mangiato hamburger e giocato a croquet?” (p165)
Il mondo di Cameron è un raffinato gioco di scatole cinesi, amaro e commovente: sotto le maschere da teatro che comunemente indossiamo e che –crediamo – ci differenziano l’uno dall’altro rendendoci unici e speciali (l’ereditiera italiana di mezza età, la di lei figlia attricetta hollywoodiana, il gay critico d’arte, la coppia di eterossessuali rigidamente NewYorkesi…) vivono e bruciano i medesimi sentimenti: il timore di non essere amati abbastanza, l’angoscia per il senso della vita, l’amore filiale che porta con se, più che felicità e senso di appagamento, l’ansia e le preoccupazioni per il futuro, nostro e di chi ci sta accanto.
“Ci sono cose che si perdono e non tornano indietro; non si possono riavere mai più, se non nella copia carbone della memoria. Ci sono cose a cui sembra impossibile rassegnarsi ma a cui rassegnarsi è inevitabile. Lo scorrere dei giorni leviga il dolore ma non lo consuma: quello che si porta via è andato, e poi si resta con un qualcosa di freddo e duro, un souvenir che non si perde mai. Un piccolo bassotto di porcellana delle White Mountains. Una marionetta del teatro delle ombre di Bali. E guarda: un calzascarpe d’avorio di un hotel a quattro stelle di Zurigo. E qua, come un sasso che porto ovunque, c’è un pezzetto di cuore altrui che ho conservato da un vecchio viaggio” (p159-160)
Vi invito a leggere le belle cose scritte, a riguardo, da @FNall.
Buona lettura 🙂