
“In un mondo sostanzialmente alterato, un mondo in cui l’innalzamento del livello dei mari avrà inghiottito le Sundarban e reso inabitabili città come Kolkata, New York e Bangkok, i lettori e i frequentatori di musei si rivolgeranno all’arte e alla letteratura della nostra epoca cercandovi innanzitutto tracce e segni premonitori del mondo alterato che avranno ricevuto in eredità. E non trovandone, cosa potranno, cosa dovranno fare, se non concludere che nella nostra epoca arte e letteratura venivano praticate perlopiù in modo da nascondere la realtà cui si andava incontro? E allora questa nostra epoca, così fiera della propria consapevolezza, verrà definita l’epoca della Grande Cecità” (p18)
.1 Intro: di chi parliamo quando parliamo di Amitav Ghosh
Il saggio più recente di Amitav Ghosh, presentato in traduzione italiana il maggio scorso in occasione del Salone del Libro, è tratto da una serie di lezioni che lo scrittore indiano ha tenuto meno di due anni fa alla University of Chicago. Parlare di Amitav Ghosh significa avere a che fare con il più grande scrittore indiano di lingua inglese e con tutti i suoi romanzi, da “Il cerchio della ragione” (Garzanti 1986) a “Il paese delle maree” (Neri Pozza 2005) fino alla “Trilogia della Ibis” (Neri Pozza 2008-2015) – ma anche confrontarsi con un antropologo di formazione internazionale (nato a Calcutta nel 1956, figlio di un diplomatico, laureato in antropologia sociale a Delhi, specializzato poi a Oxford) un professore di scrittura creativa della Columbia University e columnist del New Yorker. Tutto questo insieme.
A parlare di #climatechange Ghosh ci arriva potremmo dire per caso(*), seguendo tuttavia un filo rosso che di casuale, come si vedrà, ha proprio ben poco. “Rifugiato ambientale molto prima che si coniasse tale definizione” (p10 – ndr: i genitori erano originari di un villaggio sulle rive del fiume Padma, nel Bangladesh, che all’improvviso deviò il suo corso e sommerse l’abitato), durante la stesura de “Il paese delle maree” mentre studiava approfonditamente l’ecosistema delle foreste di mangrovie che ricoprono le isole Sundarban, nel delta bengalese, venne a scoprire due fatti: il primo, che le modifiche geologiche a cui la zona era sottoposta stavano diventando sempre più irreversibili – all’interno di un sistema dinamico “che non si limita ad esistere, ma [è] esso stesso protagonista” (p12); il secondo, la sua totale incapacità di “tradurre in forma narrativa queste intuizioni(*)” (p13).
Da qui alla riflessione sul ruolo della letteratura contemporanea nel racconto dei cambiamenti climatici il passo è breve – ma consistente, perché “La grande cecità” non è altro se non la denuncia della più totale e completa disfatta del genere di fronte a quell’impensabile rappresentato oggi dal climate change.
“Sono arrivato a convincermi che le sfide che il cambiamento climatico pone agli scrittori contemporanei, per quanto specifiche sotto certi aspetti, siano anche dovuti a qualcosa di più antico e profondo; e derivino in ultima analisi dalla griglia di forme e convenzioni letterarie che hanno modellato l’immaginario narrativo proprio nel periodo in cui l’accumularsi di anidride carbonica nell’atmosfera stava riscrivendo il destino della terra” (p13)
.2 “La Grande Cecità: il cambiamento climatico e l’impensabile”
Nella prima parte del saggio, intitolata “Storie”, Ghosh si confronta con il concetto stesso di narrativa contemporanea e in special modo con quello di romanzo partendo da un insindacabile assunto: non esiste alcuna forma letteraria a parte la saggistica e la narrativa di fantascienza che ad oggi abbia affrontato con successo il tema del cambiamento climatico: “(…) se certe forme letterarie sono incapaci di vedersela con simili flutti, significa che hanno fallito, e i loro fallimenti dovranno essere visti come un aspetto del più generale fallimento immaginativo e culturale che sta al cuore della crisi economica” (p14)
Le motivazioni sono endogene e vanno cercate per Ghosh all’interno della struttura stessa del romanzo moderno che a differenza delle narrazioni antiche (dai poemi epici al “Le mille e una notte”) ha via via cessato di “compiacersi dell’inaudito e dell’imprevedibile” (p23) per rifugiarsi nella confortante, borghese presumibilità del quotidiano, “razionalizzandosi” (p26). Però, ahinoi, la verità è un’altra, perché “il romanzo moderno, a differenza della geologia, non è mai stato costretto a fare i conti con la centralità dell’improbabile” (p30). Fino a ora.
“(…) il calcolo delle probabilità è diverso a seconda che lo si faccia all’interno del mondo immaginario di un romanzo o fuori da esso; perciò si usa dire: – se questo accadesse in un romanzo nessuno ci crederebbe. Tra le pagine di un romanzo, un avvenimento non troppo improbabile nella vita reale (…) può apparire del tutto inverosimile, e lo scrittore dovrà mettercela tutta per sembrare convincente. Se ciò vale per i casi fortuiti, si pensi quanto più duramente dovrà impegnarsi lo scrittore per allestire una scena del tutto improbabile anche nella vita reale” (p31)
E che cosa c’è di più improbabile – e spaesante – ai nostri occhi, del cambiamento climatico? Non per nulla Ghosh fa riferimento esplicito ai limiti che in questo senso ha irrimediabilmente incontrato la “scrittura ecologica“, mettendola di necessità in correlazione con un’altra questione: quella del #NewNatureWriting, e del #NewWeird (ndr: che non nomina mai esplicitamente).
La questione è complessa e interessa anche, ad esempio, la decontestualizzazione spaziale a cui è soggetta tanta parte del romanzo contemporaneo (quando invece “il senso del luogo è notoriamente una delle grandi magie della forma romanzo” – p68) verso cui invece il cambiamento climatico costringe nuovamente lo sguardo:
“A quanto pare, (…) gli eventi spaesanti e improbabili che battono alle nostre porte sembrano aver stimolato una sorta di riconoscimento, la consapevolezza che gli esseri umani non sono mai stati soli, che siamo sempre stati circondati da una molteplicità di creature che condividono con noi capacità che consideravamo precipuamente nostre: volontà, pensiero e conoscenza” (p38). (…) Tutto ciò fa dei cambiamenti climatici un soggetto particolarmente resistente ai consueti schemi che la letteratura applica alla Natura: sono troppo potenti, troppo giganteschi, troppo pericolosi e troppo accusatori per essere descritti in tono lirico, elegiaco o romantico. Anzi, proprio perché non appartengono interamente alla Natura (qualunque cosa essa sia), tali eventi mettono in crisi l’idea stessa di Nature Writing, o scrittura ecologica: sono piuttosto esempi della perturbante intimità della nostra relazione col non-umano” (p40)
“Proprio quando l’attività umana cominciava a modificare l’atmosfera terrestre, l’immaginazione letteraria cominciò a concentrarsi esclusivamente sull’umano. Ammesso che si scrivesse del non-umano, ciò non avveniva nella dimora della letteratura seria, bensì in quegli umili annessi dove la fantascienza e il fantasy erano stati esiliati” (p75)
.3 Climate change e climate fiction: il non-umano che c’è tra noi
E’ innegabile che la fantascienza resti forse il sottogenere “meglio equipaggiato” (p82) per affrontare il cambiamento climatico. “Dopotutto esiste ora un nuovo genere di fantascienza, la climate fiction (comunemente detta cli-fi) o fantaecologia, che però racconta soprattutto storie catastrofiche ambientate nel futuro” (p82) mentre il problema del raccontare il climate change è proprio quello che esso non afferisce né a mondi immaginati, né a tempi o luoghi altri da noi.
“Quelli che stento a trovare sono scrittori le cui opere di finzione trasmettano una comprensione più precisa dei cambiamenti in corso nell’ambiente. Fra i romanzieri di lingua inglese me ne viene in mente solo una manciata: JG Ballard, Margaret Atwood, Kurt Vonnegut Jr, Barbara Kingsolver, Doris Lessing, Cormac McCarthy, Ian McEwan e TC Boyle.” (p155)
Ma non solo. Ghosh pone l’accento anche su un’altra questione, ossia la perdita della dimensione collettiva in favore della “psiche individuale”:
“Così oggi, proprio quando si è capito che il surriscaldamento globale è in ogni senso un problema collettivo, l’umanità si trova alla mercé di una cultura dominante che ha estromesso l’idea di collettività dalla politica, dall’economia e anche dalla letteratura” (p91)
“Più la sfera pubblica diventa performativa, a ogni livello, dalle campagne presidenziali alle petizioni on line, più si affievolisce la sua capacità di influenzare il vero esercizio del potere” (p159)
e last but not least anche su quella del linguaggio (ndr: punto nodale anche della trilogia dell’Area X, per esempio), che di necessità deve essere ripensato sia dal punto di vista dell’interazione con il non-umano (“Sarebbe legittimo […dire che] il nostro pianeta è diventato il nostro interlocutore, e che pensa attraverso di noi?” – p94) sia rispetto alla necessità di un apparato linguistico congruo da parte dello scrittore, che torni ad avvalersi di immagini ed elementi pittorici – anch’essi da tempo eliminati dalla storia del libro stampato (e tornati in auge, in parte, attraverso l’exploit della graphic novel).
.3 Storia e Politica
La seconda e la terza parte del testo (“Storia” e “Politica”) affrontano più da vicino gli eventi storici ed economici che hanno fatto del continente asiatico un polo di importanza fondamentale per quel che riguarda il riscaldamento globale, dalle conseguenze del decolonialismo, tra cui l’impennata dell’industrializzazione, alla condanna di una sostanziale eurocentricità nell’analisi delle questioni relative al global warming (tra cui la spinosa applicazione di un’eventuale “giustizia climatica“). Un punto di vista quello di Ghosh interessantissimo proprio perché non proviene dal primo mondo e offre al lettore una visione altra, esterna, che lo caratterizza fin nei minimi particolari e ci costringe a una prospettiva nuova:
“Il fatto che all’interno dell’Anglosfera le idee liberiste siano ancora dominanti è cruciale per la crisi climatica. Smentendo l’idea che il libero perseguimento degli interessi individuali conduca sempre al bene comune, il surriscaldamento globale mette in crisi anche il sistema di credenze su cui si fonda un’identità culturale profondamente radicata. (…) Molta della resistenza alla scienza climatica viene da qui, e qui sta probabilmente il motivo per cui nei paesi dell’Anglosfera il tasso di negazionismo del cambiamento climatico è insolitamente alto” (pp166-167)
Ma parlare di storia e politica, avverte Ghosh, non sia escamotage per il rimpallo delle responsabilità individuali:
“Quando le generazioni future si volgeranno a guardare la Grande Cecità, certo biasimeranno i leader e i politici della nostra epoca per la loro incapacità di affrontare la crisi climatica. Ma potrebbero giudicare altrettanto colpevoli gli artisti e gli scrittori, perché dopotutto non spetta ai politici e ai burocrati immaginare altre possibilità” (p166)
.4 Bibliografia
Un’ultimo paragrafo per qualche osservazione sulle note alle tre sezioni, ricchissime di spunti bibliografici. Ecco qui solo degli esempi:
- Stephanie LeManager (“Living Oil: Petroleum Culture in the American Century“, Oxford University Press 2014 – a pag 81 trovate il #RoadPleasureComplex di cui parlavo su Twitter)
- Elizabeth Kolbert, “La Sesta Estinzione“, Neri Pozza 2014 – di cui si era parlato anche su ADC
- Gwynne Dyer, “Le guerre del clima“, Tropea 2012
- Mark Lynas, “Sei gradi. La sconvolgente verità sul riscaldamento globale“, Fazi 2008
- Eduardo Kohn, “How Forests Think: toward an Anthropology beyond the Human“, Unversity of California Press, Berkeley 2013
- Alexander M Stoner & Andony Melathopoulos, “Freedom in the Anthropocene: 28th Century Helplessness in the Face of Climate Change“, Palgrave 2015
- Guy Debord, “La società dello spettacolo“, Baldini e Castoldi 1997
- Tim Flannery, “I signori del clima: come l’uomo sta alterando gli equilibri del pianeta“, Corbaccio 2006
- Anthony Giddens, “La politica del cambiamento climatico“, Il Saggiatore 2015
******
(*) “Quando guardo il mio passato, ho la sensazione che il fiume incroci il mio sguardo e mi fissi negli occhi, quasi a domandare: mi riconosci, dovunque tu sia? Il riconoscimento segna notoriamente il passaggio dall’ignoranza alla conoscenza. Riconoscere, pertanto, non è la stessa cosa che entrare in contatto per la prima volta, né abbisogna di parole: quasi sempre il riconoscimento è muto. E riconoscere non significa in alcun modo capire ciò che incrocia il nostro sguardo: la comprensione non ha alcun ruolo in un atto di riconoscimento. L’aspetto più importante del termine “riconoscimento” sta dunque nella prima sillaba, che rimanda a qualcosa di anteriore, una consapevolezza preesistente che rende possibile il passaggio dall’ignoranza alla conoscenza: il riconoscimento avviene quando una consapevolezza anteriore balena dinanzi a noi, provocando un repentino mutamento nella comprensione di ciò che si ha davanti. Eppure quel baleno non può darsi spontaneamente; non può divampare se non in presenza del suo altro perduto. La conoscenza che ne risulta è dunque diversa dalla scoperta di qualcosa di nuovo: deriva piuttosto dal prendere coscienza di una potenzialità ancora inespressa” (pp10-11)
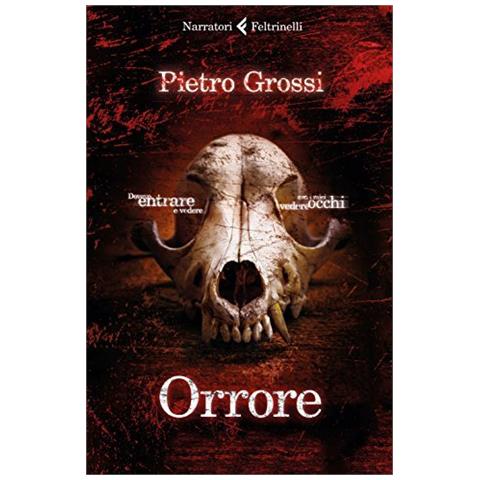







 Se volete capire qualcosa di più su Trump – non su cosa farà una volta insediatosi alla Casa Bianca, ma su come alla Casa Bianca ci è arrivato – dovete per forza leggere #TristeAmerica, reportage in quindici brevi capitoli scritto in tempi non sospetti (2016) da Michel Floquet, giornalista, anchorman di France Télévision 1 e corrispondente dagli States, in cui risiede da anni.
Se volete capire qualcosa di più su Trump – non su cosa farà una volta insediatosi alla Casa Bianca, ma su come alla Casa Bianca ci è arrivato – dovete per forza leggere #TristeAmerica, reportage in quindici brevi capitoli scritto in tempi non sospetti (2016) da Michel Floquet, giornalista, anchorman di France Télévision 1 e corrispondente dagli States, in cui risiede da anni.





