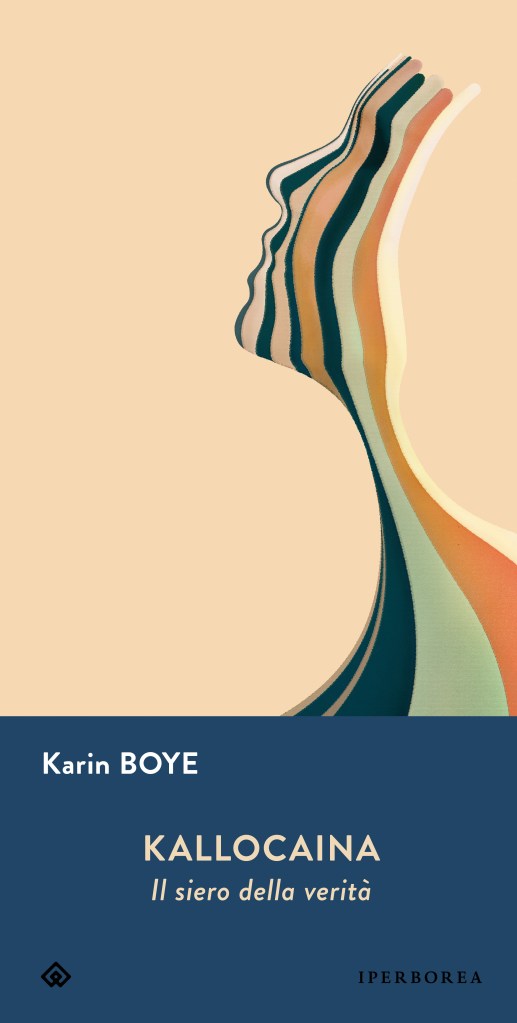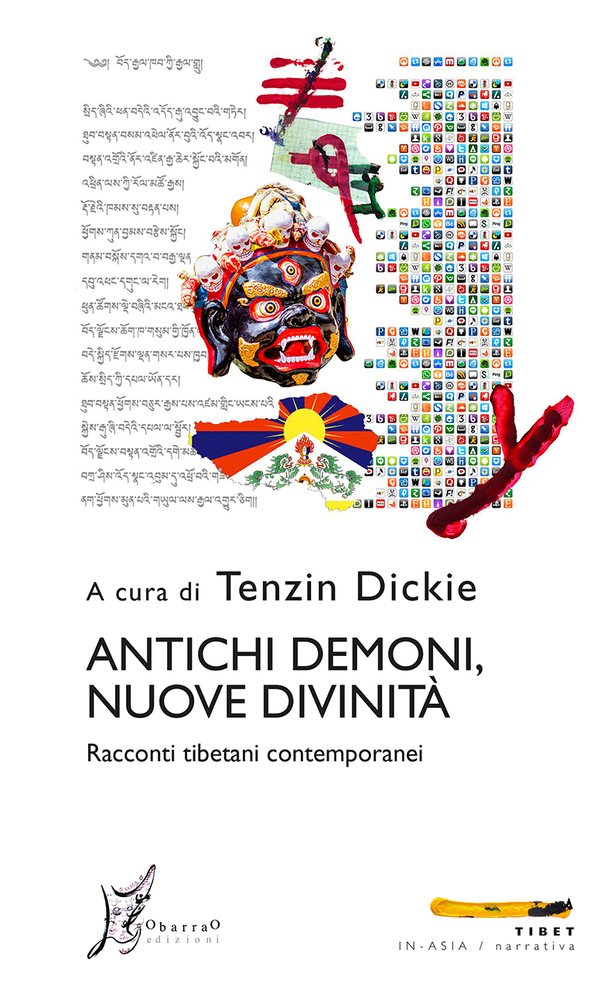“Quanto a me, credo nell’ira degli spettri all’approssimarsi della morte! «Così la notte fosse già venuta! Fin allora, tieniti tranquilla anima mia: le turpi azioni risorgono, benché tutta la terra le sopraffaccia, agli occhi degli uomini».”
Nel 1998 il romanzo “Mille six cents ventres” del quarantaduenne Luc Lang, scrittore e professore di estetica all’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy, vince il Prix Goncourt des lycéens.
Creato nel 1988 da Fnac, rettorato di Rennes e accademia Goncourt, il premio Goncourt des lycéens viene assegnato annualmente da una giuria di circa 2000 studenti scelti fra tutte le scuole superiori francesi a partire dalla seconda classe e chiamati a votare l’opera preferita fra una lista di libri proposti dall’accademia Goncourt stessa. I volumi vengono distribuiti nelle scuole, senza distinzione d’ordine anzi includendo in maniera dichiarata e specifica tutti quegli istituti, tecnici e professionali, “notamment ceux les plus éloignés d’une culture littéraire” tra cui scuole francesi all’estero e, per dire, istituti penitenziari. Nel corso degli anni il Goncourt des lycéens è divenuto uno dei premi più ambìti nel panorama letterario francese1.
“Milleseicento ventri” arriva da noi in Italia due anni più tardi, nel 2000, pubblicato da Passigli in traduzione di Maurizio Ferrara. La casa editrice decide di mantenerne il titolo originale che si riferisce – e qui sta il punto di questo giro introduttivo – al numero dei detenuti presenti fra le mura di Strangeways, il carcere cittadino di Manchester, al momento della rivolta dell’Aprile 1990.
Le proteste di Strangeways, con i detenuti in sommossa a denunciare le condizioni insostenibili della vita quotidiana all’interno della prigione, le vessazioni subìte dal personale, l’ingiustizia delle pene comminate (Strangeways in origine doveva essere un luogo di recupero per detenzioni non superiori ai cinque anni, ma poi – come prevedibile – divenne ben altro), diedero il via, in piena epoca Thatcheriana, a un fenomeno mediatico imponente le cui conseguenze furono una serie di rivolte all’interno di altri centri di detenzione fra Inghilterra, Galles e Scozia e svariate inchieste che toccarono punti nevralgici della struttura governativa dell’epoca2.
“Le ragioni invocate dai carcerati non sono del resto totalmente dei falsi pretesti”
Ricapitoliamo: uno dei più promettenti scrittori francesi, da poco professore di filosofia alla ENSAPC, sceglie di ambientare il suo quarto romanzo – quindi l’opera con cui o la va o la spacca – tra le casupole che compongono la zona suburbano/residenziale sorta alle pendici di uno dei penitenziari più problematici dell’intero Regno Unito, mettendo in scena, come su un teatro, uno degli episodi più drammatici di lotta sociale avvenuti in Gran Bretagna durante il governo di Margareth Thatcher: la rivolta di un manipolo di giovani uomini imbestialiti contro il sistema – perché di fatto la popolazione di Strangeways era composta per la maggior parte dai figli del sottoproletariato urbano fra abbandono scolastico, disoccupazione, microcriminalità e spaccio – chiusi in un carcere di massima sicurezza per reati di furto e ricettazione (“giovani che vanno dentro per una macchina rubata ed escono tossicomani”), costretti a condividere la cella con criminali della peggior specie in condizioni di detenzione disumane, abusi, malagiustizia. E in che modo decide di strutturare il racconto di questi venticinque giorni di sommossa, il nostro Luc Lang? Tramite la prima persona singolare, prendendo come protagonista uno dei residenti del quartiere: il sessantenne, raffinatissimo Henry Blain – proprietario di una delle casette più graziose del sobborgo, gran estimatore di donne e vini, mobili d’antiquariato e miscele di tè, nonché capocuoco della prigione di Strangeways e avvelenatore seriale dei detenuti; milleseicento ventri, appunto, su quali Blain regna incontrastato.
Fra spedizioni punitive – potenti lassativi nel minestrone dei carcerati giudicati maleducati o molesti, somministrazione di alimenti avariati a gruppi etnici di specifico taglio – e smerci di derrate consone in cambio di cibi etichettati come mangime animale, Blain da anni governa nell’ombra le cucine del penitenziario così come per anni aveva esercitato le proprie, disgustose perversioni sul personale delle navi da carico a bordo delle quali era arruolato. Abile manipolatore, malvivente astutissimo, meticoloso trafficante, Blain si ritrova al centro dell’azione che, come un miracolo letteralmente sceso dal cielo (i rivoltosi occupano i tetti, scagliando giù nella strada qualsiasi oggetto capiti a tiro: dalle pesantissime tegole di ardesia che vanno a infrangersi nei giardini delle casette fino a delicati e meravigliosi origami, farfalle che in mezzo allo spettacolo pirotecnico di lampeggianti, fuochi e sirene atterrano sulle teste del pubblico pagante), gli dà modo – unica volta nella vita – di autocelebrare pubblicamente il narcisismo patologico di cui è pregno: sfruttando l’indubbio vantaggio topografico, Blain apre la propria casa a cameramen e giornalisti che, previo pagamento, possono godere di una posizione di favore per riprendere gli scontri, nonché della testimonianza di un prezioso insider (che ovviamente se ne guarda bene dal proclamarsi parte del problema).
Riassumiamo (di nuovo): in Francia, un neoassunto professore universitario decide di giocarsi l’appena avviata carriera di scrittore mettendo insieme un romanzo basato su un fatto di cronaca dolorosissimo, che riguarda un Paese terzo e che ha per protagonista un lurido infame. Il romanzo tratta di violenza minorile, stupri, droga, delinquenza, abbandono scolastico, malattia mentale e femminicidio. Il libro esce, viene proposto a un pubblico adolescente/liceale – e vince il Prix Goncourt des lycéens.
“Louise sembra una zitella emancipata, sa quel che vuole, è lei a condurre il gioco, ma non è insensibile ai complimenti di un uomo. (…) Ha inoltre ritrovato in individui cosiddetti spacciati, lei predica fiduciosa, slanci di compassione verso gli altri, la natura umana è insondabile. (…) La compagnia di Louise un po’ brilla mi conveniva benissimo un attimo fa, ma davanti ai miei amici distinti ho una voglia quasi incontrollabile di schiaffeggiarla, un paio di sberle ben assestate, l’impronta viola della mano sulle guance bianche, si svegli dunque, si riprenda!”
Pausa – perché potremmo addirittura finirla qui, già sarebbe sufficiente (la domanda provocatoria potrebbe essere quale dei nostri attuali scrittori sarebbe in grado di osare tanto, ma ce la teniamo per un altro momento). Il punto in realtà è un altro e sta tutto nella figura di Henry Blain, che sotto la maschera di un’elegante normalità, fra aperitivi e merende nel salotto-tinello, nel profumo delle copertine di pellame pregiato con cui sono rilegate le edizioni dell’opera Shakespeariana di cui è avido collezionista, nasconde il più abominevole degli orrori – e no, non stiamo parlando dei suoi maneggi avvelenati.
“«È un fior di donna, la sua fidanzata», mi confessano. «Sì, ma è di origine tropicale, ha sete e debbo innaffiarla spesso», rispondo per fargli piacere.”
Fra le meravigliose aiuole di aeonium e tillandisia, beloperona guttata, azalee e camelie che compongono il suo giardino – l’unico della strada a non essere invaso dai detriti di una vita ai margini e dai rifiuti della depressione economica, ecco sta lì, il raccapriccio mortale di un individuo scellerato rispetto alla cui moralità nessuno, nemmeno noi che leggiamo (con l’eccezione del pubblico femminile adulto, forse) avremmo potuto nutrire il benché minimo sospetto. Henry Blain è, in sostanza, l’uomo perbene: un vicino di casa un po’ fissato con l’ordine e la disciplina (“Dio solo sa quanto detesto che mi scompiglino le ondulazioni dei capelli pazientemente rifatte ogni mattina”), ma così premuroso all’occorrenza; il compagno di bevute forse un po’ eccentrico, ma a chi di noi, se ciucco tradito, non scappa lo sproloquio razzista e misogino? L’amante esigente, certo, ma così attento, e facile allo scatto d’ira ma figuriamoci, si pensi a cosa deve sopportare, poveretto, sul posto di lavoro e via così, con quei tratti che oggi nella neolingua si chiamerebbero red flag ma che nel linguaggio vecchio del racconto scritto bene entrano spogliati da qualsiasi orpello woke (linguaggio politicamente scorretto e scene triggering incluse) a indicare l’analisi sapiente dello scrittore sul tema del predatore sessuale – sul modo che ha di prendere di mira gli strati deboli del tessuto sociale mascherandosi da benefattore (allenatore, maestro, zio acculturato, metteteci chi volete), sulle maniere subdole che mette in atto al fine di penetrare la fragilità di donne scelte appositamente per la loro intrinseca debolezza.
Luc Lang, con una lingua colta e affilatissima e un sistema di romanzo a scene che prende a piene mani dal teatro antico, costruisce un giallo sociale che fa della normalità percepita il proprio cardine. La domanda, quindi, risulta ancora più delicata, spinosa da affrontare: se sia possibile, oggi, nel momento attuale, proporre un testo come “Il giudizio universale” al medesimo pubblico a cui era stato proposto vent’anni fa e se addirittura si dovrebbe sentire la necessità di proporlo, in tutto il suo scabroso e didascalico orrore di vomito e diarree, corpi mutilati e sangue, sciacallaggio mediatico e turismo dell’orrore – insomma nulla che non appartenga all’oggi – scrittore maschio bianco incluso che per altro afferisce a un sistema culturale completamente differente dal retroterra descritto (giusto per rimarcare bene il fatto che se uno è bravo a scrivere può scrivere della qualunque).
“Il giudizio universale” esce ora per Clichy, rivisto direttamente dall’autore nella traduzione – e la scelta di questo nuovo titolo è conveniente e adeguata, non solo perché riprende uno dei temi ricorrenti del libro, quello della differenza fra pena e giustizia, ma anche perché segna bene il riferimento a un aspetto interessantissimo della vicenda: la trasformazione finale del protagonista in un moderno Ebenezer Scrooge che, costretto a letto e divorato dalla febbre e dai sudori, viene visitato dagli spiriti degli orrori commessi, in una notte senza fine per la quale forse esisterà giustizia, ma non redenzione.
“I suoi capelli sono stringhe di cuoio, sembra che abbia passato sul viso un lucido da scarpe, quando ride le rughe e le guance scavandosi le screpolano la maschera, immagino la pelle lattiginosa di sotto. È sempre così arrogante, tende una mano verso di me, le sue unghie smaltate sono coltelli smisuratamente lunghi, dice: «Ricordati di Eleanor nel momento della tua caduta. Il tuo corpo non ha raggiunto il suolo ma si è già separato dal suo zoccolo, sta cadendo, le leggi della gravità sono più forti delle legge del tempo. Quando ti spappolerai, miscuglio di ossa e carne, pensa alla tua sposa davanti a Dio».”
Luc Lang non piace a tutti: è un autore che sceglie di trattare temi difficili utilizzando una scrittura raffinata e nello stesso tempo rarefatta, su cui occorre tornare più volte, e delle strutture temporali complesse, pluridimensionali, che necessitano di un impegno mentale importante. Non è certo uno scrittore della buonanotte, insomma. Eppure io lo trovo geniale: precisissimo nella forma, riduce all’osso le necessità del dire, strapazza il lettore, rendendolo allo stesso tempo dipendente dalle allusioni e dai sottintesi e libero di ampliare le proprie, personali riflessioni relative alla materia analizzata. In questo guinzaglio lungo, tirato e smollato con sapienza filosofica, nell’invenzione caleidoscopica di protagonisti grotteschi e disperati, esaltati o depressi, vittime e carnefici, ecco proprio lì sta per me il talento dell’autore.
- L’edizione 2023 appena trascorsa è stata vinta dalla scrittrice Neige Sinno con “Triste tigre” (di cui Neri Pozza ha giusto acquisito i diritti), un memoir in cui l’autrice francese trapiantata in Messico racconta le violenze sessuali e gli abusi domestici a cui fu sottoposta durante l’infanzia da parte del padre adottivo. ↩︎
- Ancora oggi, la Strangeways Prison riot è oggetto di acceso dibattito interno. ↩︎