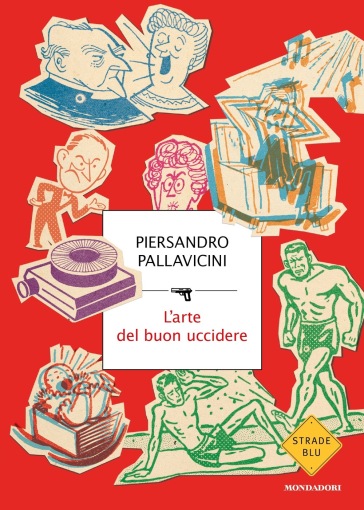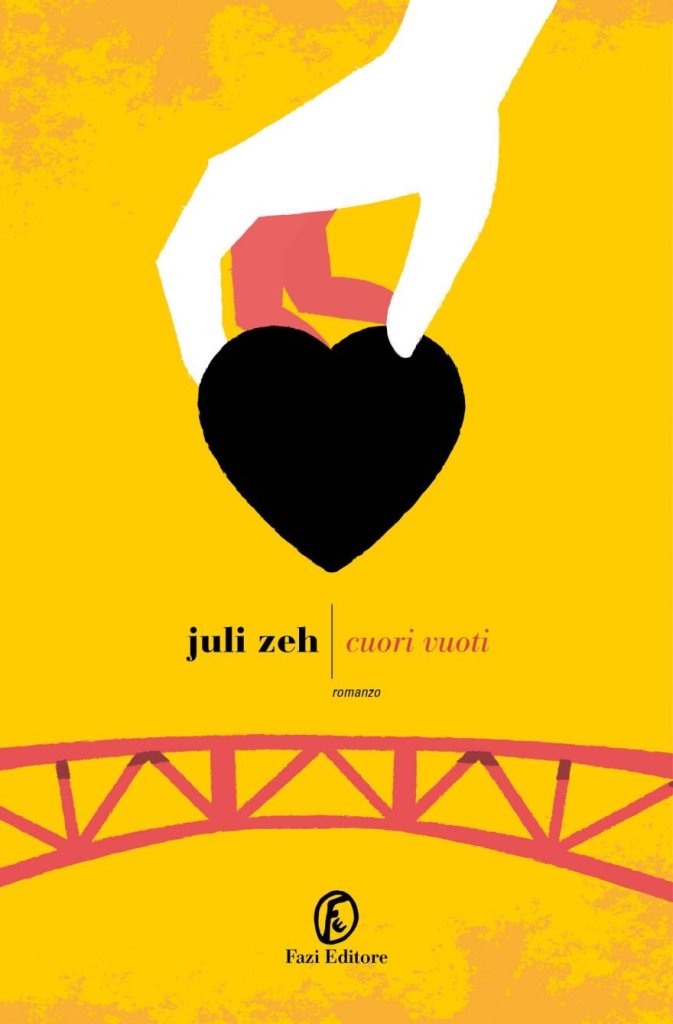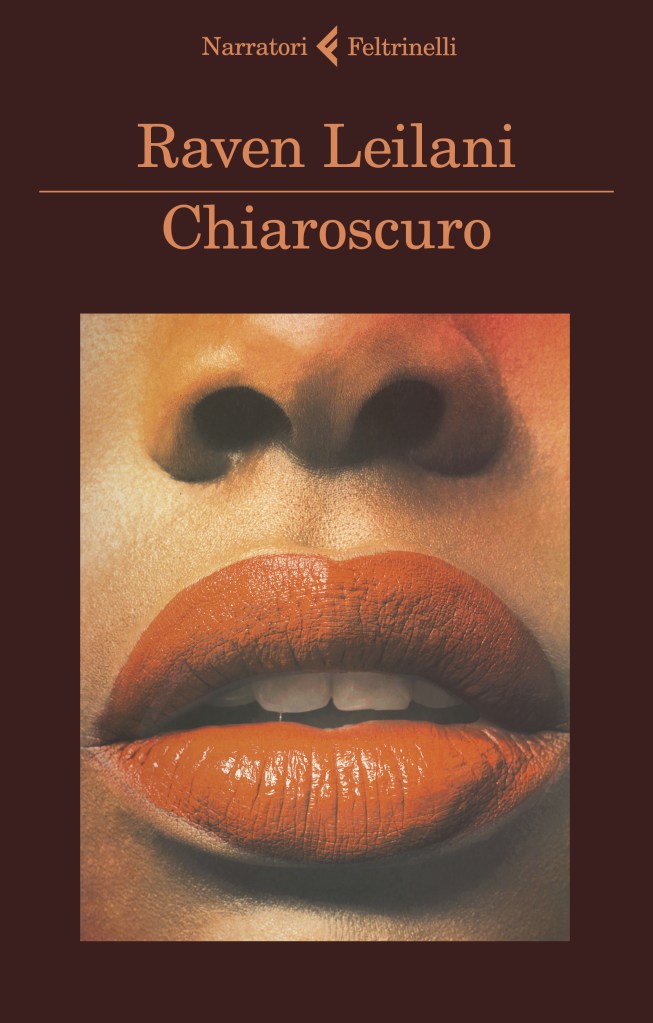“Ero felice. A dieci anni desideravo la protezione dell’oscurità. Ora, a sessanta, ho preso un appartamento in Costa Azzurra inondato di sole.”
A metà strada fra il giallo sociale, la commedia degli equivoci e il romanzo generazionale, “Il figlio del Direttore” indaga, con disincanto scrupoloso e urticante sarcasmo, le pieghe della più esclusiva Late Boomers generation nostrana.
A questa enclave d’élite appartiene Michelangelo Borromeo: neosessantenne pavese, proprietario della centralissima libreria antiquaria “Da Recalcati Libri e Gusto”, single, abitudini raffinate e conto corrente di pregio. Fanatico della boutade sapida (per mezzo della quale s’arrabatta sin dall’adolescenza a mascherare una patologica timidezza), cultore degli abiti di sartoria, dei ristoranti stellati e delle macchine sportive, Michelangelo Borromeo – nomen omen a svelare una nobiltà farlocca, indizio della pesante eredità familiare toccatagli in sorte – è insomma, diciamolo, uno di quei boomer del cavolo che, pieni di soldi, seconde case e colonscopie in regime di libera professione, da giovani affollavano di villette monofamiliari la provincia lombarda e che ora troviamo ritirati, complici età e divorzi tardivi, fra le mura di sontuosi quadrilocali ztl in quel triangolo delle Bermuda casereccio rappresentato da alta Brianza-varesotto-pavese.
“Da Recalcati Libri & Gusto, oltre alle prime edizioni di Sereni, Montale, Pavese, D’Arzo, ho quindici diversi prodotti al tartufo, colature di alici, bottarghe, creme di pistacchio, nocciola, fava tonka, tè cinesi esoterici, caffè campani artigianali, per non parlare degli champagne, solo grand cru, e dei vini di Bordogna, soltanto grand cru pure loro, e su ogni barattolo, scatoletta, bottiglia ci metto dei ricarichi semplicemente criminali. Ma la radice di follia del collezionismo librario, evidentemente, corrisponde alla medesima folle radice dell’estremismo gourmet.”
Il Borromeo, insomma, ne ha così tanti che un po’ fatica a immaginarne l’uso e a parte qualche momento di inquieta solitudine, speso a immaginarsi un personale futuro distopico di malattie neurodegenerative o navigando sui siti pornografici, se la passa discretamente bene fra il negozio, la residenza pavese e l’appartamento di proprietà al Mer Azur, un condominio di lusso affacciato sul boulevard de la Garoupe, ad Antibes. Il modo in cui Pallavicini racconta la raffinata decrepitezza della Côte d’Azur fuori stagione mi porta quel piccolo e noto conforto che viene dal leggere pagine scritte bene – tra piscine svuotate, pioggia che batte le strade quasi deserte, arenili inselvatichiti, odore forte di mare e aghi di pino, café solitari frequentati unicamente da persone del luogo e da qualche sparuto turista nordeuropeo. È un paesaggio lunare di cui Michel – come il Borromeo viene chiamato qui – si nutre avidamente; uno scenario che rimanda il lettore non soltanto agli anni gloriosi di Aly Khan e Rita Hayworth ma anche, in maniera più sinistra, all’Eden-Olympia di ballardiana memoria – il finzionale, paradisiaco complesso residenziale nizzardo all’interno del quale si svolge uno dei più truci romanzi della fantascienza occidentale.
Se sotto la penna di Pallavicini (come fosse un rivoltare d’involucro) i cultori dell’antiquariato librario si trasformano da stimati intellettuali a gente in sostanza anche simpatica e piacevole ma un poco gonza – e per questo finanziariamente necessaria, in un gioco di sapiente miniaturizzazione caricaturale, così i residenti del Mer Azur, allontanati a forza dalla gloria dei tempi passati, assumono sembianze a metà strada tra i fantasmi del tempo che fu e i protagonisti di un parco dei divertimenti a tema “benvenuti sul pianeta Terra”. Da Agathe, la svagata, autoctona proprietaria di alcuni appartamenti al Mer Azur, a rigore ricchissima ma scroccatrice seriale di opulente colazioni, a Madame Kirsten Østergaard, la turista danese affittuaria di Agathe che con l’assoluta incultura per la lingua italiana, le forme sinuose e il nudismo integrale sul terrazzo per lo yoga notturno al sottofondo di campane tibetane sconvolge gli ormoni del Borromeo e gli riporta a galla un’antica parafilia assolutamente politically incorrect, fino a Gualtiero, uno zerozerosette nazionale invischiato in non si capisce che traffico notturno – Gualtiero che ovviamente non si chiama Gualtiero e che per modi e piglio assomiglia non tanto a Daniel Craig quanto alla guardia del corpo di un boss mafioso.
“Il raggio del faro sulla cima del Cap taglia il buio ogni pochi secondi, un aereo che si prepara ad atterrare a Nizza attraversa il cielo stellato. Sotto le suole, mentre stropiccio i piedi sull’asfalto crepato, scricchiolano gli aghi dei pini. In questo momento mi sento come sempre mi sono sentito in questo angolo di mondo: non felice, che è una condizione implausibile per qualunque essere umano sopra i quarant’anni, ma vagamente euforico, sollevato anche se non si sa bene da cosa, diciamo in tregua col mondo. Ed è adesso, mentre l’angoscia della morte, della catastrofe e della rovina sono lontane, è ora, mente rimiro l’oscurità del mare con i gomiti appoggiati alla balaustra, che il cellulare si mette a suonare.”
I fantasmi del Borromeo però non finiscono qui perché, come in ogni giallo che si rispetti, a un certo punto ci scappa il morto – nella persona, addirittura, di Luca “Luchino” Borromeo, altrimenti detto il Signor direttore – nonché padre di Michelangelo; quel rinomato banchiere di provincia assurto fra gli anni ’70 e ’90 alle glorie di direttore di filiali per il Banco Italico tra Vigevano, Milano, Cantù e Busto Arsizio, quel padre smargiasso e burino, razzista, omofobo e cornificatore seriale, mancato due anni prima per causa di un brutto male che al posto di redimerlo lo aveva reso ancora più iracondo, menefreghista, cafone e stronzo. Nella pace della passeggiata serale sulla spiaggia nizzarda, insomma, una sera il cellulare del Borromeo comincia a squillare; il numero di telefono da cui arriva la chiamata è quello del padre – passato a miglior vita, come si è detto, due anni prima. La linea si interrompe appena Borromeo clicca sul tasto verde. Chi sta utilizzando il telefono del morto, quindi? Chi dunque si è introdotto nella casa di famiglia? Chi è colui che si sta appropriando dell’identità del Signor direttore?
La telefonata notturna scoperchierà il vaso di Pandora e la villeggiatura fuori stagione del Borromeo si trasformerà in un rutilante viaggio nel passato perché niente, come è ovvio, è come appare; in costante equilibrio fra i colpi di scena di un noir dai tratti hard-boiled e la farsa comica, Borromeo sarà costretto a precipitare non solo nell’abisso della propria giovinezza – un luogo della memoria infido e crudele dal quale aveva avuto ben cura di tenersi lontano – ma anche nel passato dei genitori e nel ricordo di Marcella, l’amore perduto.
Il viaggio di Michelangelo Borromeo però sarà anche un po’ nostro, perché “Il figlio del Direttore” è non solo la storia della famiglia Borromeo ma anche il racconto del sentirci boomer: se difatti alla tal generazione appartengono di diritto solo i nati tra la fine della guerra e la metà dei favolosi Sessanta va però detto che noi, un poco più giovani, quell’aria lì l’abbiamo respirata quotidianamente, insieme al fumo passivo in pizzeria – e non è che certi sistemi di pensiero si possano scardinare con facilità. “Il figlio del Direttore”, poi, significherà per molti il ritorno alla provincia lombarda – regno di piccoli ricordi acuminati, dolorosissimi – e per molti altri invece un volo radente sopra una terra che, lo si voglia oppure no, ha significato moltissimo per la società e per la politica italiana.
Ah, non dimenticate la FFP2, mi raccomando; ché tra le altre cose “Il figlio del Direttore” è anche un romanzo post-pandemico – forse il primo che s’azzarda a recuperare la dimensione comica della tragedia, fra ipocondriaci atterriti, svagati cronici che del Covid quasi nemmeno si sono accorti, incoercibili no-vax equipaggiati di bottigliette di gel igienizzante incartapecorito e mascherine putrefatte.
È possibile, si domanda Michelangelo Borromeo, godersi la vita dopo che la vita è passata? Forse no, ma forse anche sì.