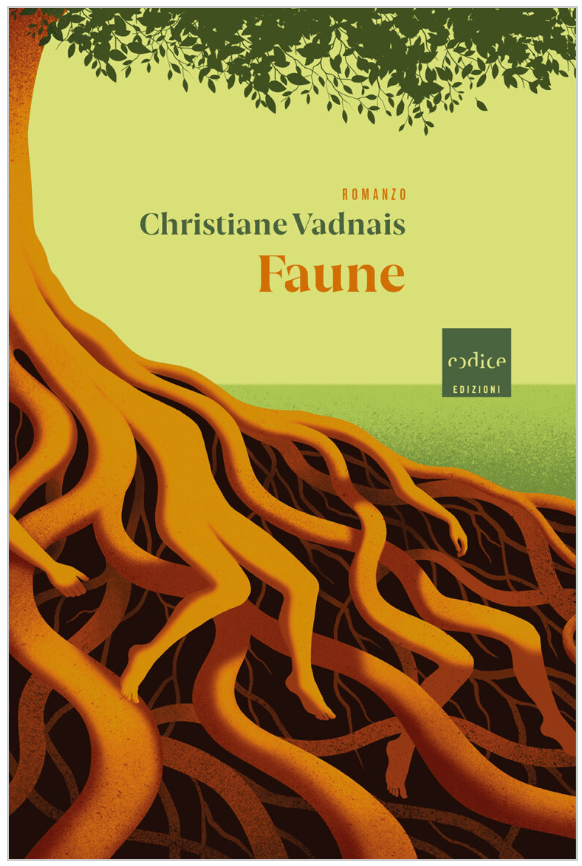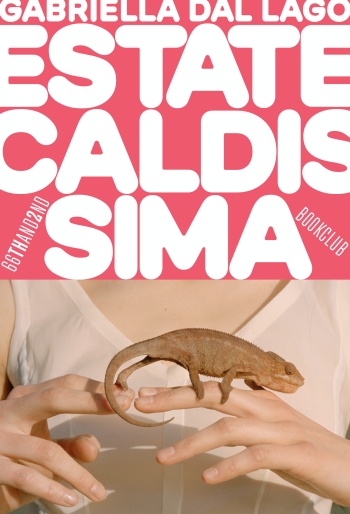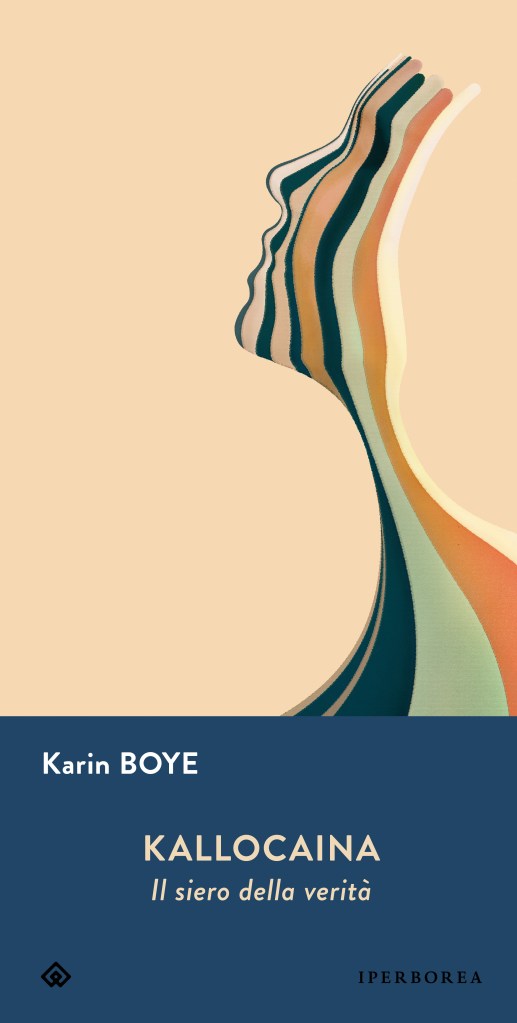Trovate qui la prima parte di questo fantastico excursus!
Una mucca per il congelatore
Nel reel apparso ieri sulla timeline di Instagram, la mia tradwife preferita è ripresa mentre maneggia una pagnottella di lievito madre e farine con una destrezza che neanche la nostra prozia di Aci Castello. L’inquadratura, di taglio professionale, la vede al bancone della cucina – legno grezzo, luce naturale dalla finestra – e mette in evidenza l’outfit “as a 22 years old housewife”: maniche rimboccate ai gomiti, apron a rouches rosa antico, gonna lunga con balze, foularino ai capelli. Al filmato si accompagna una colonna sonora peaceful orchestra e in sovrimpressione scorre il breve testo: “Save for what we value” (“Risparmia per ciò che vale!”), seguìto da un elenco di punti tra cui spese sanitarie, pneumatici per l’automobile e “a cow for the freezer”.
Un altro video recente la presentava assediata da pentoloni di marmellate fumanti, abilissima esperta del Lid-vacuum (la macchina per il sottovuoto); in un altro filmato la si vede separare dalla panna il latte appena ritirato presso il fattore. Nella didascalia: “Pov: you eat seasonally, source locally, grow your own & preserve as much as you can” (“Punto di vista: mangi secondo stagione, usufruisci di risorse locali, coltiva il tuo [necessario] e metti da parte quanto più possibile”).
Acqua potabile
In USA, terra di gente che in media cambia città di residenza 11.7 volte nel corso della vita, con un tasso di permanenza che raramente supera i cinque anni, è consolidata abitudine consultare i website di ranking (“classifiche”) per verificare che nel luogo in cui ci si intende trasferire i parametri di interesse corrispondano alle proprie necessità. La reportistica è varia e accanto ai temi più quotati, relativi alla dimensione professionale, compaiono anche sezioni dedicate all’analisi ambientale, con indicazione dei luoghi nei quali è più agevole e garantito l’accesso a un’alimentazione sana e “local” (chilometro zero) e a fonti di acqua potabile verificate; a ciò si aggiungono, infine, i dati sulla disponibilità di offerta in fatto di vita comunitaria, laica o religiosa.
(Nota per gli interessati: le statistiche di argomento professionale vertono sulla verifica delle opportunità di carriera e dei tassi di disoccupazione, su costi e disponibilità degli immobili, in vendita o locazione, e sulle modalità del commuting [tempi e modi del tragitto casa-lavoro]. Molto consultate anche le stats sulla presenza di microcriminalità e sul tasso medio di istruzione locale. Last but not least: per le statistiche relative alla potabilità dell’acqua, “Drinking Water Violation Rate” è la dicitura specifica: tutto un programma, vero?)
Numeri alla mano, si capisce che per gli americani sapere cosa c’è di preciso nel liquido che esce dal rubinetto o cosa sia davvero finito dentro alla famigerata cheesburger soup servita avant’ieri per cena non siano questioni derubricabili a una fissa da viziati hippie primomondisti. Le ragioni vanno cercate nella scarsa fiducia del consumatore statunitense verso il comparto alimentare, che per quadri normativi non sempre trasparenti e conclamate vicende giudiziarie risulta spesso ormai inaffidabile dal punto di vista della qualità sanitaria dei prodotti. Questo nuova consapevolezza coinvolge sempre più individui, spingendo le comunità locali a riformulare il modello di approvvigionamento: ove possibile si tende a virare su microimpresa domestica a chilometro zero, consumo secondo stagione, agricoltura organic indipendente dal biologico in scala (che ha prezzi inaccessibili). La produzione homemade su terreni controllati e materie prime verificate è passata da alternativa cozy a improrogabile necessità, non priva di una certa ossessione; ma, come si vede, gli americani hanno i loro buoni motivi.
(Note per gli interessati: L’offerta di testi che raccontano i disastri ambientali statunitensi è ampia e variegata e va dalla realistic fiction alla saggistica divulgativa. Su Goodreads, al tag “environment” sono associati, ad esempio, il romanzo “L’America sottosopra” di Jennifer Haigh [2018, Bollati Boringhieri] che affronta attraverso personaggi di finzione le drammatiche vicende di una certa parte rurale della Pennsylvania sottoposta alle attività estrattive per mezzo della tecnica del fracking, o le opere narrative-non-fiction di Elizabeth Kolbert e Naomi Klein).

One-income tradfamily
Non deve quindi destare stupore che il movimento tradwives dedichi tanto spazio agli argomenti relativi all’alimentazione. Per mezzo di video a estetica variamente romanticizzata (“homemade meals aesthetic”), le nuove casalinghe tuttavia celebrano – o giustificano, a seconda di come si voglia vedere la questione – il ritorno alla tradizione del cibo fatto in casa quale strumento di valore per ottenere non solo salubrità del prodotto/salvaguardia ecologica ma anche un consistente risparmio di denaro (sfruttando anche lo scambio comunitario di baratto/vendita solidale) e, ultimo ma non ultimo, per riappropriarsi della propria dimensione femminile.
Lo stile utilizzato per raccontare la scelta di vita che si basa su un reddito solo – che Ça va sans dire corrisponde all’entrata procurata dal maschio di casa – è su per giù quello del “SI PUO’ FARE” di Brooks-eniana memoria e le modalità con cui far fronte all’indiscutibile complessità del tema convergono sui concetti chiave della sobrietà, della rinuncia consapevole a beni definiti voluttuari e dei vantaggi che ne derivano (diminuzione dello stress legato a orari e responsabilità, possibilità di gestire meglio casa e famiglia, evitando la delega – donne delle pulizie, tintoria, spesa on line, babysitter, giornata scolastica lunga 12 ore ecc.). Sui social la descrizione delle pratiche saving si limita per necessità a qualche accenno ma niente paura: per una cifra solitamente inferiore ai 50 dollari, 40% off nel Black Friday, è spesso possibile acquistare l’ebook “Our affordable life as a one-income basic family” (titolo che invento, giusto per non tirare in ballo nessuno in particolare), una guida rapida e accessibile che tramite tips and tricks basati sull’esperienza pratica aiuterà chi lo desidera a “tagliare le spese e gestire il denaro in maniera più saggia”, definendo le proprie priorità e costruendo piani di risparmio.
(Note per gli interessati: la struttura organizzativa di questi testi è più o meno univoca. Si parte da un capitolo introduttivo sul “da dove cominciare”, dedicato a chi sente la necessità di un cambio di passo/nuovo modello di vita, per poi scendere nel dettaglio dell’analisi delle priorità. Interessante il punto sull’autocoscienza: quasi mai compaiono elenchi di spese dichiarate inutili a priori; è presente piuttosto un generale invito alla riflessione – “la verità è già dentro di noi” – sui temi del capitalismo, della teoria della creazione del bisogno sempre insoddisfatto e della scelta consapevole e che si auto-limita. A seguire di solito i capitoli più tecnici, con tabelle e conteggi, e alcuni compendi sull’utilizzo di prodotti alternativi e più economici per la gestione della quotidianità, dalla spesa ai detersivi, dai vestiti al parrucchiere. Accanto a osservazioni e piani di risparmio interessanti convivono suggerimenti che a prima vista ci possono apparire francamente banali del tipo “non usare la carta di credito se sai di avere il conto in rosso”: se però confrontiamo questa osservazione con gli ultimi dati usciti per FED New York – che dichiara per il secondo trimestre 2023 un debito USA di 1.000 miliardi USD sulle carte di credito e un tasso di morosità superiore a quello degli 11 anni precedenti – si capisce come la questione sia concreta ed emergenziale.)
Sottomessa al marito
Il movimento tradwives insomma celebra abitudini nuove pescando a piene mani nella sedicente convergenza evolutiva secondo cui le donne di tutto il mondo sin dalla preistoria sarebbero state esclusive protagoniste dell’organizzazione domestica, in specie per quanto riguarda raccolta, produzione e conservazione alimentare; niente di più che un back to the origins, quindi. Master and commander di tutto ciò è il marito che di fatto tiene i cordoni della borsa e che ha la facoltà – magari non la userà mai, però ce l’ha – dell’ultima parola in fatto di amministrazione del denaro di famiglia. Marito a cui la moglie sta in rapporto di amore reciproco e submission.

Il concetto di “sottomissione” è biblico e a questo contesto si rifà, volente o nolente, la maggior parte delle tradwives influencer. Infilarsi in Google alla ricerca di “definition of submission”, però, è un atto per cuori impavidi perché le questioni filologiche, non da poco, si sovrappongono come si può facilmente intuire alle traduzioni interpretative. Il problema nasce anche dalla circolarità delle definizioni che talvolta, specie nei siti di target più ampio, faticano ad andare oltre il recupero della parola sacra. Per la maggior parte vengono citati i testi biblici di riferimento – il passo più quotato è Pietro, 3:4-6 – a cui spesso segue l’associazione con brani che indicano Dio come termine ultimo di sottomissione.
Il dubbio è che tramite queste associazioni si finisca per suggerire una sorta di identità semantica fra l’obbedienza che deriva dal riconoscimento di un’autorità sociale/politica (capoufficio/individui l’uno verso all’altro come comunità) e il rapporto di sottomissione moglie/marito – procedura che come si può intuire esclude a priori tutti i temi di relazione maschio/femmina, dall’erotismo fino alle questioni del patriarcato e dell’abuso; tant’è che, onde smussare il senso di “unconfortability” che ne deriva, con frequenza ci si sente in dovere di porre l’accento sugli aspetti “mutual” (“reciproci”) della subimission: “selflessness, service, accountability, and respect” (“altruismo, servizio, responsabilità e rispetto per il proprio partner” nell’ottica di una generale accettazione della volontà divina). Ove richiesti approfondimenti, le definizioni spesso utilizzano la formula al negativo, elencando ciò che NON significa submission: la sottomissione “non pretende che la donna dimentichi il suo cervello sull’altare”, “non significa che la donna non possa avere opinioni”, “non apre la porta alla violenza domestica”, “non è un rapporto legato al valore individuale” ed è difficile (o almeno, io per ora ne ho trovato scarso riscontro) che si faccia riferimento alla sostanziale estraneità del messaggio di Cristo nei confronti di una certa tipologia di cultura patriarcale.
(Note per gli interessati: il termine greco utilizzato è Υποτάσσω, che è in realtà d’uso militare [Υπο: sotto, τάσσω: mettere] e letteralmente indica la maniera in cui le schiere di soldati vengono sistemate in assetto da battaglia, ciascuna sotto il proprio generale. Nella Bibbia il termine compare 12 volte e sempre a voce verbale, mai come sostantivo, il che è già degno di nota perché rende più esplicita la necessità della contestualizzazione spazio-temporale. Nb: Non si pretende qui di offrire una panoramica esaustiva su questioni di esegesi biblica tanto complicate. In questi paragrafi ho voluto unicamente evidenziare alcune delle criticità più evidenti della questione, senza pretesa di esaurire in poche righe un argomento la cui complessità parte addirittura da questioni filologiche.)
Di fatto – per tornare alla concretezza del frigorifero – è difficile trovare una tradwife influencer che sui social risponda candidamente, con sì o no, alla domanda: “Se mio marito mi dice che non posso comperare verdura questa settimana, posso acquistarla ugualmente se lo ritengo necessario per la mia salute o per quella dei miei figli?”. E’ su tale, semplice questione che gli animi delle commentatrici si infiammano, costruendo volumi di engagement di dimensioni considerevoli.
Nel prossimo e conclusivo episodio di questa deep dive saga: differenze tipologiche e, da qui, breve cenno agli argomenti tabù (oh sì, ce ne sono). Analisi presenza e posizionamento di tradwives a etnia non bianca / minoranze. Clicca qui per andare alla terza e ultima parte.