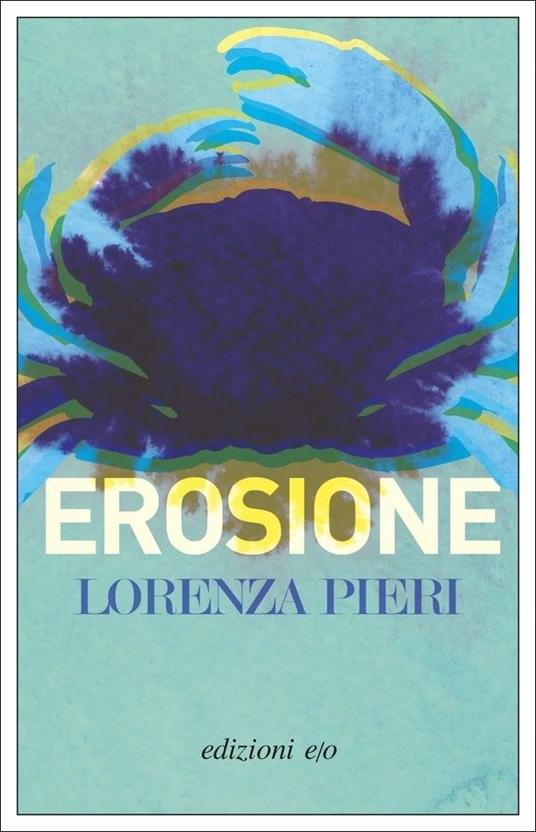“Sciocchina, i trattamenti cutanei curano l’esterno, non l’interno.”
La fantascienza transumanista di Mary Shelley cresce tra le inesauribili declinazioni del cyberpunk da Gibson a Sterling, s’aggrappa al fertile terreno dei manga (Akira, Ghost in the shell, per dire), semina dubbi nel ventre dei supereroi a stelle e strisce toccando proprio il cuore della vigorosa supremazia occidua – come ci raccontano i Tre millimetri di Matheson, il Jedi rinnegato Darth Vader, l’affaire Wolverine. Il superamento del corpo, punto riguardo al quale gli esseri umani, va detto, stanno in fissa perpetua, nella speculative fiction viene raccontato principalmente attraverso il controverso rapporto carne-macchina, precisamente nel momento in cui la tecnologia assume la funzione di strumento di sorpasso. La varietà di soluzioni è infinita a livello pratico ma ben codificata nei sottesi principi generali, in quello che per certi versi può essere interpretato come un crescendo di soluzioni ad hoc, dipendenti non solo dal livello dello sviluppo tecnologico ma anche dal grado di agiatezza economica del singolo (individuo o gruppo sociale): si comincia con le protesi esterne per passare agli innesti – del tutto meccanici o ibridi uomo-macchina -, sino ad arrivare all’interfaccia neurale impiantabile (la pila corticale di Altered Carbon, che può essere prelevata da un corpo, non a caso definito custodia, e inserita in un altro, rendendo così di fatto possibile l’immortalità, certo a patto di avere mezzi sufficienti per comperarsi un nuovo …contenitore).
“(…) a quanto pareva non era così semplice rimuovere a piacimento le parti del corpo indesiderate… Non avevano più giocato a mangiarsi. Gli adulti però se ne erano già accorti. La dottoressa notò dal monitor che ad Andy mancava un dito. Domandò cosa fosse successo e, stranamente, anziché sgridare Momo la mise in guardia. «Divertitevi quanto volete. L’operazione si avvicina e allora rimpiangerete di non aver giocato abbastanza. Però non mangiatevi, altrimenti non sapremo come fare», spiegò, «Momo, sarai tu ad andarci di mezzo per aver mangiato il dito di Andy».
Città di T., anno 2100: l’umanità si è ritirata nelle profondità degli oceani per sfuggire ai cambiamenti climatici innescati dall’inquinamento. L’incredibile sviluppo tecnico ha permesso la sopravvivenza della nostra specie ma il mondo sommerso è governato dalle industrie ipertecnologiche che oltre a contendersi i fondali marini continuano a rivaleggiare anche sulla terraferma, ormai ridotta a un parco archeologico cotto dai raggi ultravioletti, tramite guerre per procura combattute da macchine e androidi. Nella città di T. – in cui dominano asettici colori pastello e giardinieri strapagati, metà umani e metà robot, curano la preziosissima vegetazione – vive Momo, famosa estetista della pelle. Momo è divenuta una celebrità nel ramo dei trattamenti cutanei, professione molto ambita poiché l’inquinamento sulla terraferma e le atmosfere modificate nei fondali sottopongono la pelle umana a stress e malattie. La trentenne però non approfitta della notorietà e anzi vive una sorta di eremitaggio autoimposto, con il computer a fare da unico strumento attraverso cui interagire con l’esterno – a parte le sedute con i clienti durante le quali, tuttavia, mantiene un riserbo divenuto ormai leggenda. In occasione del suo trentesimo compleanno, però, alla porta si presenta sua madre, da cui si è separata vent’anni prima. Questa improvvisa apparizione darà il via a una serie di riflessioni che culmineranno in un completo stravolgimento di punti di vista, legato al fatto più importante della vita di Momo: un’operazione salvavita, subìta quando aveva dieci anni (che aveva per altro compreso anche il cambio di sesso), rispetto alla quale la madre non ha mai voluto fornire dettagli.
“Nel discolibro, Amleto diceva: «Potrei vivere nel guscio di una noce e credermi re d’uno spazio infinito, se non fosse per certi cattivi sogni».”
Per molto tempo ci siamo nutriti di fantascienza occidentale pensandola unica opzione possibile e focalizzandoci di conseguenza su un certo tipo di antagonismi e storytelling (dal quale però, va detto, alcuni autori e autrici avevano tentato di metterci in guardia); grazie però al lavoro di piattaforme di nicchia e al più recente investimento delle case editrici nella traduzione da lingue non anglofone s’è reso evidente quanto il futuro della fantascienza sia legato a esperienze diverse da quelle della scifi occidentale. L’opera divulgativa, sia dell’originale sia in traduzione dalla lingua madre non mediata dall’inglese, ha il merito di aprire al panorama non anglofono il pubblico mainstream e, allo stesso tempo, di facilitare il recupero dei testi da parte di chi s’interessa di scifi più nel dettaglio: afrofuturismo e fantascienza asiatica non sono esattamente fenomeni emergenti quanto un sistema di declinazione della materia presente da tempo e su cui qui da noi manca ancora, in tanti casi, lo sguardo d’insieme. Esempio lampante di tutto questo discorso è, appunto, “Membrana“, pubblicato a Taiwan nel 1995 e scritto dal prolifico Chi Ta-wei (scrittore, studioso di storia letteraria sinofona, esperto di temi LGBTQ, professore associato di letteratura taiwanese presso la National Chengchi University di Taipei), un romanzo breve che nella costruzione di uno scenario distopico si impegna ad affrontare temi di natura prettamente locale.
Lo scenario distopico scelto è quello della catastrofe post-apocalittica di matrice ecologica: in particolare, l’autore si riferisce all’assottigliamento dell’ozonosfera, uno dei primi veri segnali dell’inquinamento a opera umana, questione che tanto aveva colpito noi della X Gen. Tuttavia, l’indeterminatezza delle specifiche tecniche dimostra il sostanziale interesse dell’autore per lo sviluppo della parte speculativa più che per la creazione di una distopia mirata. Le considerazioni di Chi Ta-Wei difatti si inseriscono all’interno dell’analisi del sé e della critica sociale, con specifico riguardo alla realtà asiatica. Per esempio, uno dei punti cardine è l’integrazione di persone fuori canone nella rigida società ipernormativizzata orientale, il che non vuol dire solo temi LGBTQ ma anche la riflessione sulla realizzazione personale della donna quando non comprenda la tradizione del matrimonio e della maternità. Un altro argomento di forte interesse è l’analisi degli effetti dei vecchi e soprattutto nuovi colonialismi (di cui è metafora la battaglia per la conquista degli oceani) e la questione delle guerre per procura, nonché l’argomento dell’appartenenza sociale, culturale e politica alla sfera d’influenza cinese.
Membrana è tutto ciò che ci avvolge, in un continuo gioco di specchi e rimandi: è la pelle su cui scivolano gocce d’acqua e raggi di sole, baci di amanti e sbuffi di vento, ma è anche la delicata carta della stratosfera che riveste il nostro pianeta; è “il confine invalicabile tra il nostro corpo e le cose esterne”, è il luogo in cui risiede la “frattura visibile” provocata dai conflitti interpersonali, l’ “ironia bruciante” della cicatrice quando è frutto di una sottrazione. Da rifletterci.