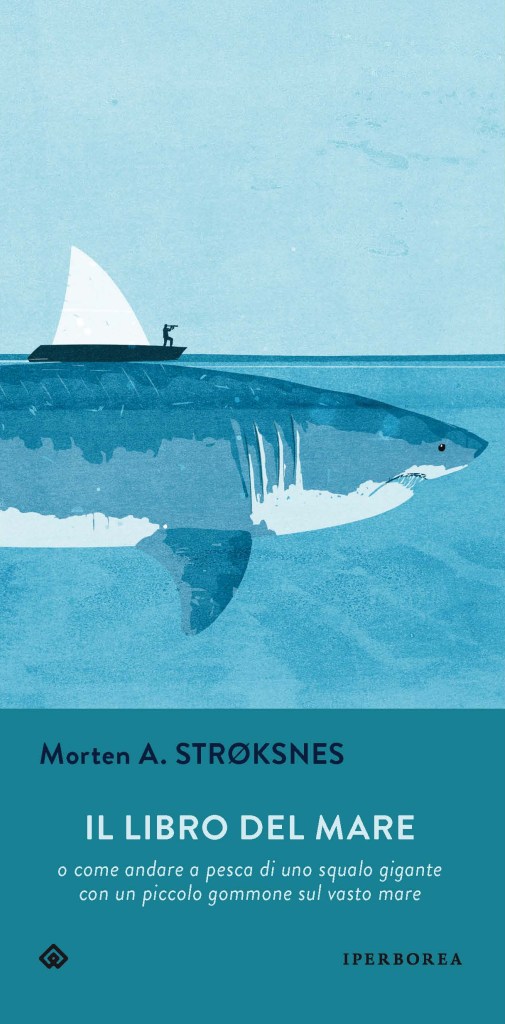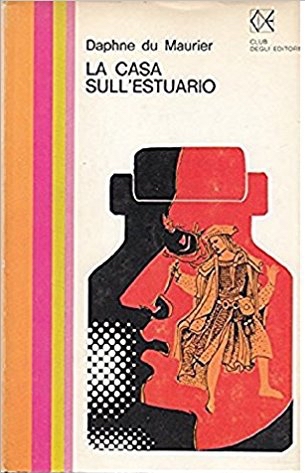“Quella notte ci addormentammo tutti e tre immaginando di essere seduti a pranzo e di udire il fragore terribile della terra che si spaccava, eruttando soffocanti fiumi sulfurei come se l’inferno affiorasse alla superficie, mentre le strade crollavano nel porto e il mare si gonfiava in onde possenti a strappare i bastimenti dagli ancoraggi e catapultarli nell’entroterra, oltre le rovine della città sprofondata” (“Mr. Rochester”, Kindle pos410)
“Nelle sue narrazioni il mare non era popolato soltanto di pirati, bensì anche di serpenti marini e di sirene, e parecchi marinai perdevano il cuore per quelle ammaliatrici dai capelli d’oro, oppure perdevano la vita, divorati dalle bestie emerse all’improvviso dagli abissi caraibici” (“Mr. Rochester”, Kindle pos417)
“La gente oggi non fa che dire che ha bisogno di esotismo, che sogna di spostarsi lontano dalle città, via da tutto e da tutti, che se potesse oh se solo potesse se ne andrebbe in campagna o su un’isola remota, ma dopo un numero di ore tutto sommato contenuto o anche solo alla minima contrarietà, in quelle città non vede l’ora di far ritorno, per ritrovare finalmente la banda larga, le sedute di depilazione laser, il pesce crudo abbattuto dei ristoranti e tutto quello che spergiurava di voler abbandonare” (“Lux”, Kindle pos3264)

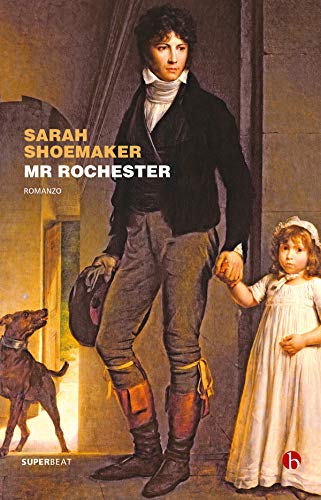
“Cerchiamo nei libri quello che non capiamo della vita, e nella vita quello che leggiamo nei libri. Forse è questa, la nostra condanna all’infelicità: cercare risposte e trovare solo commozione” (“Lux”, Kindle pos1264)
“Quanto si deve essere immaturi e ignoranti per pensare di poter apprendere lezioni di vita dai romanzi!” (“Mr. Rochester”, Kindle pos2052)
Mi perdonerà Neri Pozza se sistemo in un unico post due titoli che per forma e per trama hanno poco a che fare l’un con l’altro. Ad accomunarli qui su ADC è stato quel meccanismo della celebrazione delle stagioni che vanno e che vengono. L’idea di mettere un punto, ritualizzare un passaggio, lasciar andare e nello stesso tempo trattenere il necessario.
“Lux”: dire addio all’estate, e alle cose perdute
“Avevano un odore complicato, quelli, di umido e acqua di rose, zucchero filato e naftalina: l’odore del tempo che passa indisturbato senza che nessuno lo veda, dentro alle cuciture, attraverso le asole, in fondo alle fibre del lino e tra i capricci del falpalà” (Kindle, pos1332)
Se volete cullarvi ancora un po’, in quell’idea d’estate di mare fuori stagione, quello che dà principio alla fine di maggio, o ancor meglio a questo, di coda, coi cieli saturi e stanchi di agosto a far presa su un settembre ancora a venire – bene, allora leggete “Lux”. Che è un romanzo di piccole cose e grandi questioni: l’amore un po’ stanco e scipito di due non più adolescenti alle prese con l’adultità al cui arrivo non ci si può opporre; un anziano scrittore che deve far fronte alla vecchiezza irrimediabile – quella che vien dall’anima prima che dal corpo; una serie di altri personaggi irrisolti, femmine e maschi, adulti e bambini, a cui vorremmo costantemente suggerire come comportarsi salvo il fatto che poi alla fine si capisce che più perfetti di così, nelle loro totali imperfezioni, non potrebbero essere e che ognuno alla fine la propria vita se la fa un po’ come vuole perché le scelte, quelle profonde e da farsi in completa solitudine, sono sempre possibili checché uno ne dica (“Alla fine la vita è solo questione di scegliersi la bugia giusta”). Viceversa però, sta a guardarci – dalla lontananza siderale di un tavolinetto da tè in legno di teak appartenuto a chissà quale signora della nobiltà inglese – la famigerata tazzina sbeccata: a ricordarci che a ogni azione corrisponde una conseguenza; una volta caduta a terra, la tazzina mai più tornerà come prima – e però potrà essere rattoppata, mani sapienti e arte antica dell’oro, a crearne una nuova, stoffa di passato e futuro cuciti insieme. Su tutto domina l’elenco – di comodini in legno di cedro, servizi di porcellana cinese, stoffe e tendaggi, tappeti e suppellettili, animali impagliati e copricapi ammuffiti – che per chi come me è cresciuto a cataloghi (delle navi, dei guerrieri, degli eroi, degli dei, degli scudi, delle battaglie, dei consoli, degli imperatori, dei condottieri, dei capitelli, delle metope, degli esametri, delle opere, dei versetti del Dhammapada), rappresenta non tanto un catalizzatore di facili nostalgie quanto un mezzo espressivo potentissimo attraverso cui catturare la memoria del lettore, la sua capacità di ricordare, recuperando quel vizio tutto indoeuropeo di imparare attraverso l’oralità degli aedi – e di tutti coloro che sono capaci di inventare storie. (*)
“Eppure a lui, soltanto a lui aveva dedicato pensieri, stagioni, e chissà quante altre cose ancora si sarebbe preso senza che lei lo volesse, senza che potesse farci nulla. Non era forse assurdo affannarsi, allora? Cosa pensavamo di dimenticare davvero, se passavamo la vita a ricordare? cosa ci ostinavamo a voler salvare, se poi smarrivamo tutto?” (Kindle, pos2345)
“Mr. Rochester”: salutare l’autunno – di mettere punti e creare mondi
“Bisogna giocare con le carte che si hanno” (Kindle, pos588)
La prima fu Jean Rhys, scrittrice inglese di origini caraibiche, che ci raccontò di Antoinette Cosway, la folle ereditiera creola data in sposa a Edward Rochester con l’inganno. Romanzo postcoloniale dai tratti decisamente femministi e di critica sociale, dalla questione della schiavitù alla condanna del contesto fortemente misogino e patriarcale dell’epoca (nb: il romanzo è del 1966) “Il grande mare dei Sargassi” è di fatto la prima fanfiction canon (di lusso) a base Jane Eyre. Venne poi Bianca Pitzorno che con il suo “La bambinaia francese” (2004) prese le parti di Sophie Gravillon, la tata che la cantante d’Opera Céline Varens assume per occuparsi della figlia Adele – come tutti ben sappiamo la pupilla di Edward Rochester, convinto ad occuparsi di lei per spirito di carità, nel dubbio che sia sua figlia. Anche qui, un’opera di fiction (OOC “out of character” – per l’esattezza) che pur partendo chiaramente dal testo di Charlotte Bronte se ne discosta sia per l'(in)fedeltà all’originale (si parla in questo caso di un “what if” ucronico), sia per il forte intento di rottura con il personaggio femminile “passivo” di Jane Eyre, e infine per il target giovane a cui il romanzo è dedicato.
Di Edward in realtà avevano scritto entrambe ma a tirare per bene le fila ci pensa infine Sarah Shoemaker, americana dell’Illinois, costruendo una narrazione parallela volta a gettar luce, almeno un pochetto, sulla figura maschile per eccellenza della romance fiction britannica. Uno scorcio di notevole interesse storico su ambienti, società e psicologia dell’epoca: dalle industrie tessili della fumosa e poverissima periferia londinese al crescendo delle lotte operaie, dai rapporti non sempre pacifici tra élite aristocratiche ed emergente classe mercantile fino all’esotica Giamaica, in un turbine di colori e sentimenti. Avviene però solo a tratti e mai del tutto (come è giusto che sia) la rivalutazione dell’operato di Mr. Rochester, che da tempo è necessaria – sia perché Charlotte Bronte è sempre stata davvero parca di dettagli, sicché di fatto ne abbiamo saputo sempre ben poco, dei trascorsi di Mr. Rochester, sia perché questo personaggio così come mostrato dalla Bronte rischia col tempo di perdere quel fascino poliedrico che indubbiamente possedeva nella testa della sua creatrice, sacrificato sull’altare dello stereotipo vittoriano nel quale talvolta Charlotte indulge.
Già. Perché su tutto e dentro a tutti, come ha fatto ben capire nel 2011 Cary Fukunaga, con quelle inquadrature a campo lungo che rimarranno iconiche e definitive, dominerà sempre – e incontrastata – la brughiera: coi suoi autunni precoci e meravigliosamente colorati, i tramonti d’oro, le eriche piegate dal vento, le candele alla finestra, le serate buie e interminabili, gli spifferi da sotto le porte, le stanze segrete di Thornfield.
“Arrivate al vespro, come un sogno o come un’ombra” (Kindle, pos5624)
Buona lettura e buon autunno 🙂
(*) Per la lettura di “Lux” ringrazio l’amico @LukeAlb: ero scettica, mi ha convinto lui – e menomale.