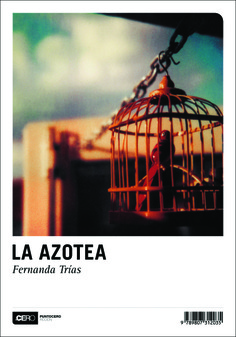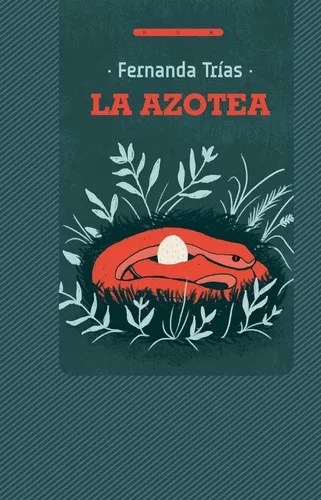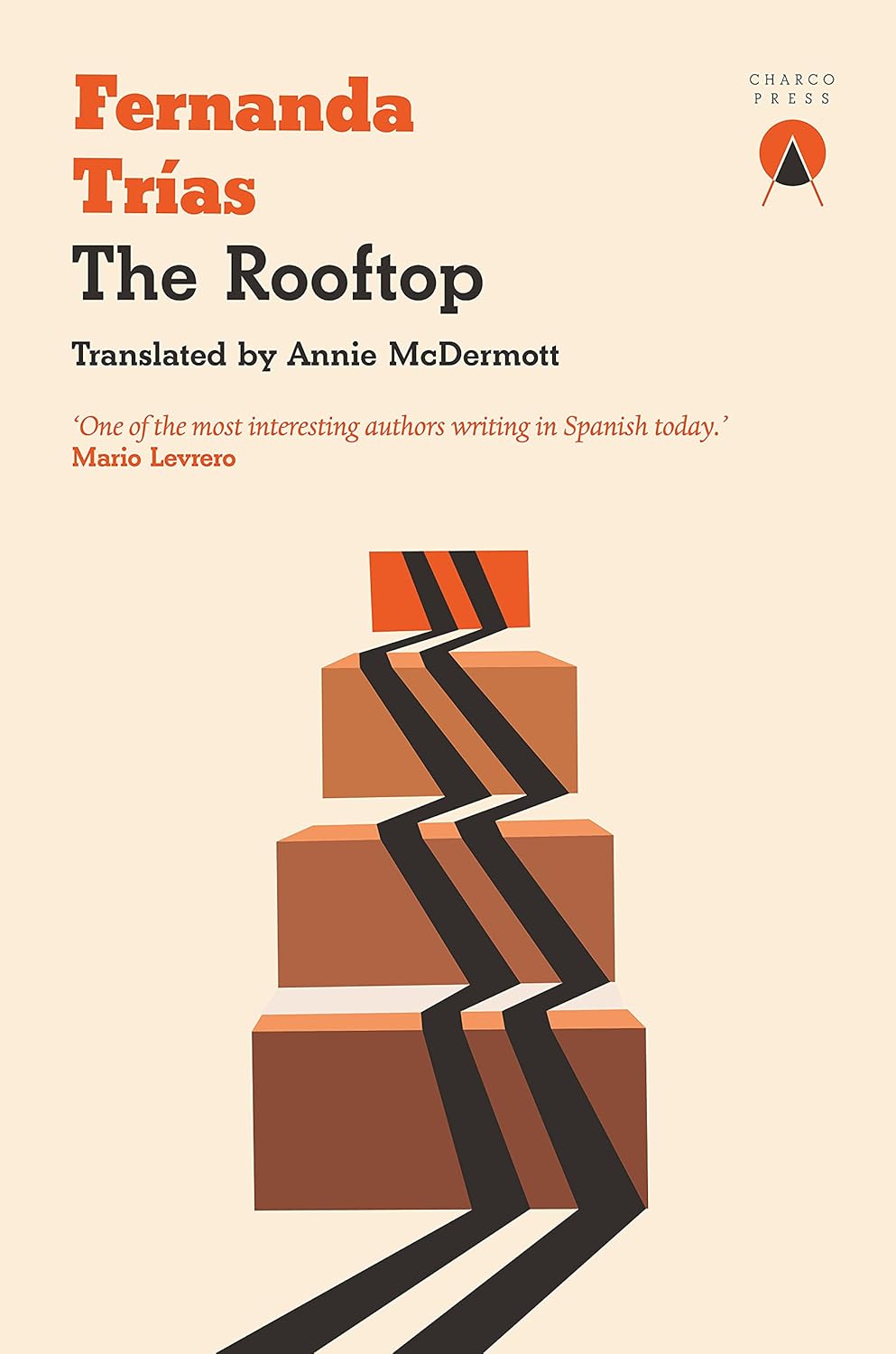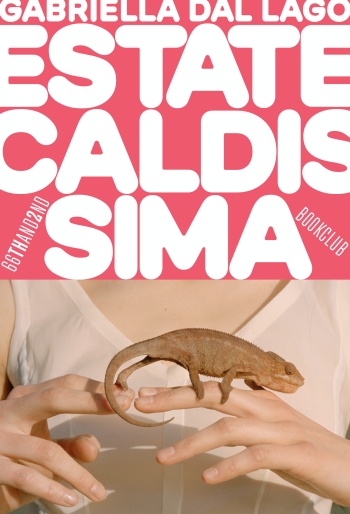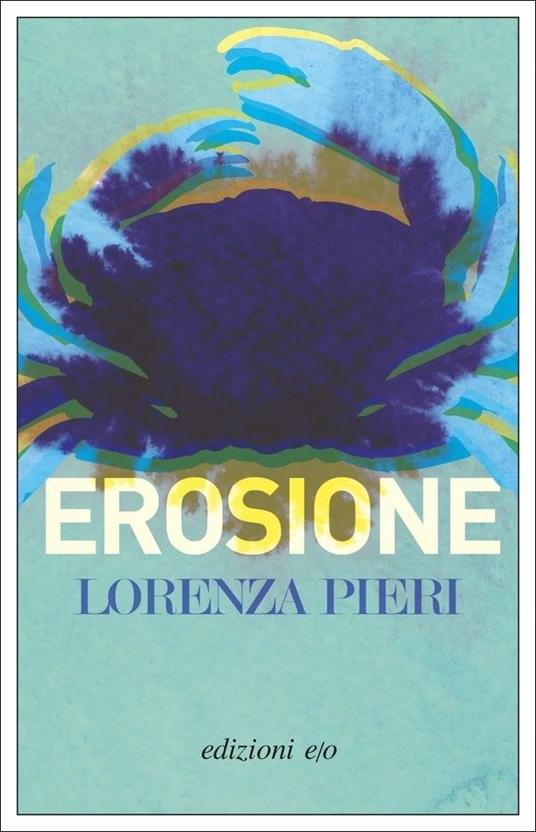Nel 2022, Claire Keegan dona al suo editore parigino il racconto “So Late in the Day“, apparso sulle pagine del New Yorker alcuni mesi prima. A tradurlo per la lingua francese è Jacqueline Odin e Sabine Wespieser éditeur, che con questa e altre pubblicazioni celebra i propri vent’anni di attività, lo intitola “Misoginye“.
L’intestazione deriva da un passo della storia offerta in dono, frammento in cui si assiste a uno scontro verbale fra una giovane donna – franco-britannica residente a Dublino per lavoro – e il findanzato irlandese, proprio riguardo ad argomenti di maschilismo e, potremmo dire, di interiorizzazione del patriarcato. [Anticipazione: la discussione accade a pochi giorni dal matrimonio e la celebrazione alla fine non avverrà, come si evince sin dalle prime righe del racconto, ma la motivazione non è strettamente connessa al diverbio di cui sopra, che risulta piuttosto esplicitazione di non-detti].
Nella versione originale di Keegan la scelta del titolo appare all’apparenza più sfumata – ma anche più provocatoria e meno scontata rispetto a quella della casa editrice. In “Quando ormai era troppo tardi” (nota: per mano di Einaudi una modifica di non poco conto, anche – ma di significato altro) la scrittrice irlandese difatti racconta non tanto le dinamiche patriarcali quanto il cosa accade all’interno di una coppia pervasa da una specie di sottesa e inespressa tension cruelle, prendendo come punto di vista quello del protagonista maschile. SW éditeur ribalta invece il punto d’osservazione, consegnandolo al giudizio di una parte del tutto femminile.
Anche tanto Internet di lettori e lettrici dichiara necessaria una presa di posizione netta, che vede nel dualismo oppositivo maschio-femmina, carnefice-vittima, il nucleo della rappresentazione, senza all’apparenza curarsi della questione del punto di vista, che invece Keegan definisce con atto programmatico fin dal titolo: il so late in the day, infatti, si riferisce sia al contesto agito – il viaggio di ritorno dall’ufficio che l’uomo intraprende nel giorno in cui invece avrebbe dovuto sposarsi – sia alle riflessioni del protagonista riguardo a delle supposte mancanze nei confronti dell’ex-fidanzata, sia anche all’irrevocabile decisione della donna di lasciare il compagno (ecco la focalizzazione di Einaudi, che nel taglio secco del riferimento alla giornata particolare decide di tagliar via tutta la parte allacciata allo spazio-tempo di cui sopra).
Offrono riscontro a questo sistema di pensiero, mi pare, due punti interni al testo, a dire fondamentali – di struttura e di argomenti, che prendono forma nell’edizione 2023, in cui la casa editrice Grove Press NY unisce il sopracitato pezzo ad altre due narrazioni brevi: “The Long and Painful Death”, del 2007, e “Antarctica”, uscito nel 1999. Il primo punto è che i testi si trovano sistemati alla rovescia cronologica, con il più recente “So late in the day” in apertura a far da specchio all’ultimo, “Antarctica”; il secondo punto è che il titolo dalla raccolta – in inglese originale – rende l’idea di una rinuncia di fondo a qualsiasi tentativo di confronto, mediazione, finanche riparazione.
Nel mezzo di questo trittico dell’amore maligno il posto centrale è occupato da “The Long and Painful Death”. “Una morte lenta e dolorosa” – che, va detto, potrebbe benissimo vivere da sé, al di là della contestualizzazione temporale (questione invece piuttosto importante per il terzo racconto) – è dedicato a quella ben specifica repulsione per le donne che da sempre alberga all’interno di certi ambienti letterari. Se in “So Late in the Day” Sabine si libera dal fidanzato oppressore lasciandolo appena prima delle nozze, ecco in “The Long and Painful Death” una giovane e talentuosa scrittrice ospite di una residenza per artisti che cerca di evitare l’ira di un collega anziano tramite la blandizie della cucina, in un crescendo di suspense e angoscia per quella visita imprevista che potrebbe trasformarsi in una brutta avventura della stanza chiusa, (questo dei tre è per me il pezzo più raffinato, nel recupero del gesto tutto femminile e antico del nutrire, come al piegare la materia del materno, manipolarla a forza rientrandola nel solco da dove in qualche modo era stata in grado di rigurgitare fuori); infine in “Antartica”, il terzo racconto, il più antico dei tre, una donna-felicemente-sposata resta vittima di stupro, nel suo desiderio di emancipazione e trasgressione. Quindi, a considerare questa raccolta come un banale manifesto di lotta al patriarcato le si farebbe, ho idea, un torto.
“E poi, giusto giusto un mese prima, era arrivato il furgone del trasloco con tutte le sue cose: una scrivania e una sedia, una libreria, scatoloni di libri e dvd, cd, due valigie piene di vestiti, una grossa riproduzione di un quadro di Matisse con un gatto che infilava la zampa in una vasca di pesci rossi e delle foto incorniciate di persone a lui sconosciute che lei aveva sistemato e appeso qua e là, spostando altre cose, come se la casa adesso fosse anche sua. Una buona parte dei libri era in francese, e lei aveva un aspetto diverso col viso struccato, mentre si aggirava in tuta, sudando e sollevando questo e quello, costringendolo a sollevare e spostare le sue cose, spingendo i mobili, con la faccia tesa per lo sforzo. E c’erano pentole e padelle, un tappetino da yoga, gonne e camicette, grucce di legno, un filtro per l’acqua, scatole di tè, un macinino da caffè.”(*)
” – Credi che i soldi mi escano dalle orecchie? – aveva detto lui, e subito aveva sentito l’ombra lunga del linguaggio di suo padre passare sopra la sua vita, in quella che avrebbe dovuto essere una bella giornata, se non una delle più felici.”
Cathal, il protagonista di “So late in the day”, è in concreto un omino un poco gretto, figlio anche inconsapevole di una certa Irlanda di paese, taccagna e retrograda, ma la compagna Sabine di contro non sembra brillare, né per intraprendenza né per sentimento. Quasi trascinata dagli eventi (alla proposta di matrimonio risponde con quella che appare una vaga noncuranza e passano settimane prima di un tiepido convincimento), si rende soggetto attivo unicamente all’interno di una specie di dinamica del trasbordo, nel rovesciare in casa del compagno vita e pensieri al di là, sembrerebbe suggerirci Keegan, di una contezza d’intento, per quello che significhi traghettare se stessi dal singolo quotidiano a una dimensione doppia, strutturata nel progetto.
” (…) e si era alzata, decisa a svuotare l’ultimo scatolone, e aveva spinto il rasoio e il dentifricio di Cathal da parte sulla piccola mensola di vetro nel bagno che si apriva sulla camera, per far posto alle sue cose. E c’erano anche creme, balsamo per capelli, contraccettivi e una busta piena di cosmetici, scatole di tamponi.”
Sono convinta dell’intento di Keegan: far risuonare nelle orecchie del lettore quel lieve tintinnio di bottigliette da bagno. Come non si sia notato questo gesto di mano spessa, del riempire casa d’altri, mi resta un mistero – impossibile sia stato casuale, per via dello spazio fisico, di numero delle righe intendo, che occupa nella dimensione strutturale del racconto. La verità è che dobbiamo fare i conti con l’ipotesi che Keegan con “So late in the day” abbia voluto a bella posta rendere nullo il dualismo della colpa nei sessi. Il “voi” al maschile collettivo che Sabine utilizza nella reprimenda al compagno in questo senso appare più un adesivo appiccicato a sottolineare l’artificioso di certe affermazioni che una reale e concreta presa di posizione intima, sociale e politica. Come a domandarci dove possa davvero arrivare il femminismo, se poi nel pratico si risolve in un allargarsi di spazio col deodorante su una mensola da bagno. Così come sono precisamente sicura che in “Antartica” quelle righe – chi legge con me ha portato in regalo un aggettivo primario: di evento “esiziale” – siano da Keegan state sistemate lì per contezza, a ricordarci, ancora e ancora, di questo fatto così dololoso e tagliente del momento in cui si sceglie:
“Lei non era in vena di fare sesso. Nella sua mente se ne era già andata, era già davanti a suo marito alla stazione. Si sentiva pulita, sazia, al caldo; tutto quello che desiderava adesso era una bella dormitina in treno. Ma alla fine non riuscì a trovare un motivo per non andare, e cedette come se fosse un regalo di addio. Disse di sì.”
/ Claire Keegan, “Quando ormai era tardi”, traduzione di Monica Pareschi, Torino 2024 / ricevuto in regalo – unospazio
(*) in originale: “And then, this time last month, the moving van had arrived with all her things: boxes of books and DVDs, CDs, a table and chairs, two suitcases filled with clothes, a large Matisse print of a cat with its paw in a fish tank, and framed photographs of people he did not know, which she placed and hung about the house, pushing things aside, as though the house now belonged to her, too. A good half of her books were in French, and she looked different without her makeup, going around in a tracksuit, sweating and lifting things and making him lift and move his own things, rearranging furniture, the strain showing so clearly on her face. And there were pans and a wok, a yoga mat, skirts and blouses, wooden hangers, a water filter, cannisters of tea, a coffee grinder, lamps.“