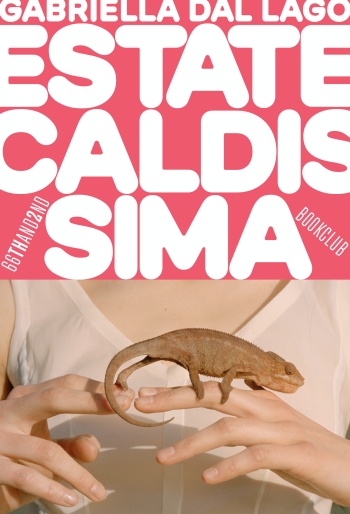
La particolarità di “Estate caldissima” è che ognuno riesce a recuperare da queste pagine l’aspetto che più insiste nell’esperienza individuale. Dalla soddisfazione di una curiosità socio-antropologica fino all’attivazione di un personale triggering point (nel linguaggio nuovo: tutto ciò che, in senso esteso, è in grado di innescare una reazione emozionale non positiva), la struttura dell’enigma a stanza chiusa aiuta nella rappresentazione di una scena teatrale fissa: ciascuno dei personaggi interpreta un sé che finisce per diventare superficie riflettente rispetto alla platea dei lettori, pubblico in sala in qualità di individuo singolo e di entità collettiva.
L’approccio non è nuovo: da Boccaccio all’Isola dei famosi, dal noir di Poe alla speculative fiction di Ballard, la formula è quella della cornice narrativa all’interno della quale un gruppo di persone, ciascuna con proprie caratteristiche e idiosincrasie, viene osservato durante lo svolgersi di una situazione imprevista. Il romanzo breve “Estate caldissima” costruisce la propria impalcatura su questo canovaccio: figuranti posizionati all’interno di un presepe, per affrontare un’emergenza che, in questo caso, si vuole esterna.
Nove le statuine: Gian, quartacinquenne capobranco, capelli lunghi e brizzolati agghindati a cipolla, e i sei colleghi che compongono il team Bombagency – la trentenne Greta, compagna di Gian e socia fondatrice dell’agenzia pubblicitaria; Laura, bella e atletica art director; i due social media specialist Tommi lo svagato e la gigantessa Alma; in coda gli account Vic e Carlo: lei emo-“cyberspazio” ventenne neoassunta, lui disperato cocainomane. Chiudono l’armata il piccolo Leo, otto anni, figlio di Gian, e Lily, la gatta di Greta. Come luogo d’elezione (“location“), l’elegante ma sobrio cascinale-ristrutturato-con-piscina, di proprietà della famiglia di Gian, perso nell’arsura di una campagna estiva, potremmo pensare al piacentino o alla collina toscana. L’emergenza: un progetto da consegnare a un cliente di alto livello, durante un’estate post-pandemica che si preannuncia rovente, apocalittica. Una necessità di brainstorming che però nasconde e rivela allo stesso tempo l’urgenza di una fuga escapista alla quale ciascuno dei protagonisti, per proprio interesse (ed è qui che si incarna l’immedesimazione), ha motivo di guardare con favore.
“Estate caldissima” quindi come racconto generazionale, perché descrive con precisione la vita liquida della generazione Millennials, quel professionale che continuamente si sovrappone all’intimo in una caratterizzante commistione di fuori e dentro in un luogo del mestiere – tipicamente nel terzo settore creativo – che si mescola, agile e fluido, al momento del privato. Recensioni e approfondimenti on line si sono concentrati proprio sugli aspetti dell’ambito professionale: il linguaggio specifico, i titoli, le professioni, la maniera di vestire, gli oggetti, le attività, tutto è parte di un modo di percepire il reale che in certi momenti diventa altro rispetto al reale stesso, con le immancabili questioni che vediamo descritte anche in altri contesti di fiction e saggistica: precarietà come stile di vita, perdita di contatto con le famiglie d’origine, difficoltà nelle relazioni di coppia, attivismi che scivolano nell’ossessione, controllo sul corpo e sulla mente al limite del fanatismo – insomma come si vede ce n’è per tutti.
“…un sorriso che sembra una presa in giro ma che Alma legge come un’alleanza, la sicurezza che tra loro c’è qualcosa, un patto, una sintonia – e questo è il problema di leggere nei gesti degli altri quello che noi vogliamo leggere, e in definitiva questo è il problema di amare male”.
Un punto che tuttavia differenzia “Estate caldissima” da altri racconti simili è la presenza costante del motivo della necessità di interpretazione, per via dell’esistenza di uno scarto fra il reale e il pensato. L’autrice utilizza perfino il verbo “sovrascrivere” in relazione al meccanismo di sovrapposizione fra la persona reale e quella immaginata, identificando questa visuale come una delle criticità generazionali: l’ondeggiare fra la necessità di rivelarsi (io sono così e fattelo bastare, non cambierò) e quella inconscia, si potrebbe dire fisiologica e ancestrale, di tutelare i propri spazi di vita personale e pensiero. La paura di impegnarsi in una strada di scoperta dell’altro è parte fondamentale del sistema che governa l’incontro e che, di fatto, ne determina il fallimento. Questo è un punto importante, che spinge l’analisi sui Millennials di “Estate caldissima” un po’ più avanti, raffinandone l’osservazione perché si lega non solo a una lettura del reale non stereotipata – figurine da presepe, non caricature – ma anche al rapporto dei protagonisti con un tema che fino a ora era stato analizzato solo di sfuggita: quello del diventare adulti, con particolare riguardo alla genitorialità.
“Leo è abituato a interagire con persone molto più grandi di lui, perché da figlio di separati che hanno l’ansia di dimostrarsi reciprocamente di essere in grado di badare a lui senza ricorrere in misura eccessiva a genitori, baby-sitter o aiutanti di vario genere, ha passato gran parte della sua vita immerso nei contesti amicali dei propri genitori, trascinato a cene di compleanno, pranzi di lavoro, feste aziendali e sì, ora anche a ritiri creativi come questo.”
Poco analizzato perché erroneamente interpretato, verrebbe da dire, da molti ma non da Gabriella Dal Lago che ne coglie il nodo centrale: genitorialità legata non tanto e non per forza alla riflessione sul materno quanto a un approccio complessivo nei riguardi del mondo adulto, all’interno del quale la caratteristica fondamentale dovrebbe essere un atteggiamento di cura sociale, collettiva.
Per paradosso e per provocazione queste riflessioni sono consegnate a Leo. Il cui padre, a esser chiari, non brilla per competenza. Il fatto che sia divorziato non è dirimente nella misura in cui il romanzo non possiede intento moraleggiante ma ci interessa, ancora una volta, per la questione dei figuranti. Gian, maschio adulto di quarantacinque anni – professore universitario e amministratore di una realtà consolidata che si presenta e viene conosciuto unicamente tramite nomignolo – si impegna certamente nel ruolo genitoriale ma allo sforzo, dichiaratamente titanico e sottomesso a interi Eoni di iperboliche seghe mentali, corrisponde invero il parto di un topolino. Non sono migliori, nella gestione dell’età adulta, né le performance di Greta che ovviamente con Leo ha un rapporto complicato (per anagrafe potrebbe eventualmente corrispondere al ruolo di sorella o giovane zia: di sicuro non matrigna) né quelle degli altri membri del gruppo all’interno del quale nessuno a parte forse Tommi, che difatti nel finale del libro è l’unico a essere rappresentato in un modo ben preciso, rivela la benché minima capacità o voglia di interazione col ragazzino.
Come registra il bambino stesso, nel corso di alcuni capitoli a lui dedicati tramite punto di vista interno, Leo risulta non tanto in-curato quanto piuttosto abbandonato a sé stesso nell’uso e nella percezione della realtà che lo circonda; non visto (proprio uno dei suoi giochi preferiti: il ragazzino invisibile) il bambino assiste, privo di quella protezione comunitaria che invece dovrebbe essere riservata all’infanzia, al teatro della vita adulta senza filtri e, ancora peggio, senza che gli vengano forniti strumenti per localizzarne in senso: litigate di coppia, promiscuità, consumo di alcol e stupefacenti, fisime e scenate, workaholism, ritmi di sonno/veglia alterati, routine inadatta alle esigenze di un bambino; niente di ciò gli è precluso, in un senso di estraneità, disallineamento di percezione col reale e solitudine che si acuisce col procedere della narrazione. La tensione narrativa sulla figura di Leo è palpabile e nel lettore inevitabilmente nasce il sospetto che gli elementi “bambino di otto anni + giochiamo a essere invisibili + piscina incustodita” potrebbero non andare proprio così d’accordo fra loro.
Ciò che fa specie è l’incapacità del gruppo di uno sguardo di comunità; il che, come si è detto, non implica per forza la riflessione sulla maternità quanto l’esperienza del senso di famiglia: nello sguardo che percepisce la presenza di un bambino e nella consapevolezza della propria posizione di adulti ecco dovrebbe identificarsi lì, la capacità di mettere da parte sé stessi, se valutato necessario. Cosa che invece non accade poiché tutti e sette i protagonisti adulti sono concentrati unicamente sull’analisi e sulla risoluzione dei propri psicodrammi esistenziali.
Questo punto, della mancanza di cura (o di consapevolezza, o di contatto con il reale, la si metta come si preferisce), si rivela anche nell’allusione allo scenario distopico all’interno del quale ruota la vicenda. A un periodo di gravissima siccità seguiranno anni di inondazioni e marcescenze: con buona pace di Amitav Ghosh, che ormai parla da pagine antiche (“La grande cecità” è del 2017 e non sta invecchiando benissimo), la scelta di ambientare “Estate caldissima” a cavallo fra il reale del post- pandemico e una catastrofe climatica globale di sapore distopico – sebbene molto realistica – apre lo sguardo al tema del motivo-clima all’interno della narrativa italiana di fiction contemporanea, creando un buon precedente con cui le narrazioni successive dovranno per forza confrontarsi. Il tutto si incarna grottescamente, però, nella figura di Greta, (nomen omen) che si autodefinisce attivista ambientale ma che appare di fatto più vicina a un’invasata fuori controllo, con le sue crisi isteriche alle due di notte per una confezione di insalata in busta trovata in frigorifero, che a un’adulta consapevole di certe dinamiche, pronta a condividere le proprie conoscenze e consapevolezze con la comunità o con i più giovani (di lei).
“Ogni tanto si trovava a provare una cocente invidia per la conflittualità tra genitori e figlie che vedeva raccontata da film, serie TV, saggi, come se l’accondiscendenza e la comprensione estrema dei suoi genitori l’avessero privata di un passaggio cruciale, fondativo della sua identità come essere umano: la lotta.”
Gabriella Dal Lago non fa molti sconti alla generazione che dipinge. Ogni personaggio in scena incarna uno dei tanti punti di cui si parla spesso quando si parla dei trenta-quarantenni e di quando essi stessi si raccontano. Sembra, ci dice l’autrice, che il tutto si possa definire come una discrepanza fra ciò che si sente (a cui viene dato il credito dell’assoluto) e quello che è. Sarebbe troppo facile associare questo modo di interpretare il reale alla maniera in cui dai social pensiamo di dedurre la vita personale dei nostri following. È più che altro, invece, un difetto di lettura, un inciampo per qualcosa andato storto dove, chi lo sa – forse durante l’apprendimento scolastico, in famiglia, nelle amicizie (il tema dell’amicizia ricorre spesso), forse negli studi (altro tema ricorrente: università come buco nero di nozionismi iper-strutturati, determinati da una feroce corsa a chi arriva prima, legami sociali e dibattito contraddittorio ridotti al minimo).
Cosa succede alla fine? Sta qui l’equilibrio di queste pagine: chi lo dice, che debba per forza capitare qualcosa di drammatico per scuoterci, nei libri che leggiamo? Cos’è il fascino che abbiamo, per il contenuto, per l’inizio e la fine, per la conclusione che ci si aspetta: pure questa attesa del qualcosa, ci racconta l’autrice, non è che parte del problema.