
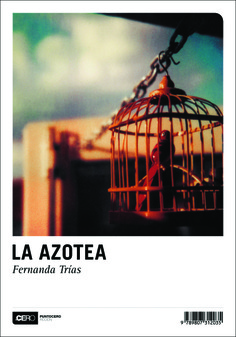


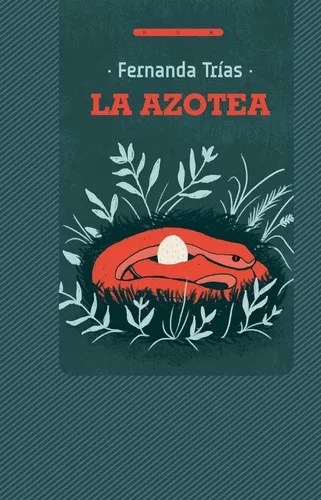


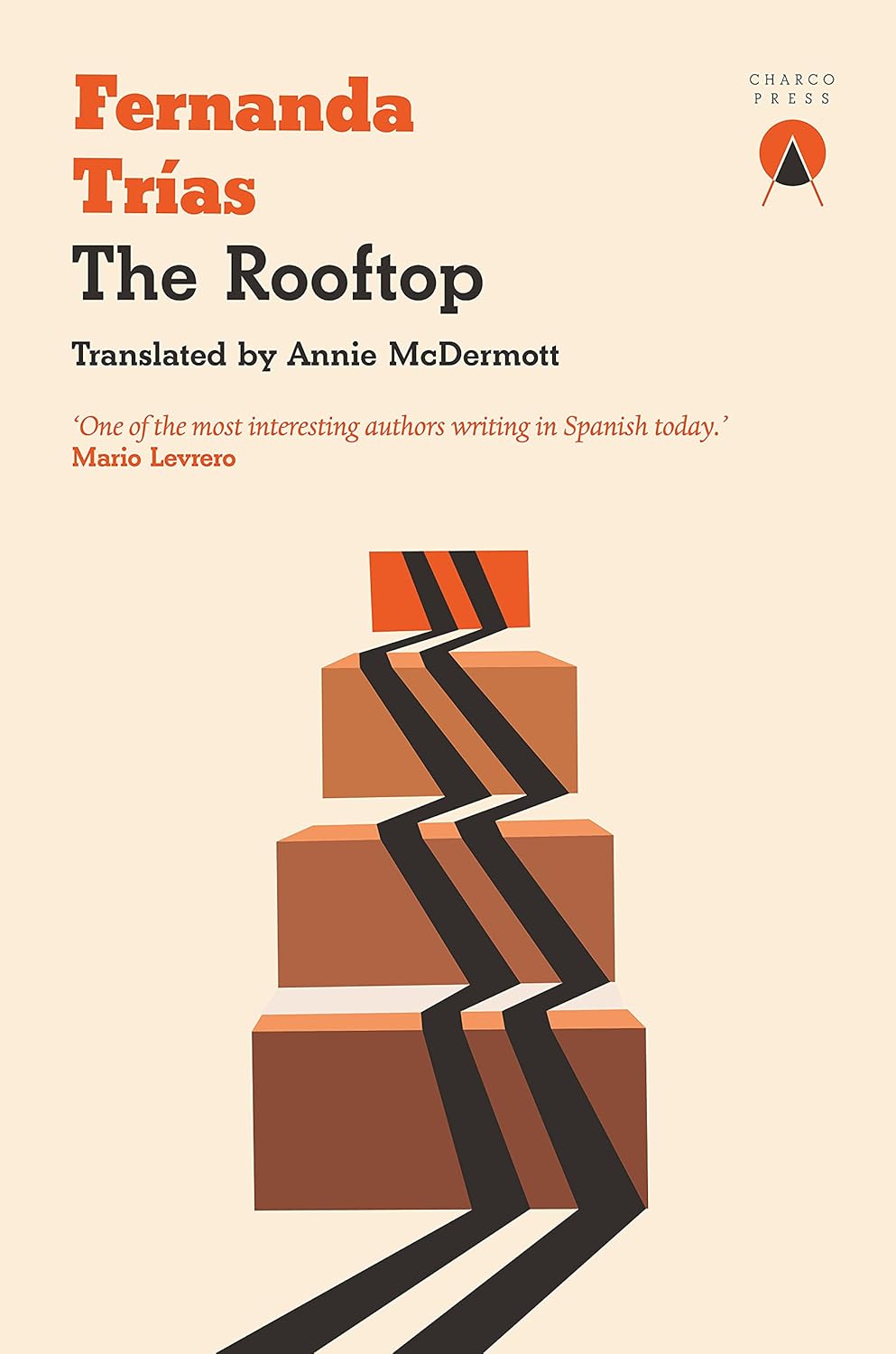
Nella sua lingua, Fernanda Trìas (Montevideo, 1976) racconta di un terrazzo – La azotea appunto – unico punto di contatto con la realtà del mondo esterno per Clara, una giovane donna che vive rinchiusa in casa insieme al padre, alla figlioletta Flor e a un canarino. Alle finestre dell’appartamento, un caseggiato popolare che tuttavia per alcuni tratti sembra piuttosto conservare le vestigia di un lusso decaduto, Clara ha applicato dei drappi, lo spioncino della porta reso cieco da un pezzo di carta assorbente, la porta legata con giri di chiavistelli; sullo stoino la spesa è lasciata da una donna straniera, badante e mammana, pagata per questi servizi, le medicine vengono consegnate da un trafficante prezzolato. A nessuno è dato sapere del perché di questa che pare una scelta. Mentre il genitore è allettato e si consuma inerme dentro una malattia non meglio precisata e la bambina – nata in casa e mai uscita dal perimetro domestico – conserva il segreto di una paternità forse proibita, la giovane donna, licenziatasi dal lavoro, impiega il tempo delle proprie giornate nell’accudimento, in un delirio crescente e ossessivo di onnipotenza e autodistruzione.
“Credo che Julia si sentisse protetta all’ombra di quel muro. Non andava mai a messa la domenica, le piaceva stare in chiesa da sola e preferiva andarci all’ora della siesta, quando tutti si dimenticano dei santi. Si sedeva sui banchi in fondo e guardava nel vuoto; immagino fosse in attesa che succedesse qualcosa di speciale. Il suo era un avvicinamento fisico: stare il più vicino possibile alla schiena di Dio. Forse pensava che accanto a quel muro non le sarebbe successo niente di brutto. Però si sbagliava. A volte l’accompagnavo. Gattonavo sotto i banchi finché la calzamaglia diventava tutta nera e si bucava sulle ginocchia. Mi piaceva l’odore di vernice fresca, soprattutto se potevo staccarne delle palline indurite e succhiarle come una caramella. Julia pregava e guardava davanti a sé. Che strana l’aria delle chiese. Densa, appiccicosa, colma di presenze.”
Con il trascorrere dei giorni, dei mesi, finanche degli anni, tutto si incrina: i risparmi messi da parte vengono a esaurirsi, l’amministratore di condominio per via delle spese insolute taglia le fonti di approvvigionamento in un susseguirsi cadenzato e ineluttabile: gas, luce, acqua; le stagioni si avvicendano l’una sull’altra, feroci (e rovesciate, siamo nell’emisfero australe), i quattro abitanti della casa come a rimpicciolirsi rispetto non solo alla parte del fuori ma anche alle necessità, ridotte all’essenziale – vestirsi come si può, lavarsi quando si riesce, nutrirsi con ciò che si recupera, parlare nel silenzio – nella parte del dentro di un’abitazione le cui mura si stringono attorno ai quattro corpi ancora vivi, una stanza chiusa dopo l’altra, porte sprangate a proteggere dal freddo tremendo o dal caldo insostenibile, polvere sotto i letti, il buio della notte abitato da candele e fantasmi e dalle risate di una bambina molto piccola che – con i capelli agghindati a trecce sopra una crosta lattea persistente, che nessun medico ha mai avuto modo di esaminare – balla nelle macchie di luce di quei piccoli fuochi fatui. Unica aderenza con l’ambiente esterno è per Clara la notte, durante la quale la donna sgattaiola fuori dall’appartamento; infagottata nei maglioni smessi della matrigna, sotto i quali non porta biancheria, Clara sale le scale del palazzo, descritte come labirintiche, paurose e insondabili – luogo di poliziotti corrotti, puttane e travestiti, vecchie inacidite e delatrici, complotti di Stato per rapire la figlia -, fino ad arrivare al terrazzo e a ciò che questo spazio vuoto e pericolante, sferzato dal vento gelido o bruciato dalla canicola, vuole significare, nella percezione di Clara e nel senso del romanzo.
Racconto d’atmosfera, horror, romanzo d’introspezione psicologica, analisi sociale, scrittura sul dramma psichico – stupiscono i 23 anni dell’autrice uruguaiana al momento della stesura. Precedente a Melma rosa, ne contiene già quasi tutti i temi, come in embrione ma già definiti nelle cellule che li comporranno: il mistero della triplice essenza: figlia, moglie e madre; la tempesta emotiva della maternità; il ruolo del maschile, l’eredità dei padri; e ancora: indifferenza sociale, crisi economica, degrado urbano. Melma rosa in questo senso non costituisce un prosieguo e nemmeno una ripetizione, quanto più il concretizzarsi di questi temi all’interno di un recipiente diverso, ricerca tematica e stilistica che si affina, in specie nella caratterizzazione dei personaggi e nella precisissima indeterminatezza del contesto, a trovare nuove strade – il distopico nel caso di Melma rosa – per esprimersi al meglio.
“Da un’estate all’altra la casa all’angolo si trasformava. Non erano grandi cambiamenti e agli occhi di un’altra persona sarebbe parsa una semplice casa abbandonata, ma per me era diventato l’unico concetto comprensibile di cosa significasse invecchiare. Pensavo che un giorno sarei tornata e non avrei trovato più nulla. Non perché l’avessero demolita, ma perché si era disintegrata da sola e di lei non restava altro che un mucchietto di calce in mezzo alle erbacce del prato. Quando chiesi a papà perché non ci vivesse nessuno, mi rispose che la casa era così vecchia che ormai non ci si poteva fare più niente.”
Nelle righe scritte da Trìas non esiste menzione di una vita di prima di questa o per lo meno quella vita precedente, sicuramente esistita, rimane nell’ombra, solo accennata – una professione d’ufficio per Clara, la passione del padre per le passeggiate al mare, le vacanze in famiglia, la morte improvvisa dell’insopportabile matrigna Julia, per un incidente di cui non si rivelerà dettaglio – e non viene mai a rappresentare la parte focale dello scritto. A peccar di precisione occorre definire La azotea come un lungo flashback, all’interno del quale Clara – sdraiata a letto, nell’ultima notte che presumibilmente trascorrerà con il padre e la figlia, per via dell’intervento dei servizi sociali – rievoca dall’inizio il processo di hikikomori; questo strumento stilistico tuttavia non pare atto a recuperare il dettaglio sul prima quanto, dicendo banale, a creare e a mantenere attiva la tensione narrativa. Annie McDermott nella traduzione inglese mantiene il titolo originale e anche le copertine delle varie edizioni in spagnolo (la prima uscita risale al 2018) recuperano più o meno tutte, con qualche differenza attribuibile a variabili di spazio e di tempo (e di gusto), i fondativi tematici del testo.